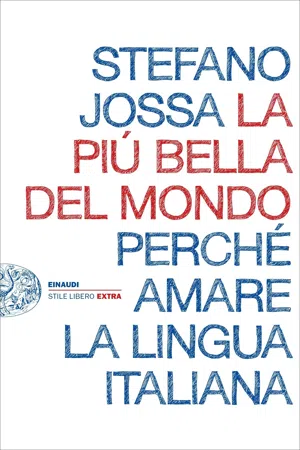Se c’è un punto di partenza per considerare la lingua italiana «la piú bella del mondo», questo punto di partenza è certamente la sua letteratura. La bellezza di una lingua sta nella sua storia, nei suoi usi, nelle sue possibilità e nelle sue sbavature: nell’insieme delle sue caratteristiche attraverso il tempo e lo spazio. Ritenere che sia la piú bella perché è la piú musicale, o la piú dolce, o la piú intima, non vuol dire niente, poiché si tratta di concetti evanescenti, senza alcuna base oggettiva e condivisa. Ma identificare la bellezza con delle caratteristiche che nella storia si sono espresse significa dare la possibilità della scelta: e cos’è piú bello di ciò che si sceglie?
La lingua italiana è prima di tutto una lingua letteraria. Lo è non solo perché è stata costruita quasi a tavolino nel corso del tempo da tre grandi uomini di lettere, Dante Alighieri, Pietro Bembo e Alessandro Manzoni, che in momenti diversi si fecero carico di pensare una lingua nazionale per gli italiani (anche quando di nazione e italiani non si parlava ancora), ma soprattutto perché di letteratura si è nutrita fino ai giorni nostri, al punto che a scuola la lingua s’insegna ancora a partire dalla letteratura (anziché, ad esempio, dai film o dalle canzoni). Letteraria, la lingua italiana lo è anche per un’altra ragione: fin da bambini gli italiani imparano a condividere una lingua che è fatta di storia, delle formule e delle varietà che in quella storia si sono depositate, delle soluzioni espressive e formali che quella storia ci ha tramandato. A scuola abbiamo sperimentato per la prima volta quella lingua che abbiamo poi usato nella nostra vita sociale: se è vero che il primo apprendimento avviene per lo piú in famiglia e attraverso i media, è indubitabile che la consapevolezza della lingua come lingua comune, e politica, e nazionale, nasce lí, tra i banchi di scuola.
Invitando il suo «lettore ideale» a studiare l’italiano in conclusione di quello che forse è il primo della serie dei libri sulla bellezza della nostra lingua, L’idioma gentile del 1905, Edmondo De Amicis non esitava a presentare il suo percorso linguistico come un itinerario letterario: «Fu come un viaggio di vari anni per il mio paese e a traverso la sua letteratura, dove quasi ad ogni parola mi s’alzava davanti la reminiscenza d’una lettura, la visione d’un fatto, il fantasma d’uno scrittore».
Tullio De Mauro ha piú di recente dimostrato che delle circa 4500 parole piú frequenti nell’uso quotidiano dei parlanti dell’italiano (il lessico «fondamentale» o «di alta frequenza») quasi il novanta per cento è di provenienza letteraria e discende dagli autori del Trecento. Nell’Italia di oggi, a seguito della legge sull’autonomia scolastica, i programmi della scuola elementare (che ora si chiama primaria) non esistono piú, ma le linee-guida ministeriali per quanto riguarda l’insegnamento della lingua insistono sull’importanza della lettura, cioè del testo scritto, e sull’avviamento alla poesia, cioè l’espressione formalizzata della lingua: ai bambini si chiede fin dall’inizio di interagire con la dimensione letteraria della lingua, che è appunto dove risiede la sua bellezza.
Questo capitolo sarà perciò dedicato a una breve storia dei momenti fondanti della lingua che chiamiamo italiana, con l’obiettivo di dimostrare che questa lingua è prima di tutto una lingua «d’invenzione»: inventata, ma anche e soprattutto finalizzata all’invenzione, alla creatività linguistica e al gioco verbale. Contro i tecnicismi che oggi dominano il discorso linguistico, del tipo «si può o non si può dire», oppure le mode come l’italiano della radio, l’italiano della canzone, l’italiano delle arti e della musica, il primo modo per entrare in contatto con la bellezza di una lingua sarà proprio quello di conoscerne la storia, l’origine e gli sviluppi.
Una lingua per inventare il mondo.
Nel Medioevo si riteneva che la bocca della pantera, dopo aver sbranato il suo pasto, emanasse un profumo dolcissimo e fortissimo. I cacciatori ne erano attratti e si mettevano all’inseguimento della belva, ma non riuscivano a trovarla, perché era abilissima a fuggire. La pantera era dunque il simbolo di un impossibile (adynaton, secondo la retorica), l’oggetto del desiderio sempre anelato e sempre introvabile.
Questa era la situazione della lingua italiana quando Dante cominciava a scrivere: un sogno o una chimera, qualcosa di inseguito e irraggiungibile. La lingua in cui il poeta voleva scrivere non esisteva e gli toccava inventarsela: lo dice lui stesso nel De Vulgari Eloquentia (I 16), ammettendo che la lingua di cui sta andando alla ricerca è come il profumo della pantera. Per trovarla ci sarà bisogno di una costruzione razionale, cioè un ideale che si manifesta di quando in quando nella realtà, ma non si trova effettivamente in nessun luogo. La lingua proposta da Dante è perciò una lingua di valori anziché d’uso: corrisponde a un’astrazione teorica, come l’idea di buono, che non ha alcuna corrispondenza nella realtà umana, ma solo singoli individui che piú o meno le si avvicinano. Allo stesso modo la lingua italiana non esiste, ma ci sono parlate locali (i volgari, cioè le lingue del volgo, parlate dal popolo) che hanno un sentore d’italianità piú forte: la lingua di cui Dante sta andando alla ricerca è un principio, come l’uno tra i numeri e il bianco tra i colori, cui rapportare tutte le esperienze concrete del parlato.
Questa lingua dev’essere «illustre, cardinale, regale e curiale», continua Dante, perché è un modello cui ambire anziché una realtà in atto: illustre perché è segno di dottrina, fonte di potere e materia di prestigio; cardinale, perché è ciò intorno a cui ruotano gli altri volgari, cioè i vari dialetti; regale e curiale, perché sarebbe la lingua del palazzo e dell’assemblea, cioè della comunità politica. La lingua porta con sé il sapere, fornisce gli strumenti per cambiare l’animo umano e consente di distinguersi al di sopra degli altri; ha una funzione di misura, di classe e di socialità. Si tratta allora di una lingua letteraria, perché i volgari scritti si staccano dalle imperfezioni del parlato e possono ambire al sublime della poesia, come Dante ha già spiegato quando ha esaminato i vari volgari della penisola italiana, tra i quali solo il siciliano e il bolognese si salvano, proprio in virtú della loro qualità letteraria, cioè come lingue scritte invece che parlate. In questo modo Dante sancisce la separazione tra la lingua bella della letteratura e la lingua rozza dell’oralità, stabilendo un paradigma di lunga durata nella storia della cultura italiana: bella è la lingua che si stacca dal parlato anziché seguirlo, perché sa guardare piú in alto, appunto, in quella regione del bello che appartiene al regno delle idee e non alle comuni pratiche umane. Lingua di ragione, infine, cioè dell’intelligenza, perché è lí che risiede il principio politico della comunicazione, che fa dell’uomo l’unico essere capace di parlare: la lingua non servirà a scambiarsi beni e a definire relazioni, ma a dare agli italiani la possibilità di stare insieme, conoscersi meglio e conoscere di piú.
Mettendo in pratica la riflessione teorica nella scrittura poetica, Dante si sforzerà di realizzare una lingua caratterizzata dalla varietà prima che dalla comprensibilità. Non gli interessava dire le cose in sé e per sé, ma dire di piú della stretta corrispondenza tra parole e cose, dire le relazioni fra le cose. La lingua è perciò poesia, cioè esperienza creativa, dal greco poieîn, che vuol dire semplicemente «fare». Nell’incontro con Adamo nel cielo delle stelle fisse in Paradiso Dante non ha dubbi che parlare sia un’esperienza creativa: «Opera naturale è ch’uom favella; | ma cosí o cosí, natura lascia | poi fare a voi secondo che v’abbella» (Paradiso, XXVI 130-2), gli spiega colui cui la Bibbia attribuiva l’esperienza di essere stato il primo uomo a parlare. Che l’uomo parli è cosa naturale, ma il modo in cui parla la natura lo affida al gusto degli uomini, dice Adamo a Dante. Il nesso tra lingua («favella») e bellezza («abbella») è stabilito, e per di piú sancito dalla rima: la lingua è un piacere anziché la risposta a delle regole fissate prima di noi. Del resto Adamo la lingua, oltre ad averla usata, l’ha fatta: «l’idioma ch’usai e che fei» (114) è ciò di cui sta parlando, per spiegare a Dante che la lingua perfetta voluta da Dio è la facoltà di parlare che Dio ha donato all’uomo e non un sistema di regole grammaticali.
La lingua italiana nasce allora all’insegna dell’invenzione: non si tratta di usare le parole comuni, ma quelle piú belle, appunto. Unica tra le lingue occidentali moderne, l’italiano nasce come lingua poetica anziché lingua del commercio e del diritto. Ci sono, certo, attestazioni di usi del volgare non solo sul versante poetico ben prima di Dante, ma l’italiano come lingua dotata di una sua definizione nasce con Dante e nasce come lingua della poesia. Di qui discende il principio stilistico della Commedia, che è la varietà, al fine di comprendere lo spettro piú ampio possibile di situazioni umane con lo spettro piú ampio possibile di soluzioni linguistiche: dalla terra che puzza alla caduta della pioggia infernale («pute la terra che questo riceve», Inferno, VI 12) alla latrina che è diventata Firenze («in lor letame», Inferno, XV 75) e all’irriconoscibilità di un adulatore all’inferno («vidi un col capo sí di merda lordo», Inferno XVIII 116), dal sacco intestinale di Maometto («che merda fa di quel che si trangugia», Inferno, XXVIII 27) alla scorreggia del diavolo («ed elli avea del cul fatto trombetta», Inferno, XXI 139), fino alla posizione astrale dei pianeti («che quattro cerchi giugne con tre croci», Paradiso, I 39) e alla quadratura del cerchio («come si convenne | l’imago al cerchio e come vi s’indova», Paradiso, XXXIII 137-38), la lingua deve saper dire tutto, inventandoselo perché è l’unico modo di dirlo di nuovo. A nuove situazioni, nuove parole, e a nuovi modi di sentire, nuove parole: la lingua crea e mette in comunicazione le anime, al punto che a Dante tocca inventare nuove parole per esprimere situazioni inaudite, come la perfetta compenetrazione nel sentire altrui che si verifica nel momento in cui tu diventi me e io te. «S’io m’intuassi come tu t’inmii», dice per l’appunto il poeta a Folchetto di Marsiglia nel cielo di Venere (Paradiso, IX 81). Che fa Dante quando si trova di fronte all’impossibilità di dire ciò che vuole dire, perché la materia è superiore alla capacità espressiva dell’uomo? Mescola i suoni e inventa parole, in modo che il lettore venga introdotto a un mondo che non conosce, ma che gli risulta familiare perché fa risuonare cose che conosce:
Con tutto ’l core e con quella favella
ch’è una in tutti, a Dio feci olocausto,
qual conveniesi a la grazia novella.
E non er’ anco del mio petto essausto
l’ardor del sacrificio, ch’io conobbi
esso litare stato accetto e fausto;
ché con tanto lucore e tanto robbi
m’apparvero splendor dentro a due raggi,
ch’io dissi: «O Elïòs che sí li addobbi!»
(Paradiso, XIV 88-96)
In questi nove versi compaiono ben nove parole che Dante usa una volta soltanto in tutta la Commedia (hapax, si chiamano con termine tecnico, dal greco hapax legomenon, detto una sola volta): olocausto, essausto, litare, accetto, fausto, lucore, robbi, Elïòs, addobbi. Sono tutti latinismi, incluso Elïòs che è grecismo, ma che Dante riceveva attraverso il latino, non sapendo il greco; quel che piú conta qui, però, è che Dante sta parlando «con quella favella | ch’è una in tutti», cioè con la lingua interiore delle emozioni: una lingua della mente preesistente alla nascita delle lingue storiche, sita in quel luogo dove piú forte l’uomo sentirebbe l’eco della lingua di Dio da cui è stato creato (essendo la creazione, secondo la Bibbia, un atto linguistico, perché Dio creò nominando le cose). Passando dal cielo del Sole, il quarto, a quello di Marte, il quinto, Dante sente il bisogno di sottolineare la propria gratitudine a Dio con una preghiera che sancisce non solo la novità della sua esperienza, ma anche il fatto che tutti gli esseri umani dovrebbero essere in grado di pregare Dio nello stesso modo per ringraziarlo di aver creato loro e il mondo in cui vivono. La lingua diventa un corto circuito tra l’uomo e Dio perché solo con la lingua l’uomo riconquista il mistero della creazione, che lo porta a incontrare colui che l’ha creato.
Questa ricchezza espressiva è stata spesso chiamata il realismo di Dante, definizione che va bene nella misura in cui si considera realismo la capacità di dare un nome alle cose anziché quella di ritenere che a ogni cosa corrisponda un nome: la lingua non designa qualcosa che le preesiste, ma lo crea nel momento stesso in cui lo designa. La tesi di questo capitolo è cosí introdotta: che l’italiano sia stato concepito come lingua poetica in tutti i momenti della sua fondazione istituzionale come lingua nazionale.
Una lingua per la socialità di corte.
Il passaggio successivo nella storia della lingua italiana è la nascita di una grammatica che renda l’italiano uguale per tutti. Che gli italiani avessero una lingua comune per i commerci, la diplomazia e gli incontri di vario tipo è innegabile e l’ha dimostrato qualche tempo fa Enrico Testa, che ha chiamato questa lingua, con espressione tratta da La pietra lunare di Tommaso Landolfi, «italiano pidocchiale», cioè capace di garantire la diffusione e la comunicazione, ancorché sconnesso e scalcinato; ma che sentissero come lingua collettiva la lingua della poesia anziché questa lingua mista degli usi pratici è altrettanto innegabile, come dimostra la cosiddetta questione della lingua nel Cinquecento.
Quando un poeta e umanista veneto, Pietro Bembo, decide di promuovere la lingua di Petrarca e Boccaccio come lingua comune degli italiani, la scelta a favore della lingua della scrittura rispetto a quella dell’oralità è compiuta: l’italiano è lingua prima di tutto da scrivere, perché il suo obiettivo è esplorare l’animo umano e costruire la socialità anziché scambiare merci o codificare comportamenti. La lingua dovrà essere inventata una seconda volta, allora, perché il toscano che Bembo proporrà ai suoi contemporanei come lingua comune della cultura non sarà il toscano parlato ai suoi tempi, ma quello dei grandi classici del Trecento.
Di qui la stranezza per cui una lingua costruita su base toscana tradisce i toscani ogni volta che si ha a che fare col dittongo «uo»: nel Trecento si diceva «uomo», «uovo» e «buono», come scrivono Petrarca e Boccaccio, ma i toscani del Cinquecento avevano elaborato le soluzioni «omo», «ovo» e «bono», come ancora dicono i toscani oggi. Il risultato è che l’italiano non coincide col fiorentino, perché Bembo lo sottrae all’evoluzione storica e al cambiamento nel tempo, ma solo col fiorentino del Trecento. Un fiorentino non ha perciò nessuna chance in piú degli altri italiani di parlare un buon italiano, perché la sua lingua italiana dovrà essere, come quella di tutti gli altri, una lingua appresa anziché naturale.
Se la lingua si deve imparare, sarà naturalmente una lingua da studiare piuttosto che una lingua della strada: in questo senso l’italiano è una lingua artificiale, cioè fatta con arte (artificio dal latino, ars e facere: fare con arte). Si pensa di solito che Bembo abbia chiuso ciò che Dante aveva aperto: scegliendo Petrarca anziché proprio Dante come modello della lingua nazionale, Bembo avrebbe preferito il monolinguismo al plurilinguismo. Eppure il suo obiettivo non era quello di ridurre le possibilità espressive della lingua, ma di rendere la lingua comune: senza il petrarchismo, la lingua non sarebbe stata condivisa, perché il suo obiettivo doveva essere l’espressione dei sentimenti e lo scambio delle parole anziché la pretesa filosofica di rappresentare il mondo. Dante veniva rifiutato, insomma, sul piano ideologico piú che su quello linguistico, al punto che lo stesso Bembo continuò tranquillamente a usare parole dantesche oltre che petrarchesche e boccacciane. «Quanto ancora sarebbe egli miglior poeta che non è, se altro che poeta parere agli uomini voluto non avesse nelle sue rime», si legge nel capitolo XX del secondo libro delle Prose della volgar lingua, il trattato del 1525 cui Bembo affidava il proprio progetto linguistico: la polemica contro Dante e la sua lingua riguarda prima di tutto lo statuto della poesia, che per Bembo non dev’essere filosofia, ma solo lo strumento della comunicazione umana a livello elegante e profondo. Che il petrarchismo fornisse quindi una grammatica anziché il lessico unico e inderogabile della lingua italiana è prospettiva che non si può mettere facilmente in discussione, come una critica troppo avversa a Bembo ha invece voluto fare. Il grammatico non riuscí a uccidere il poeta.
L’obiettivo dell’aristocratico Bembo era dunque paradossalmente democratico: avendo la certezza della regola, tutti potranno avere accesso al livello piú alto della lingua, che servirà a formare una comunità di uguali che si scambiano fra loro prima di tutto pensieri ed emozioni, da cui nasceranno anche i discorsi culturali e politici. Il petrarchismo serve a definire una parità delle opportunità: eliminata la presunzione dantesca di possedere la varietà del mondo, chi vorrà parlare la lingua migliore a disposizione non dovrà distinguersi, ma partecipare al gioco. Non essere superiore agli altri, ma un membro della comunità.
La lingua del popolo.
Due volte, quindi, l’italiano nasceva come lingua artificiale: con Dante, che se l’inventava, e con Bembo, che la costruiva a tavolino. La terza tappa della questione della lingua sembra spostare completamente le cose: Alessandro Manzoni pretende che l’italiano sia una lingua parlata anziché letta e scritta. Si propone perciò di ricorrere al fiorentino parlato dei suoi tempi; ma lo fa da milanese che ha imparato l’italiano sui libri, visto che le sue prime lingue erano il dialetto locale, il milanese, e una lingua straniera, il francese (cominciando proprio dai vocabolari: il Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini e il Grand dictionnaire français-italien di François d’Albe...