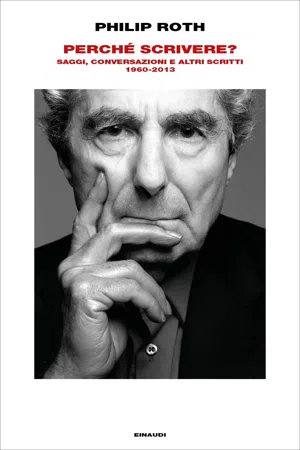1.
Sto guardando, mentre scrivo di Kafka, la sua fotografia a quarant’anni (la mia età): è il 1924, con ogni probabilità l’anno piú dolce e pieno di speranza della sua vita adulta, e l’anno della sua morte. Il viso è affilato e scheletrico, la faccia di uno che vive a credito: zigomi pronunciati resi ancora piú evidenti dall’assenza di basette; orecchie con la forma e l’inclinazione delle ali di un angelo; un’espressione intensa e creaturale di sbigottita compostezza – enormi paure, un enorme controllo; unico tratto sensuale, una cuffia nera di capelli levantini tirata sul cranio; c’è una familiare svasatura ebraica nel ponte del naso, un naso lungo e un poco appesantito in punta – il naso di metà dei ragazzi ebrei che erano miei amici alle superiori. Crani cesellati come questo furono spalati a migliaia dai forni; se fosse sopravvissuto, il suo sarebbe stato fra quelli, insieme ai crani delle tre sorelle minori.
Ovviamente pensare a Franz Kafka ad Auschwitz non è piú orribile che pensare a chiunque altro ad Auschwitz: è solo orribile a proprio modo. Ma lui morí troppo presto per l’Olocausto. Se fosse sopravvissuto, forse l’avrebbe scampato fuggendo insieme al suo caro amico Max Brod, che trovò rifugio in Palestina e restò cittadino di Israele fino alla morte nel 1968. Ma Kafka che fugge? Suona inverosimile per uno cosí affascinato dalle trappole e dalle esistenze culminanti in morti angosciose. Eppure c’è Karl Rossmann, il suo emigrante di primo pelo. Avendo immaginato la fuga e le alterne fortune di Karl in America, Kafka non avrebbe potuto trovare un modo per mettere anche lui in atto una fuga? La New School for Social Research di New York che diventa il suo Grande Teatro Naturale di Oklahoma? O magari, grazie a una raccomandazione di Thomas Mann, una posizione al dipartimento di germanistica a Princeton… D’altra parte, se Kafka fosse sopravvissuto, chissà se i libri che Mann celebrò dal suo rifugio nel New Jersey sarebbero mai stati pubblicati; Kafka avrebbe potuto distruggere i manoscritti che già una volta aveva chiesto a Max Brod di far sparire al momento della sua morte, o quantomeno avrebbe potuto continuare a tenerli segreti. Il profugo ebreo che giunge in America nel 1938 non sarebbe dunque stato l’ineguagliato «umorista religioso» di Mann, ma uno scapolo cinquantacinquenne erudito e di salute cagionevole, ex legale di una compagnia d’assicurazioni governativa di Praga ritiratosi in pensione a Berlino al tempo dell’ascesa al potere di Hitler – un autore, sí, ma solo di alcuni racconti eccentrici, perlopiú riguardanti animali, racconti di cui in America nessuno aveva sentito parlare e che in Europa solo una manciata di persone avevano letto; un K. senza casa, ma privo della caparbietà e della determinazione di K., un Karl in esilio, ma privo dello spirito giovanile e della resistenza fisica di Karl; semplicemente un ebreo abbastanza fortunato da essere fuggito portando in salvo la vita, con giusto una valigia contenente qualche vestito, qualche foto di famiglia, qualche ricordo di Praga, e i manoscritti, ancora inediti e frammentari, di America, Il processo e Il castello, nonché (se ne vedono di cose strane) di altri tre romanzi incompiuti, non meno notevoli dei bizzarri capolavori tenuti per sé in nome di una timidezza edipica, una follia perfezionistica e un insaziabile desiderio di solitudine e purezza spirituale.
Luglio 1923: undici mesi prima di morire in un sanatorio di Vienna, in qualche modo Kafka trova la forza di lasciare per sempre Praga e la casa di suo padre. Mai prima è riuscito anche solo lontanamente a vivere per conto proprio, indipendente dalla madre, dalle sorelle e dal padre, né è mai stato uno scrittore se non nelle poche ore in cui non lavora nel dipartimento legale dell’Ufficio delle assicurazioni per gli incidenti sul lavoro di Praga; da quando si è laureato in giurisprudenza è stato, secondo tutte le testimonianze, il piú coscienzioso e scrupoloso dei dipendenti, sebbene trovi il proprio mestiere noioso e snervante. Ma nel giugno del 1923 – dopo aver ottenuto da qualche mese il pensionamento per ragioni di salute – incontra in una località marittima tedesca una ragazza ebrea diciannovenne, Dora Dymant, impiegata presso la colonia estiva della Casa popolare ebraica di Berlino. Dora (che ha la metà degli anni di Kafka) ha lasciato la sua famiglia di polacchi ortodossi per guadagnarsi da vivere per conto proprio; lei e Kafka – da poco quarantenne – si innamorano… Fino a questo momento lui è stato fidanzato con due ragazze ebree molto piú convenzionali – con una di loro per due volte –, fidanzamenti frenetici e angosciati, mandati a monte soprattutto a causa delle sue paure. «Sono spiritualmente inadatto al matrimonio, – scrive al padre nella lettera di quarantacinque pagine che aveva affidato alla madre perché gliela consegnasse. – Dall’istante in cui decido di sposarmi non riesco piú a dormire, la testa mi arde notte e giorno, non vivo piú». Poi spiega perché. «Il matrimonio mi è precluso, – dice al padre, – perché si tratta dell’ambito piú propriamente tuo. A volte mi figuro una carta della terra e tu sopra sdraiato di traverso. E allora ho la sensazione di poter considerare per la mia vita solo regioni che tu non ricopri o che sono fuori dalla tua portata. E in conformità all’idea che mi sono fatto della tua grandezza, queste non sono molte e non sono molto confortanti, e il matrimonio non è fra loro». La lettera che spiega cosa c’è che non va fra questo padre e questo figlio risale al novembre 1919; la madre aveva ritenuto meglio non consegnarla, forse per mancanza di coraggio, forse, al pari del figlio, per mancanza di speranza.
Nei due anni successivi, Kafka tenta di portare avanti una relazione con Milena Jesenská-Pollak, un’appassionata ventiquattrenne che ha tradotto in ceco alcuni suoi racconti ed è sposata molto infelicemente a Vienna; la relazione con Milena, condotta in modo febbrile ma perlopiú per corrispondenza, è per Kafka ancor piú demoralizzante degli spaventevoli fidanzamenti con le brave ragazze ebree. Loro si limitavano a suscitare in lui quei desideri da padre di famiglia che non osava appagare, desideri inibiti dall’esagerata soggezione che provava verso il padre – «Era intrappolato nell’incantesimo della cerchia famigliare», dice Brod – e dall’ipnotica malia della propria solitudine; invece la ceca Milena, impetuosa, scalpitante, indifferente ai vincoli convenzionali, donna di furie e appetiti, suscita in lui bramosie e paure piú elementari. Secondo un critico praghese, Rio Preisner, Milena era «psicopatica»; secondo Margarete Buber-Neumann, vissuta per due anni al suo fianco nel campo di concentramento tedesco dove Milena morí nel 1944 in seguito a un’operazione ai reni, era potentemente sana, straordinariamente umana e coraggiosa. Il necrologio di Milena per Kafka fu l’unico di una qualche rilevanza a comparire sulla stampa praghese; la prosa è forte, come lo è la sua rivendicazione dei successi di Kafka. Lei non ha ancora trent’anni, il morto è quasi del tutto sconosciuto come scrittore al di là della sua piccola cerchia di amici, eppure Milena scrive: «La sua conoscenza del mondo era insolita e profonda. Lui stesso era un mondo insolito e profondo… [Era di] una stupefacente delicatezza d’animo e di una lucidità mentale lontanissima da qualsiasi compromesso; ma, per contro, aveva fatto ricadere sulla malattia tutto il peso della sua angoscia esistenziale… Scrisse i libri piú significativi della letteratura tedesca contemporanea». Ci si può immaginare questa vibrante giovane donna sdraiata di traverso sul letto, altrettanto terrificante per Kafka del padre disteso di traverso sulla carta della terra. Le lettere di Kafka per lei sono sconnesse, diverse da qualunque altra sua cosa pubblicata; la parola «angoscia» compare quasi a ogni pagina. «Noi siamo entrambi sposati, tu a Vienna, io con l’angoscia a Praga». Si strugge dal desiderio di posare la testa sul suo seno; la chiama «mamma Milena»; durante almeno uno dei loro due brevi incontri è del tutto impotente. Alla fine è costretto a dirle di lasciarlo perdere, un’ingiunzione cui Milena si attiene, sebbene si senta svuotata dal dolore. «Non scrivere e impedisci che ci incontriamo, – le dice Kafka, – esaudisci in silenzio questa mia preghiera, essa sola può consentirmi di continuare a vivere in qualche modo, tutto il resto prolunga la distruzione».
Poi, a inizio estate del 1923, mentre è ospite della sorella in vacanza coi figli sul mar Baltico, trova la giovane Dora Dymant, e nel giro di un mese Franz Kafka se n’è andato a vivere con lei in due stanze in un sobborgo di Berlino, finalmente lontano dalle «grinfie» di Praga e di casa sua. Come può essere accaduto? Come può lui, nella sua malattia, essere riuscito in modo cosí rapido e definitivo ad attuare quel commiato che gli era stato impossibile quand’era in salute? L’appassionato epistolografo capace di cavillare interminabilmente su quale treno prendere per incontrarsi con Milena a Vienna (se mai davvero decidesse di incontrarla per il fine settimana); il corteggiatore borghese in colletto alto che, durante la prolungata agonia del fidanzamento con la rispettabile Fräulein Bauer, compila in segreto un memorandum in cui contrappone gli argomenti «pro» e «contro» il matrimonio; il poeta dell’inafferrabile e dell’irrisolto, le cui atroci visioni di sconfitta hanno al proprio cuore la fede nell’irremovibile barriera che separa la volontà dalla sua realizzazione; il Kafka la cui narrativa invalida qualsivoglia facile, commovente, umanisticheggiante sogno a occhi aperti di salvezza e giustizia e soddisfacimento, immaginando complessi controsogni che deridono qualunque soluzione o via di fuga… questo Kafka fugge. Da un giorno all’altro! K. penetra oltre le mura del castello, Josef K. si sottrae alle accuse, scopre «come vivere al di fuori del processo». Sí, le possibilità che Josef K. intravede quando si trova nel duomo, ma che non riesce né a comprendere né a mettere in pratica – «non già come si poteva influire sul processo, ma come evaderne» –, Kafka le mette in pratica nell’ultimo anno della sua vita.
È stata Dora Dymant o è stata la morte a indicare la nuova via? Forse l’una senza l’altra non avrebbe potuto essere. Noi sappiamo che il «vuoto apparente» contemplato da K. la prima volta che entra nel villaggio e attraverso la nebbia e le tenebre alza gli occhi verso il castello non è piú vasto e incomprensibile di quanto fosse per il giovane Kafka l’idea di se stesso come marito e padre; ma adesso, a quanto pare, la prospettiva di una Dora per sempre, di una moglie, una casa e dei figli per l’eternità, non è piú la prospettiva terrificante, sbigottente, che sarebbe stata un tempo, perché adesso «per l’eternità» senza dubbio non significa piú che qualche mese. Sí, il Kafka morente è deciso a sposarsi, e scrive al padre ortodosso di Dora per chiedergli la mano della figlia. Ma la morte imminente che in Kafka ha risolto ogni contraddizione e incertezza è anche l’ostacolo piazzato sulla sua strada dal padre della giovinetta. La richiesta da parte di Franz Kafka, un uomo in punto di morte, di legare a sé nella propria menomazione la giovane e sana Dora Dymant viene… negata!
Se non c’è un padre a mettere i bastoni fra le ruote a Kafka, ce n’è un altro – e dietro, un altro ancora. Il padre di Dora, scrive Max Brod nella sua biografia di Kafka, «aveva recato la lettera [di Kafka] alla persona che piú venerava e alla cui autorità teneva massimamente: al “Gerer Rebbe”. Questo rabbino lesse lo scritto e non disse altro che un breve no». No. Klamm in persona non avrebbe potuto essere piú netto – o piú remoto dal postulante. No. Nella sua violenta perentorietà, una risposta altrettanto rivelatrice e implacabile dell’anatema scagliato dal padre sull’osteggiato promesso sposo Georg Bendemann: «Prendi a braccetto la tua fidanzata e vienimi incontro! Te la spazzo via di dosso, vedrai come!» No. Tu non avrai, dicono i padri, e Kafka acconsente a non avere. La sua solita assuefazione all’obbedienza e alla rinuncia; nonché, come al solito, il disgusto per gli infermi e l’ammirazione per la forza, l’appetito e la salute. «“Ora però mettete in ordine!”, disse il sorvegliante, e il digiunatore venne sepolto insieme alla paglia. Nella gabbia fu messa invece una giovane pantera. Fu sollievo percepibile persino dallo spirito piú ottuso vedere quell’animale feroce agitarsi nella gabbia per tanto tempo deserta. Non le mancava nulla. Il cibo che le piaceva glielo portavano i guardiani senza star tanto a pensarci; non sembrava neppure avvertire la mancanza della libertà; quel corpo nobile, perfetto in ogni sua parte quasi fino a spezzarsi, sembrava portarsi addosso anche la libertà; essa sembrava essere da qualche parte fra i denti; e la gioia di vivere erompeva con ardore cosí forte dalle fauci, che per i visitatori non era facile resisterle. Ma essi si facevano forza, si accalcavano attorno alla gabbia e non volevano piú andarsene». Dunque no è no; questo lui lo sa. Una giovinetta diciannovenne non può, non deve, venir data in matrimonio a un uomo malaticcio del doppio dei suoi anni, che sputa sangue («Io ti condanno – grida il padre di Georg Bendemann – alla morte per acqua!») e se ne sta a letto scosso dalla febbre e dai brividi. Che razza di sogno per nulla alla Kafka stava sognando Kafka?
Tuttavia quei nove mesi trascorsi con Dora contengono anche elementi «kafkiani»: un rigido inverno in un appartamento mal riscaldato; l’inflazione che riduce a una miseria la sua magra pensione e riempie le strade di Berlino di affamati e bisognosi le cui sofferenze, dice Dora, rendono Kafka «cinereo»; e i propri polmoni tubercolotici, carne trasfigurata e castigata. Dora si prende cura dello scrittore infermo con la medesima devozione e tenerezza riservata dalla sorella di Gregor Samsa a suo fratello, lo scarafaggio. La sorella di Gregor suona cosí bene il violino che a Gregor «parve di vedere tracciata davanti a sé la via verso quel nutrimento ignoto e agognato»; e, nelle sue condizioni, sogna di mandare la talentuosa sorella al conservatorio! La musica di Dora è l’ebraico, che lei legge a Kafka ad alta voce con gran perizia, tanto che, secondo Brod, «Franz intuí in lei l’ingegno drammatico e le consigliò di coltivarlo, ciò che essa fece sotto la sua guida…»
Solo che Kafka non è affatto un parassita agli occhi di Dora Dymant, e nemmeno ai propri. Lontano da Praga e dalla casa paterna, a quarant’anni Kafka sembra essersi finalmente liberato dal disgusto verso se stesso, dai dubbi che lo divoravano e dai sensi di colpa coi conseguenti impulsi alla dipendenza e all’abnegazione, che per poco non l’hanno fatto ammattire nei due decenni precedenti; d’un tratto sembra essersi levato di dosso l’onnipresente senso di assoluta disperazione che permea le grandi fantasticherie punitive di Il processo, Nella colonia penale e La metamorfosi. Anni prima, a Praga, aveva dato disposizione a Max Brod di distruggere tutte le sue carte, compresi i tre romanzi inediti, al momento della sua morte; ora, a Berlino, quando Brod lo presenta a un editore tedesco interessato alla sua opera, Kafka acconsente alla pubblicazione di un volume di quattro racconti, e acconsente, dice Brod, «senza che si dovesse persuaderlo». Con Dora ad aiutarlo, riprende con diligenza lo studio dell’ebraico; nonostante la malattia e i rigori invernali, si reca all’Accademia berlinese per gli studi ebraici ad assistere a una serie di conferenze sul Talmud – un Kafka molto diverso dall’estraniato malinconico che una volta aveva scritto nel suo diario: «Che cosa ho in comune con gli ebrei? Non ho, si può dire, niente in comune con me e, contento di poter respirare, dovrei mettermi quieto in un angolo». E a marcare ancor piú il cambiamento, ci sono la disinvoltura e la felicità con una donna: con questa compagna giovane e adorante è giocoso, è pedagogico e, viene da pensare alla luce della sua malattia (nonché della sua felicità), è casto. Se non un marito (come aveva aspirato a essere per la convenzionale Fräulein Bauer), se non un amante (come si era sforzato senza speranza di essere con Milena), pare essere diventato qualcosa di non meno miracoloso nel suo schema delle cose: un padre, una sorta di padre per questa fraterna, materna figlia. Quando Franz Kafka una mattina nel suo letto si svegliò da sonni inquieti, si ritrovò trasformato in un padre, uno scrittore e un ebreo.
«Ho costruito la tana, – cosí comincia il lungo e squisitamente monocor...