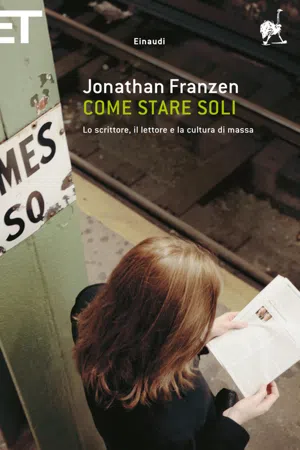![]()
Perché scrivere romanzi?
(Il saggio di «Harper’s»)
La mia disperazione nei confronti del romanzo americano nacque nell’inverno del 1991, quando fuggii a Yaddo, la colonia di artisti nella parte settentrionale dello stato di New York, per scrivere gli ultimi due capitoli del mio secondo libro. Mi ero appena separato da mia moglie, e vivevo un periodo di volontario isolamento a New York City, trascorrendo lunghe giornate di lavoro in una stanzetta bianca, imballando dieci anni di beni in comune e facendo passeggiate notturne lungo strade dove si parlavano in uguale misura il russo, l’hindi, il coreano e lo spagnolo. E tuttavia le notizie, attraverso il televisore e l’abbonamento al «Times», riuscivano a raggiungermi persino nel cuore del mio quartiere di Queens. Il paese si stava preparando estaticamente alla guerra, armato della retorica di George Bush: «Sono in gioco principî di vitale importanza». L’ottantanove per cento di consensi alla politica di Bush, cosí come la pressoché totale assenza di pubblico scetticismo nei confronti della guerra, mi facevano apparire gli Stati Uniti come una nazione irreparabilmente scollegata dalla realtà – che sognava la gloria nel massacro di iracheni senza volto, sognava riserve infinite di petrolio per i viaggi dei pendolari, sognava l’esenzione dalle regole della storia. E anch’io, quindi, sognavo di fuggire. Volevo nascondermi dall’America. Ma quando giunsi a Yaddo e scoprii che non era affatto un rifugio – il «Times» arrivava tutti i giorni, e gli altri abitanti della colonia parlavano in continuazione di missili Patriot e nastri gialli – cominciai a pensare di avere, in realtà, bisogno di un monastero.
Poi un pomeriggio, nella piccola biblioteca di Yaddo, trovai il romanzo breve di Paula Fox Quello che rimane. «L’avrebbe fatta franca su tutto!» è la speranza che si impossessa della protagonista del romanzo, Sophie Bentwood, una donna senza figli che vive a Brooklyn, infelicemente sposata con un avvocato benpensante. Un tempo Sophie traduceva romanzi francesi; ora è cosí depressa che riesce a malapena a leggerli. Nonostante gli ammonimenti del marito, Otto, ha dato del latte a un gatto randagio, e il gatto ha ripagato la cortesia mordendole la mano. Sophie si sente subito «estremamente ferita» – è stata morsa senza «nessuna ragione», proprio come nel Processo Josef K. viene arrestato senza «nessuna ragione» –, ma quando il gonfiore alla mano diminuisce, Sophie diventa euforica per la speranza di evitare l’iniezione antirabbica.
Il «tutto» su cui Sophie vuole farla franca, però, è qualcosa di piú della tollerante autoindulgenza dimostrata con il gatto. Sophie vuole farla franca sul fatto di leggere romanzi dei Goncourt e mangiare omelettes aux fines herbes in una via dove i vagabondi giacciono nel proprio vomito e in un paese che sta combattendo una sporca guerra in Vietnam. Vuole che le venga risparmiato il dolore di affrontare un futuro al di là della sua vita con Otto. Vuole continuare a sognare. Ma la logica del romanzo non glielo permetterà. È costretta, invece, a questa equiparazione del personale al sociale:
«Dio, se ho la rabbia non sono diversa da ciò che accade all’esterno», dichiarò a voce alta, e provò uno straordinario sollievo, come se, finalmente, avesse scoperto ciò che poteva creare un equilibrio fra il succedersi dei giorni tranquilli e alquanto vuoti che passava in quella casa, e quei presagi che illuminavano il buio ai margini della sua esistenza.
Quello che rimane, che venne pubblicato per la prima volta nel 1970, termina con un atto di violenza profetica. Logorato dalla tensione per il crollo del proprio matrimonio, Otto Bentwood agguanta una boccetta di inchiostro dalla scrivania di Sophie e la scaglia contro la parete della camera da letto. L’inchiostro con cui sono stati scritti i suoi testi di giurisprudenza e le traduzioni di Sophie forma ora una macchia illeggibile. Le righe nere sul muro sono i segni di un tragico destino ma anche gli araldi di uno straordinario sollievo, la fine di un febbrile isolamento.
Equiparando il crollo di un matrimonio al crollo di un sistema sociale, Quello che rimane si riferiva in maniera diretta alle ambiguità che stavo sperimentando durante quel gennaio. Il fatto che il mio matrimonio stesse cadendo a pezzi era una cosa fantastica o una cosa terribile? E l’angoscia che provavo era dovuta a un malessere interiore, dell’anima, oppure mi veniva imposta dal malessere della società? Il fatto che qualcun altro, oltre me, avesse sofferto per queste ambiguità e avesse visto la luce in fondo a esse – che il libro di Fox fosse stato pubblicato e conservato; che potessi trovare compagnia e consolazione e speranza in un oggetto preso quasi a caso da uno scaffale – somigliava a un esempio di grazia religiosa.
Eppure, proprio mentre venivo salvato, come lettore, da Quello che rimane, come scrittore ero sopraffatto dalla disperazione riguardo alla possibilità di connettere il personale con il sociale. Al giorno d’oggi, chiunque si ritrovasse a leggere Quello che rimane verrebbe colpito dalla familiarità ma anche dall’estraneità del mondo dei Bentwood. Un quarto di secolo non ha fatto altro che ampliare e confermare il senso di crisi culturale espresso da Fox. Ma ciò che oggi sembra essere il locus di quella crisi – il banale ascendente della televisione, la frammentazione elettronica del dibattito pubblico – non appare da nessuna parte nel romanzo. Per i Bentwood comunicazione significava libri, un telefono, lettere. I presagi non scaturivano ininterrottamente da un cavo o da un modem; si intravedevano soltanto di sfuggita, ai margini dell’esistenza. Una boccetta di inchiostro, che oggi sembra un bizzarro oggetto d’altri tempi, nel 1970 poteva ancora rappresentare un simbolo.
In un inverno in cui ogni casa della nazione era infestata dalle spettrali presenze televisive di Peter Arnett da Bagdad e Tom Brokaw dall’Arabia Saudita – un inverno in cui gli abitanti di quelle case, piú che individui, sembravano un algoritmo collettivo per la conversione dello sciovinismo mediatico in un indice di consenso dell’ottantanove per cento – fui tentato di pensare che un moderno Otto Bentwood coi nervi a pezzi avrebbe sfondato a calci lo schermo del televisore in camera da letto. Ma il punto non era questo. Otto Bentwood, se fosse vissuto negli anni Novanta, non avrebbe avuto i nervi a pezzi, perché il mondo non avrebbe piú esercitato alcuna influenza su di lui. Snob spudorato, avatar della parola stampata e uomo autenticamente solitario, Otto appartiene a una specie cosí minacciata da essere quasi irrilevante nell’era della democrazia elettronica. Per secoli l’inchiostro, sotto forma di romanzi, ha fissato individui distinti e soggettivi all’interno di narrazioni dense di significato. Quello che Sophie e Otto intravedevano, nel profetico sgorbio nero sulla parete della camera da letto, era la disintegrazione della nozione stessa di personaggio letterario. Non c’è da stupirsi che fossero disperati. Erano ancora gli anni Sessanta e non avevano idea di cosa li avesse colpiti.
C’era un assedio in corso: andava avanti da molto tempo, ma gli stessi assediati erano gli ultimi a prenderlo sul serio.
da Quello che rimane
Quando finii il college, nel 1981, non ero al corrente della morte del romanzo sociale. Non sapevo che Philip Roth ne avesse compiuto l’autopsia molto tempo prima, descrivendo la «realtà americana» come qualcosa che «stordisce… dà la nausea… fa infuriare, e infine… crea persino un certo imbarazzo alla scarsa immaginazione degli individui. L’attualità supera continuamente il nostro ingegno…» Io ero innamorato della letteratura, e di una donna che mi aveva attratto, fra l’altro, perché era una brillante lettrice. Avevo un gran numero di modelli per il tipo di romanzo intransigente che volevo scrivere. Fra questi modelli c’era persino un romanzo intransigente che aveva trovato un ampio pubblico: Comma 22. Joseph Heller aveva scoperto un modo per superare l’attualità, utilizzando l’assurdità della guerra moderna come metafora della diffusa degenerazione della realtà americana. Il suo libro si era insinuato cosí profondamente nell’immaginario della nazione che il mio Webster’s Ninth Collegiate forniva non meno di cinque sfumature di significato per il titolo. Il fatto che in seguito nessun romanzo impegnativo avesse influenzato la cultura in modo anche solo lontanamente paragonabile a Comma 22, proprio come nessuna questione era piú riuscita a galvanizzare tanti giovani americani emarginati quanto la guerra del Vietnam, era facilmente trascurabile. Negli anni del college il marxismo mi aveva dato alla testa, e credevo che il «capitalismo monopolistico» (come lo chiamavamo) abbondasse di «momenti negativi» (come li chiamavamo) che uno scrittore avrebbe potuto sbattere in faccia agli americani se solo avesse confezionato le proprie bombe sovversive all’interno di una narrazione abbastanza attraente.
Quando cominciai a scrivere il mio primo libro avevo ventidue anni e sognavo di cambiare il mondo. Quando lo finii avevo sei anni in piú. L’unica, minuscola speranza mondana a cui ancora mi aggrappavo era un passaggio su radio Kmox, «la voce di St Louis», con le sue lunghe, profonde interviste a scrittori che ascoltavo da ragazzo nella cucina di mia madre. Il mio romanzo, La ventisettesima città, parlava dell’innocenza di una città del Midwest – delle forti ambizioni municipali di St Louis in un’epoca di apatia e confusione –, e non vedevo l’ora di trascorrere quarantacinque minuti con uno dei conduttori del talk-show pomeridiano di radio Kmox, il quale, nella mia immaginazione, mi avrebbe aiutato a sviluppare i temi che nel libro erano rimasti latenti. Agli ascoltatori infuriati che avrebbero telefonato per chiedermi perché odiavo St Louis avrei spiegato, con il tono coraggioso di chi ha perduto la propria innocenza, che quello che a loro sembrava odio era in realtà un amore difficile. Tra il pubblico in ascolto ci sarebbe stata la mia famiglia: mia madre, che considerava quella dello scrittore una carriera socialmente irresponsabile, e mio padre, che sperava di trovarmi un giorno recensito sulla rivista «Time».
Solo quando La ventisettesima città venne pubblicato, nel 1988, mi accorsi di quanto fossi ancora innocente. L’ossessivo interesse dei media per la mia giovane età mi sorprese. E altrettanto mi sorprese il denaro. Lanciato dall’ottimismo degli editori, secondo i quali quel romanzo fondamentalmente cupo e controcorrente avrebbe potuto vendere una miriade di copie, guadagnai abbastanza da finanziare la stesura del mio secondo romanzo. Ma la piú grossa sorpresa – la vera misura di quanto avessi sottovalutato l’allarme che io stesso avevo lanciato nella Ventisettesima città – fu che il mio romanzo culturalmente impegnato non suscitò alcun impegno da parte della cultura. Il mio scopo era la provocazione; quello che ottenni, invece, furono sessanta recensioni nel vuoto.
Il mio passaggio su radio Kmox fu significativo. L’annunciatore, un mestierante con la faccia rossa per il whiskey e uno straziante riporto di capelli, evidentemente non era andato oltre il secondo capitolo. Sotto il microfono a giraffa, sfiorava le pagine del romanzo come se sperasse di assorbirne la trama attraverso l’epidermide. Mi rivolse le domande che mi rivolgevano tutti: Come mi sentivo a ricevere recensioni cosí positive? (Benissimo, dissi). Il romanzo era autobiografico? (No, dissi). Come mi sentivo nei panni del ragazzo di St Louis che ritorna nella città d’origine per un lussuoso giro promozionale? Vagamente deluso. Ma questo non lo dissi. Avevo già capito che i soldi, la notorietà, la corsa in limousine fino allo studio fotografico di «Vogue» non erano semplici indennità accessorie. Erano il premio principale, la consolazione per il fatto di non avere piú alcuna rilevanza all’interno della cultura.
È impossibile dire con precisione quanto sia diminuito il numero dei romanzi che rivestono una certa importanza per la cultura di massa americana, rispetto al periodo in cui Comma 22 venne pubblicato. Ma il giovane scrittore ambizioso non può fare a meno di notare che, nel recente sondaggio di «USA Today» su ventiquattr’ore di vita culturale americana, la televisione viene citata ventuno volte, i film otto, la musica pop sette, la radio quattro e la narrativa una volta soltanto (I ponti di Madison County). Oppure che riviste come «The Saturday Review», che all’apice della carriera di Joseph Heller vagliavano ancora mucchi di romanzi, sono completamente scomparse. O che oggi il «Times Book Review» pubblica non piú di due recensioni di narrativa alla settimana (cinquant’anni fa, il rapporto tra narrativa e saggistica era uno a uno).
L’unica famiglia media americana che conosco bene è quella in cui sono cresciuto, e posso testimoniare che mio padre, pur non essendo un lettore, aveva una certa familiarità con James Baldwin e John Cheever, perché la rivista «Time» li aveva messi in copertina, e «Time», per mio padre, era la massima autorità in campo culturale. Nell’ultimo decennio, la rivista il cui profilo rosso ha incorniciato per due volte la faccia di James Joyce, ha dedicato la copertina a Scott Turow e Stephen King. Si tratta di due validi scrittori, ma non c’è dubbio che siano state le dimensioni dei loro contratti a procurare loro quelle copertine. Il dollaro è oggi il metro di valutazione dell’autorità culturale, e un periodico come «Time», che fino a non molto tempo fa aspirava a formare i gusti della nazione, adesso serve soprattutto a rifletterli.
L’America letteraria in cui mi ritrovai dopo la pubblicazione della Ventisettesima città assomigliava stranamente alla St Louis in cui ero cresciuto: un’ex grande città che era stata sventrata e prosciugata dalle autostrade e dall’esodo dei bianchi. Intorno al nucleo urbano depresso della narrativa seria prosperavano nuove periferie di intrattenimento di massa. Gli ultimi residui di vitalità del centro cittadino erano concentrati nelle comunità di neri, ispanici, asiatici, gay e donne, che avevano occupato le strutture lasciate libere dalla fuga dei maschi bianchi eterosessuali. I programmi del Master of Fine Arts offrivano alloggi e lavoro ai sottoccupati; alcuni eccentrici artisti amanti della città continuavano ad abitare in vecchi magazzini; e i lettori di passaggio nel fine settimana potevano ancora visitare alcuni monumenti culturali ben sorvegliati dalla polizia – la chiesa di Toni Morrison, l’orchestra di John Updike, la Faulkner House, il Wharton Museum e il Mark Twain Park.
All’inizio degli anni Novanta ero depresso come il nucleo urbano della narrativa. Il mio secondo romanzo, Strong Motion, era una lunga e complicata storia sulla vita di una famiglia del Midwest in un mondo di sovvertimento morale, e questa volta, invece di spedire le mie bombe in una busta imbottita piena di ironia e understatement, come avevo fatto con La ventisettesima città, ero uscito allo scoperto lanciando molotov di retorica. Ma il risultato fu identico: un’altra pagella con buoni voti da parte dei critici, che avevano sostituito gli insegnanti la cui approvazione, quando ero piú giovane, avevo desiderato ardentemente senza però ricavarne alcuna soddisfazione; una discreta quantità di denaro; e il silenzio dell’irrilevanza. Nel frattempo, mi ero ricongiunto con mia moglie a Philadelphia. Per due anni avevamo continuato a spostarci lungo tre zone di fuso orario, cercando un luogo piacevole e poco costoso dove non ci sentissimo estranei. Alla fine, dopo un’attenta valutazione, avevamo preso in affitto una casa troppo costosa in un’altra città depressa. Il fatto che continuassimo a sentirci infelici sembrò confermare al di là di ogni dubbio che non esisteva alcun posto al mondo per gli scrittori di narrativa.
A Philadelphia cominciai a fare calcoli inutili, moltiplicando il numero di libri che avevo letto l’anno precedente per il numero di anni che potevo ancora ragionevolmente aspettarmi di vivere, e scorgendo nelle tre cifre del risultato non tanto un preannuncio di mortalità (anche se le notizie da quel fronte non mi tirarono su di morale), quanto una misura dell’incompatibilità del lento lavoro della lettura con l’ipercinesi della vita moderna. D’un tratto ebbi l’impressione che i miei amici che un tempo leggevano non si giustificassero neanche piú per il fatto di avere smesso. Una giovane conoscente che si era laureata in Letteratura inglese, quando le chiesi cosa stesse leggendo, rispose: «Vuoi dire lettura lineare? Come quando leggi un libro dall’inizio alla fine?»
Non c’è mai stato un grande spreco di amore fra la letteratura e il mercato. L’economia dei consumi predilige prodotti che si possano vendere a un prezzo elevato, che si logorino in fretta o si possano migliorare regolarmente, e che offrano a ogni miglioramento qualche lieve vantaggio in termini di utilità. Per un’economia come questa, il nuovo che rimane nuovo non è soltanto un prodotto inferiore; è un prodotto antitetico. Un classico della letteratura è poco costoso, riutilizzabile all’infinito e, peggio ancora, non migliorabile.
Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, l’economia politica americana si è impegnata a consolidare i propri guadagni, ad ampliare i mercati, a mettere al sicuro i profitti e a scoraggiare i pochi che ancora la criticavano. Nel 1993 i segni di questo consolidamento erano visibili ovunque. Li riconoscevo nei voluminosi furgoncini e nei massicci fuoristrada che avevano rimpiazzato l’automobile come veicolo preferito nei sobborghi – quei Ranger e Land Cruiser e Voyager che costituivano il vero bottino di una guerra combattuta per mantenere il piú basso possibile il prezzo della benzina americana, una guerra che aveva trasmesso qualcosa come mille ore di spot pubblicitari per l’alta tecnologia, una guerra dei consumi diffusa attraverso la Tv commerciale. Vedevo i soffiatori da giardino sostituire i rastrelli. Vedevo la Cnn tenere in ostaggio i viaggiatori nelle sale d’attesa degli aeroporti e i clienti in fila alle casse dei supermercati. Vedevo i processori 486 rimpiazzare i 386 e venire rimpiazzati a loro volta dai Pentium, di modo che, nonostante le nuove economie di scala, il prezzo base di un computer portatile non scendesse mai al di sotto dei mille dollari. Vedevo la Penn State University vincere il Blockbuster Bowl.
Tuttavia, proprio mentre andavo santificando la letteratura, ero cosí depresso da non riuscire a fare altro, dopo cena, che accasciarmi davanti alla Tv. Non avevamo i canali via cavo, ma trovavo sempre qualcosa di divertente: una partita Phillies contro Padres o Eagles contro Bengals, M*A*S*H*, Cheers, Homicide. Naturalmente, piú guardavo la Tv e peggio mi sentivo. Se sei uno scrittore e nemmeno tu hai voglia di leggere, come puoi aspettarti che qualcun altro legga i tuoi libri? Pensavo che avrei dovuto leggere, cosí come avrei dovuto scrivere il terzo romanzo. E non un terzo romanzo qualsiasi. Avevo sempre pensato che inserire i personaggi di un romanzo in un ambiente sociale dinamico arricchisse la narrazione; che la gloria di questo genere letterario consistesse nell’abbracciare la distanza che separa l’esperienza privata dal contesto pubblico. E poteva esistere un contesto piú vitale dell’annullamento di tale distanza da parte della televisione?
Ma il terzo libro mi paralizzava. Torturavo la storia, la stiracchiavo per farvi entrare un numero sempre maggiore di quelle cose-del-mondo che interferiscono con l’impresa della scrittura. L’opera piena di trasparenza e bellezza e allusività che volevo scrivere si stava gonfiando di tematiche. Avevo già inserito la farmacologia contemporanea e la Tv e la razza e la vita carceraria e un’altra dozzina di linguaggi; come sarei riuscito a ironizzare anche sull’esaltazione di Internet e sul Dow Jones, lasciando spazio per le complessità dei personaggi e dell’ambientazione? Il panico cresce nel divario fra la continua espansione del progetto e i tempi sempre piú stretti dei cambiamenti culturali: Come ideare un vascello che possa galleggiare sulla storia per tutto il tempo necessario a costruirlo? Il romanziere ha sempre piú cose da dire a lettori che hanno sempre meno tempo per leggerle: Dove trovare l’energia per dialogare con una cultura in crisi quando la crisi consiste nell’impossibilità di dialogare con la cultura? Furono giorni infelici. Cominciai a pensare che ci fosse qualcosa di sbagliato nell’intero modello di romanzo come forma di «impegno culturale».
Nel diciannovesimo secolo, quando Dickens e Darwin e Disraeli leggevano le opere l’uno dell’altro, il romanzo era il principale mezzo di istruzione sociale. Un nuovo libro di Thackeray o di William Dean Howells era atteso con la stessa eccitazione con cui oggi si attende un evento cinematografico di fine dicembre.
La grande, ovvia ragione del declino del romanzo sociale è che le moderne tecnologie sono un mezzo di istruzione sociale molto piú efficace. Televisione, radio e fotografia sono media vividi e immediati. Anche il giornalismo, sulle orme di A sangue freddo, è diventato una possibile alternativa al romanzo in campo creativo. Grazie all’ampio pubblico di cu...