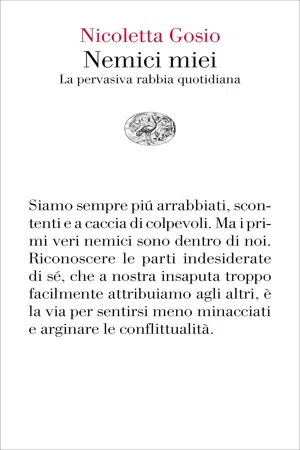Restando all’interno del nostro territorio di caccia non incontriamo soltanto, come abbiamo visto fin qui, volti simili e familiari. La società in cui viviamo è di fatto un mosaico variopinto di genti e mondi diversi in cerca di composizione, e in verosimile forte espansione. Lo straniero, nel senso ordinario di colui che viene da fuori, che appartiene ad altri Paesi, è da sempre il nemico per eccellenza, il latore dell’umana angoscia universale che proviamo nei confronti di tutto ciò che è sconosciuto, non familiare. Per la mente, e nella storia, non ultima la nostra di italiani ed europei, l’estraneità è invero una figura camaleontica, ampiamente plasmabile e cangiante, sulla quale è possibile ritagliare di volta in volta a propria discrezione categorie connotate da una qualche diversità – di nascita, colore, religione, valori, casta – per farne nemici anche dentro i propri confini. La forma di estraneità privilegiata dal presente è quella dell’immigrato extracomunitario, proveniente dall’esterno e strano per noi, in un ventaglio di etnie con sfumature di visuale diverse.
Nell’insieme, il posto che gli riserviamo è in cima alla graduatoria delle avversioni e delle paure sociali, delle minacce incombenti e, sembrerebbe, dei problemi attuali. Questo stesso primato, sempre rivedibile e intercambiabile, sostenuto oggi dall’imponenza degli spostamenti e da vicinanze inattese e malviste, è di per sé ambiguo e discutibile. Come e perché stiliamo la classifica è una faccenda di vecchia data, che precede e oltrepassa nomi e volti che la compongono. Pesca in motivazioni piú o meno fondate, ma in maggior grado fa ricorso a falsificazioni e trucchi in parte eterni e ingenuamente spontanei, in parte contestuali e scientemente costruiti.
Parafrasando il titolo eloquente di un discorso tenuto negli anni Sessanta dallo scrittore svizzero Max Frisch, Volevamo braccia, sono arrivati uomini, si potrebbe dire «abbiamo aperto le frontiere ai mercati, le stanno varcando persone». Volevamo prosperità economica, flussi di capitali, merci e informazione; per ironia della sorte, errori di valutazione o bieco cinismo, forse di tutto un po’, ci troviamo in casa ondate di sofferenza, povertà estrema e conflitti.
L’affluenza degli stranieri in numeri tanto elevati solleva enormi, controverse questioni di ordine culturale, sociale, morale, geopolitico, giuridico e finanziario. Crea problematiche concrete – e altre ne svela. Congiuntamente, “l’invasione” suscita reazioni largamente circonfuse di irrazionale emotività e connotazioni ideologiche pregiudiziali. Rievoca spettri, riesuma memorie sgradite, rafforza una logica binaria di sguardo e pensiero: noi e (o) loro, bene e male, innocenza e colpevolezza, diversità e uguaglianza, tolleranza e xenofobia. Tutto in bianco o nero in un dibattito pressante in cui, sia a livello politico sia fra gente comune, una continua confusiva commistione di piani riproduce divisioni, barriere difensive e offensive, e qualsiasi argomentazione rischia di essere convogliata in propaganda o polverosa retorica. In tal modo l’altro è consegnato o a un buonismo improbabile e malfermo, o al risentimento e all’odio.
Accogliere o respingere finisce col tradursi in una rigida dicotomia arroccata su una concezione statica di identità e società che schiva il faticoso percorso di confronto, cambiamento e costruzione di un pluralismo sostenibile. Il primo ostacolo da superare si pone nella preliminare conoscenza dell’altro per chi e come è realmente, al netto delle proprie paure, ambizioni e convenienze. Vale a dire, nell’impegno a riconoscere la sua diversità senza farne l’immagine del male – di angosce e impulsi aggressivi – che è anche nostro, senza ridurlo allo specchio dei propri «ospiti stranieri», come Freud chiamava le forze inconsce che governano idee e affetti1. Rinunciando a trincerarci dietro la falsa ma rassicurante convinzione che “noi” e “loro” siano due discorsi distinti, che possiamo considerarci testimoni neutrali di storie altrui e non parte attiva, come in realtà siamo in molteplici sensi nei condizionamenti che determiniamo, a partire dallo sguardo che agli altri rivolgiamo, che è l’oggetto a cui circoscrivo le mie notazioni.
Brutti, sporchi e colpevoli.
«Protestiamo contro l’ingresso nel nostro Paese di persone i cui costumi e stili di vita abbassano gli standard di vita americani e il cui carattere, che appartiene a un ordine di intelligenza inferiore, rende impossibile conservare gli ideali piú alti della moralità e civiltà americana»: è una dichiarazione del 1911 della commissione Usa per l’immigrazione2. Dieci anni prima dell’entrata in vigore di leggi restrittive e dell’insorgenza del timore di un «suicidio razziale»3.
Quelle persone eravamo noi, gli italiani emigrati. «La feccia del pianeta», «maledetta razza di assassini», «sporchi come maiali», «mendicanti per il piacere di mendicare», un «fagotto di stracci provenienti dalle macerie di paesi impoveriti che sciupano la bellezza di Manhattan», «rubano il lavoro», «insistono sull’aiuto come se gli fosse dovuto», e ridurranno New York a «una colonia penale per i rifiuti dell’Italia». Al massimo, nello slancio di una pelosa compassione, «povero bestiame muto e manipolato», «macaroni (mangia-pasta)» o «cantanti».
Cosí, in larga misura ci consideravano non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i Paesi d’oltreoceano ed europei dove tra fine Ottocento e metà del secolo scorso sono espatriati quasi 23 milioni di italiani4, dei quali circa 4 milioni approdati ai piedi della Statua della Libertà di Ellis Island. Ovunque indesiderati, guardati con sospetto, vilipesi, emarginati e discriminati. In Svizzera, fino a cinquant’anni fa ci accoglievano i cartelli «Vietato l’ingresso ai cani e agli italiani» affissi sulle vetrine di bar e ristoranti. La peggior fama di criminali e fannulloni l’avevano i meridionali. I primi a disprezzarli e rimarcare la «diversità di razza» erano i connazionali del Settentrione, cosa che del resto ci suona familiare in casa nostra. Con la differenza – talvolta la Storia si diverte – che l’anglosassone Dictionary of Race and People tracciava lo spartiacque tra Nord e Sud del mondo dal 45° parallelo nord che attraversa la Pianura padana e taglia in due Torino, cosicché «terroni» valeva in pratica per tutti gli abitanti della Penisola. In dubbio era messa perfino l’appartenenza dei latini alla razza bianca. In Australia, ammonendo le donne autoctone a non contrarre unioni contaminanti e “disgustose” con noi, ci chiamavano «pelle-oliva» (lombardi, piemontesi, veneti inclusi). In Louisiana, ritenuti in odore di niggers, ci era precluso l’accesso alle scuole dei bianchi.
A rovescio, dal canto nostro abbiamo coltivato il mito eroico-romantico di noi brava gente – intraprendenti, onesti, pieni di ingegno e talenti, lavoratori indefessi e grandi latin lover, riamati, apprezzati e premiati dal successo – estrapolando storie di pochi dalla maggioranza dei tanti in fuga un po’ da guerre e molto dalla povertà, taglieggiati dai Caronte nostrani dell’epoca e vissuti in dure e dolorose condizioni di miseria e degrado. Tra vizi piú o meno fasulli e supposte virtú, di quei tempi – e non è nemmeno del tutto immeritato – ci portiamo ancora cuciti addosso mafia e spaghetti, un’icona che perfino il cinema stenta ad archiviare. Ricambiamo con la figura degli americani un po’ sempliciotti e sprovvisti di pedigree pari al nostro. Ma a distanza di cent’anni tra le due sponde dell’oceano giochiamo a ping pong con cliché tutto sommato innocui. Siamo indiscutibilmente bianchi e dalla stessa parte. Gli estranei sono altri.
Sovente il richiamo al nostro passato, noi ieri come loro oggi, punta a far leva su principî di pietas e solidarietà, trascurando il fatto che ciò che si paventa ha di norma la meglio sia sulle corde del cuore sia sui fili del raziocinio. Rispetto alla somiglianza di vicende umane, piú pregnante è la ripetitività di espressioni xenofobe e ritratti spregiativi nei quali non ci riconosciamo ma si pretende di conoscere gli stranieri di turno. I migranti ci rimettono in panni, in stracci già indossati che adesso ci svolazzano intorno come fantasmi gemelli. La «paura della peste»5, la chiama la psicoanalista Gabriella Mariotti: la peste di un mondo di sofferenza, fame, persecuzioni, solitudine, che si vuole rimuovere; di beni da spartire e standard di benessere a cui si potrebbe essere costretti a rinunciare; di subire una destabilizzazione culturale, senza preoccuparsi troppo di quale cultura ci si possa far vanto. In controluce, la peste di sensi di colpa, per la propria agiatezza o per pregressi torti inflitti ad altri, come in effetti è accaduto (e ancora l’elaborazione non è finita) agli americani che devono riconoscere di avere sopraffatto i nativi; o la peste della paura dell’invidia distruttiva che i nuovi arrivati potrebbero nutrire, spia della propria invidia verso chi ha o aveva di piú – come è avvenuto ad esempio, nel nostro caso, attribuendo l’avidità agli ebrei, ricchi e potenti, per validare l’antisemitismo.
Nelle paure, fatti reali ed elementi di verità si intrecciano a forzature, invenzioni e inevitabili distorsioni di prospettiva nel momento in cui ci si trova alle prese con civiltà differenti dalla propria. Le diversità, altri modi di essere, di sentire e di pensare, esistono. Oltre al nostro tempo imperfetto, ora come allora, il contatto fa riaffiorare primordiali ansie intollerabili e altrettanto ataviche e universali istanze narcisistiche di autostima. I nuovi arrivati ci pongono due questioni eterne e basilari: come far fronte alle nostre paure e come riuscire a mantenere livelli elevati di autocompiacimento. Una soluzione da sempre la offrono idee preconcette e stereotipi basati su semplificazioni, generalizzazioni, associazioni e relazioni causali arbitrarie che permutano la verità con la piú comoda ovvietà dei luoghi comuni.
Quanto piú occorre sentirsi al riparo da pecche e debolezza, forti e con la coscienza pulita, dalla parte della ragione, sentirsi insomma i migliori, tanto piú c’è bisogno che gli altri restino, come è toccato anche a noi, “brutta gente”. Un’altra razza.
Questa è un’idea di chiara, semplice evidenza per il senso comune. Al contrario, il concetto di razza è stato definitivamente archiviato dalla scienza da almeno vent’anni. Sappiamo di venire tutti dalla stessa culla africana, di discendere da incroci e migrazioni, che le differenze sono minime e superficiali. Abbiamo il 99,9 per cento del patrimonio genetico in comune, con una variabilità interna a ogni popolazione superiore a quella tra popolazioni distinte, e senza gli spostamenti di popoli dal Medio Oriente e dalla Russia di 7000-8000 anni fa, noi europei saremmo di pelle scura. La razza è un mito, «una delle forme piú distruttive e potenti di categorizzazione sociale»6, una categoria essenzialmente vuota che viene riempita da vari tipi di proiezioni, consce e inconsce, idealistiche del gruppo di appartenenza, o di parti scisse negative riservate agli altri. Non esiste, non è mai esistita se non in un delirio di grandezza, una razza ariana7. Né bianca, gialla, rossa o nera. Non c’è nessuna diversità originaria, nessuna corrispondenza innata fra tratti fisici – colore della pelle, lineamenti, morfologia somatica – e caratteri intellettivi e morali8. Nulla autorizza a pensare che esistano “per natura” razze superiori e razze inferiori.
Dei fantasiosi e terribili postulati di purezza e suddivisioni razziali per doti e tare dell’eugenetica di Gobineau, Galton, Cartwright e tanti altri, resta esclusivamente il valore di testimonianza del veleno che infondate teorie pseudoscientifiche hanno aggiunto alle dottrine razziste. Il teschio del contadino calabrese – «di cute oscura […] tutto stortilato»9, incarcerato per sospetto brigantaggio (pare per il furto di cacio e pane) – che Cesare Lombroso teneva orgogliosamente sulla scrivania non è che la prova dell’assurdità della tesi che zigomi sporgenti, mandibole possenti, grandi denti canini e la famosa «fossetta occipitale mediana» segnino un fatale, ed ereditario, destino di criminale. In compenso, la certezza di un’elevata concentrazione al Sud delle malefiche fossette del padre della criminologia, che peraltro ebbe l’onestà intellettuale di rivedere alcune sue concettualizzazioni, diede un fiero e dannoso sostegno all’ideologia di un Meridione nato e condannato a restare sotto il segno del meno.
Tutto ciò è, o dovrebbe essere, ampiamente acquisito. Infatti, a nessuno piace sentirsi chiamare razzista, derivato di un termine che ormai implica ignoranza (perfino chi nutre di fondo l’idea di una supremazia dei bianchi rifiuta di definirsi tale). Cosí, al posto della razza è subentrata l’etnia, una nozione in teoria piú flessibile, ma di fatto intesa in maniera affine quando non equivalente per demarcare distinzioni mutualmente esclusive. Se le differenze biologiche erano incontestabili, quelle di valori e costumi sono parimenti vissute come insormontabili. Ben lungi dalle moderne acquisizioni dell’epigenetica sulla modulazione dell’espressività genica a opera dell’ambiente – per cui ad esempio deprivazione affettiva e povertà possono avere impatti su una serie di processi fisiologici per generazioni – in un singolare ibrido di congenita, inalterabile diversità culturale che utilizza e mescola entrambi i carburanti (biologia e cultura), si ricostruiscono le gerarchie e si rianimano gli stessi stereotipi e giudizi a priori, le stesse fantasie.
Che sia scritto «nel DNA», «nel sangue» o nell’identità culturale, la coincidenza di bruttezza dentro e fuori – immoralità, inerzia, inettitudine, inaffidabilità, indole violenta o truffaldina, barbarie legate a colore della pelle, religione, status economico-sociale, nazionalità – è alla base di credenze saldamente radicate in costrutti interni. Bel volto uguale bell’anima – paradossalmente ispirato alla concezione di bellezza dell’antica Grecia, intesa come inseparabilità di armonia e giustizia, decisamente alleggerita del peso del secondo polo nel consolatorio slogan contemporaneo «ci salverà la bellezza»...