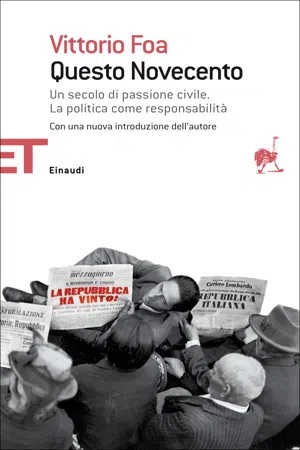![]()
Nel linguaggio politico corrente il centrosinistra è quell’alleanza di democristiani e socialisti che ha governato l’Italia per quasi tutti gli anni sessanta. È stata un’esperienza importante. Ha comportato la liquidazione definitiva del centrismo, che era stato espressione non solo politica ma anche civile e sociale della guerra fredda, con un soffocante monopolio della destra cattolica, l’emarginazione del mondo del lavoro e la riaffermazione continua della spaccatura del paese. Centrosinistra voleva anche dire fine della lunga dipendenza dei socialisti dai comunisti, riemergere del partito socialista come riconoscibile soggetto politico, impaziente di governare avviando una politica di riforme. Per i democristiani centrosinistra voleva dire apertura a sinistra che significava anche una rottura della sinistra: l’inclusione dei socialisti e l’esclusione dei comunisti.
Esaminiamo quell’esperienza piú da vicino, nelle intenzioni e nella realtà. Di esso si possono dare, e ne diamo, diverse letture. Vi leggiamo la proiezione in Italia dei cambiamenti nel mondo, con l’inizio della distensione fra le grandi potenze e l’attenuazione di quella aspra e pervasiva contrapposizione – nei fatti come nel linguaggio – che prese il nome di guerra fredda. Si tratta di una lettura attraente perché connette la nostra situazione con quella degli altri paesi. Si può anche pensare il centrosinistra come una consapevole modernizzazione del maggior partito di governo, la democrazia cristiana: essa prende atto che è svanita la sua base sociale tradizionale nel mondo contadino e che è avanzato, con nuove pretese, il ceto medio urbano. Capisce che le cose sono cambiate, coglie le difficoltà di una migrazione interna di massa, la ricollocazione territoriale (verso il nord-ovest) dell’iniziativa e del potere economico. E per la prima volta, dopo tanta presunzione negli anni cinquanta, vede gli squilibri che accompagnano lo sviluppo, che anzi ne sono figli. Naturalmente si può anche dire, con ovvia grossolanità, che la democrazia cristiana ha deciso l’alleanza coi socialisti solo per conservare il suo potere, la sua egemonia minacciata sul piano elettorale e che questa era la sola cosa che le stava a cuore.
Vi sono poi altri modi di leggere il centrosinistra. Si può vedervi una maturazione del partito socialista, il suo tanto auspicato allineamento con le grandi socialdemocrazie europee e quindi un passo avanti dell’Italia verso l’Europa. Oppure, al contrario, una fortunata operazione capitalistica per «integrare», cioè ricondurre sotto controllo, associando i socialisti al governo, una classe operaia diventata troppo agitata. O ancora, si può avanzare una verosimile lettura culturale: di liberazione da una asfissiante atmosfera clerico-moderata, quella nella quale un ministro degli Interni come Mario Scelba poteva appunto descrivere gli intellettuali come «culturame». Ognuna di queste letture contiene elementi di verità. Nel loro insieme esse dimostrano l’impossibilità di fare discendere il centrosinistra da una causa specifica. È certo che esso fu un tentativo di allineare l’Italia a un mondo in movimento, alle sue aperture e alle sue nuove contraddizioni. Esso si presenta come una promessa il cui risultato, secondo un giudizio prevalente, è quanto meno controverso.
Sono molti i cambiamenti nel mondo che hanno influenzato il processo politico italiano. Cominciamo col monolito comunista e le sue crepe. Fino alla metà degli anni cinquanta esso era stato un fattore di rigidità, causa di guerra fredda dentro ogni paese. La denuncia degli errori e poi dei crimini di Stalin, la crisi polacca e soprattutto l’insurrezione operaia ungherese del 1956, schiacciata con armi sovietiche, aveva incrinato quella rigidità senza scioglierla: i comunisti occidentali persero colpi ma confermarono tutti la loro disciplina verso l’Urss. Una frattura seria, tale da scuotere l’immaginazione delle sinistre fu, nei primi anni sessanta, lo scontro tra Russia e Cina e quindi tra i due piú grandi regimi comunisti del mondo. Ho potuto verificare di persona, a Pechino nel giugno del 1960, l’inizio di quella frattura. Ero in Cina per una riunione sindacale. I cinesi non attaccarono ancora direttamente i sovietici ma riversarono tutte le loro contumelie sui sindacalisti occidentali «servi del capitale». Tornai a casa convinto che la vera rottura era con i russi ed era profonda e duratura. Era un conflitto di potere tra due stati ma si ammantava di ideali. I cinesi criticavano il comunismo burocratico sovietico, il primato dell’industria pesante e centralizzata e la disattenzione verso i contadini. L’economia sovietica era denunciata come una variante della divisione capitalistica del lavoro. I cinesi proponevano una mobilitazione totale del lavoro, ugualitaria e dal basso, in ogni punto dell’immenso paese. Fu la linea del «grande balzo in avanti» che portò la Cina a un disastro economico totale. Vedevo con i miei occhi la carestia a Pechino. Ma l’immaginario della sinistra occidentale era piú forte dell’esperienza empirica. Di fronte al monolite burocratico russo, la Cina sembrava offrire spiragli di libertà. Su un piano piú realistico, la divisione del comunismo mondiale sollecitò chiaramente i socialisti a separarsi dai comunisti.
Grande influenza ebbe anche un altro evento politico che gli italiani osservarono da vicino. Penso alla elezione a pontefice di Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII. Eugenio Pacelli (Pio XII) era morto nel 1958. Già prima della morte il suo carisma, fatto di rigore e di aristocratico distacco, si era esaurito. Ma la sua politica anticomunista e antisocialista era ancora intatta nella Curia, dominata dal cardinale Ottaviani e nell’episcopato italiano sotto la guida del cardinale Siri. Roncalli non era un grande borghese come Pacelli, era, e si sentí sempre, un contadino delle valli bergamasche. Non aveva una carriera brillante come il suo predecessore: Pacelli, oltre che nunzio apostolico nella Germania hitleriana, era poi stato a lungo segretario di stato; Roncalli aveva servito una diplomazia vaticana minore, era stato in Bulgaria e Turchia durante la guerra e poi in Francia; quando fu fatto papa era patriarca di Venezia. Di lui nel mondo politico italiano non sapevamo nulla, ci dissero che da giovane aveva difeso la libertà sindacale e che era antimoderno, non voleva che i preti guardassero la televisione, che proprio allora si affacciava trionfante sul mondo. Ma il nuovo papa fu per tutti una rivelazione, il suo linguaggio toccava il cuore del suo prossimo, uomini e donne di ogni età. Il linguaggio ebbe influenza politica proprio perché non era politico ma pastorale e spirituale. La politica italiana fino al 1961 non cambiò. Tutta la Chiesa si oppose con ogni mezzo al centrosinistra in formazione. Solo dopo le agitazioni popolari dell’estate 1960, cui parteciparono moltissimi lavoratori cattolici, il vento cambiò. Allora si affermò per la prima volta a chiare lettere il non intervento della Chiesa nelle questioni interne italiane, l’Azione cattolica tornò alla religione, Luigi Gedda e i comitati civici si tolsero di mezzo. Ma l’influenza di Papa Giovanni sulla politica italiana fu indiretta e, secondo me, grandissima. L’immagine della Chiesa romana, che Pacelli aveva reso cosí strettamente politica e di parte, proponeva adesso orizzonti spirituali e universali. La sinistra italiana ne fu colpita. Dopo la seconda guerra mondiale, nella rinata democrazia, i dirigenti della sinistra si erano molto impegnati a dissolvere il vecchio anticlericalismo ereditato dalla rivoluzione unitaria e dalla breccia di Porta Pia. Dal linguaggio politico l’anticlericalismo era scomparso fino al punto (francamente eccessivo) di rimuovere ogni critica al rapporto fra Chiesa e fascismo. Non cosí nel cuore dei militanti di sinistra che avevano vissuto, spesso come cristiani, l’aggressione politica della Chiesa contro di loro.
Adesso il clima era diverso, la parola del papa frenava la destra e rasserenava la sinistra. Nelle sue encicliche (ricordo la Mater et Magistra del maggio 1961 e soprattutto la Pacem in Terris dell’aprile 1963) l’apertura del papa verso tutte le religioni aveva un significato che andava oltre la sfera religiosa. Adesso il papa distingueva le false posizioni filosofiche dai movimenti che ad esse si ispiravano, la condanna delle posizioni filosofiche risparmiava i movimenti reali: si riscopriva il principio della tolleranza. Ricordo la sera che Papa Giovanni morí, il 3 giugno 1963. Mi fu impossibile non unirmi a tutti gli altri romani in silenzio sulla strada che portava a San Pietro.
In quei primi anni sessanta ci sono altri personaggi-simbolo di cambiamenti positivi. Naturalmente penso al presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy. La sua breve esperienza di governo si presentò ai fautori del cambiamento carica di possibilità. La condotta americana verso l’Italia, che era un pezzo del tutto secondario, della politica internazionale, cambiò lentamente. Kennedy era favorevole in sostanza all’ipotesi di centrosinistra, contrariamente al segretario di stato, Dean Rusk. Ma anche in questa circostanza, in ultima analisi, prevalse il sí. Nei momenti in cui Kennedy dovette affrontare acute tensioni, come nell’agosto 1961 durante la costruzione del Muro di Berlino o un anno dopo con la crisi dei missili cubani e la minaccia americana di un blocco navale, l’impressione era che non si trattasse di passi verso la guerra bensí di ostacoli che i nostalgici stalinisti ponevano a un processo di distensione. Vorrei ancora ricordare il generale De Gaulle che salí al potere in Francia nel 1958 su un’ondata colonialista e che poi invece, al principio del decennio successivo, riconobbe l’indipendenza dell’Algeria e anche quella delle ex colonie a sud del Sahara. E di là dell’Atlantico nel 1959-60 la rivoluzione castrista offriva ancora un’immagine democratica e insieme di orgogliosa difesa della propria indipendenza diventando subito un modello per l’America Latina umiliata fra sfruttamento neocoloniale e tirannie indigene. Nell’insieme era un quadro di fermenti di democrazia ben diverso da quella che era stata chiamata l’Europa «carolingia» degli anni cinquanta.
Passiamo adesso dal quadro esterno a quello interno. È il lungo travaglio della democrazia cristiana insieme con il lungo travaglio del partito socialista, il tutto dentro uno sviluppo economico senza precedenti (il «miracolo economico») con forti squilibri e nuove elaborazioni politiche. Alla fine degli anni cinquanta la democrazia cristiana temeva l’instabilità. Con la crescita delle correnti comparvero anche i «franchi tiratori», cioè parlamentari democristiani che nelle votazioni a scrutinio segreto votavano contro il governo. Di qui l’intrusione nella maggioranza delle destre monarchica e neofascista che sostennero i governi di Zoli e di Segni e poi, in modo aperto, quello di Tambroni. La crisi e la caduta del governo Tambroni nell’estate del 1960 sono fuori del solito gioco interno della democrazia cristiana. Ci furono, come sempre, intrighi e manovre, ma gli elementi dominanti furono gli scioperi, la partecipazione di molti lavoratori cattolici e la risposta feroce del governo: la polizia sparò uccidendo alcuni scioperanti. Chi allora analizzava gli scioperi, quello di Genova contro il congresso del Movimento sociale e poi quello generale dopo gli eccidi, vi scorgeva una volontà che andava oltre gli obiettivi dichiarati. Due cose erano chiare. Prima di tutto l’eccezionale partecipazione di giovani e giovanissimi. A Genova apparvero decine di migliaia di «ragazzi con le magliette a strisce»: non era un’uniforme, i ragazzi portavano quelle magliette e secondo il costume giovanile si vestivano tutti uguali. La loro scatenata allegria, la loro gioia di muoversi insieme, quella protesta cosí alta che sembrava toccare il cielo, aveva un significato: basta con la politica incomprensibile, ci siamo anche noi, vogliamo capire e dire anche la nostra. E qui s’inserisce anche un’altra questione: l’antifascismo. I governi centristi avevano continuato a onorare la Resistenza e l’antifascismo, era una necessaria demarcazione a destra, ma erano onoranze tutte ufficiali e burocratiche, senza anima, senza consapevolezza critica. Per parte sua la sinistra coltivava la memoria resistenziale e antifascista come una sua proprietà privata, quasi come memoria di una vittoria tradita. Adesso era diverso. L’antifascismo era rivendicato dai giovani e giovanissimi come un valore del futuro. Quel movimento, ne sono convinto, non serví solo a risolvere una crisi di governo, fu una forte spinta alla svolta politica. La democrazia cristiana non riusciva a reggere un’aperta svolta a destra. Il paradigma antifascista era ancora il punto di riferimento della repubblica. Ma per l’apertura a sinistra ci volle ancora un bel po’ di tempo. I dorotei che frenavano, insieme con Moro le tendenze di riforma, non erano però sicuri della loro maggioranza. Di qui la lenta formazione dell’alleanza Moro-Fanfani, che portò al centrosinistra. La motivazione storica della nuova politica non poteva ridursi all’attivismo riformatore di Fanfani, occorreva un orizzonte piú vasto. L’anno della costruzione fu il 1961. I discorsi e le relazioni congressuali del segretario del partito, Aldo Moro, furono sempre singolarmente prive di contenuto, fiumi di parole per giustificare il «non fare», il rinvio, ma già allora era possibile riconoscere l’apporto di uomini di pensiero cui il partito seppe dare ascolto. Penso ad Ardigò e a Saraceno, alla piena consapevolezza del definitivo tramonto della società contadina sulla quale il partito si era fondato, e quindi dell’urbanizzazione, della crescita impetuosa del ceto medio urbano e soprattutto degli squilibri dello sviluppo, dal rapporto nord-sud al disagio metropolitano, alla migrazione di massa, alla dislocazione produttiva. L’intervento pubblico trovava adesso la sua piena giustificazione e con esso la necessità di un incontro a sinistra. Ma già nei governi di Fanfani prima del centrosinistra si avvertivano segnali importanti di movimento. Ricordo la capacità progettuale e operativa di Fiorentino Sullo come ministro del Lavoro e poi, soprattutto, come ministro dei Lavori Pubblici.
Ora, qualche parola sul duro travaglio dei socialisti, di fronte a quella svolta. La domanda che turbava i militanti e occupava i discorsi dei dirigenti era questa: l’operazione di Fanfani e di Moro è (come allora si diceva) una vera apertura a sinistra o non è piuttosto una divisione della sinistra per aumentare o almeno consolidare il potere democristiano? Era molto diffusa fra i socialisti la sensazione che non si trattava di una vera apertura ma di un’emarginazione di una parte consistente del mondo del lavoro, di quel mondo che stava trasformandosi e mostrando disponibilità e capacità innovative. Il travaglio socialista ha ritardato e indebolito l’apporto socialista nella nuova alleanza? Forse ha compromesso la stessa alleanza? Me lo domando ormai da molti anni dato che di quel travaglio, di quei dubbi, sono stato attivo partecipe. Pensavo allora (e ne scrissi molto su «Mondo Nuovo», organo della sinistra socialista diretta da Lucio Libertini) che la borghesia industriale italiana, investita da lotte operaie intense e anche di imprevedibile portata per i loro aspetti innovativi, si trovava a dover scegliere tra due vie: quella tradizionale, della negazione e quindi della repressione e quella, essa pure in qualche modo tradizionale, dell’alleanza progressista con una parte del movimento operaio. Mi veniva in mente Giovanni Giolitti e, piú in là, la monarchia di luglio, il 1830 francese. Il centrosinistra mi appariva quindi come la risposta della parte piú intelligente della borghesia alla tensione sociale crescente. Questa analisi aveva mille riscontri fattuali. Ne citerò uno solo. Nel luglio 1962, dopo una lunga passività, gli operai della Fiat tornarono allo sciopero. La sera stessa Vittorio Valletta, capo della Fiat, noto per la sua tenacia anticomunista e antisocialista, disse: qui ci vuole un centrosinistra; e, per incoraggiare i democristiani si adoperò perché quella frase venisse a conoscenza di tutti.
A distanza di anni può sembrare strano ma quella analisi della borghesia progressista mi portava a rifiutare il centrosinistra. I socialisti che la pensavano cosí, quasi tutti assorbiti dall’impegno sindacale, non erano mossi da rispetto per i comunisti, di cui anzi criticavano ideologia e comportamenti, essi pensavano solo all’unità del mondo operaio e quindi alla sua efficacia. Il risultato fu la scissione del partito socialista. Il rifiuto della nuova alleanza, con le sue diverse motivazioni, fu del 40 per cento del partito. La scissione rese piú facile il cammino a Nenni, ma ne compromise il risultato.
Il centrosinistra divise veramente socialisti e comunisti? Col passare degli anni i dubbi crescono. I socialisti sostennero, senza entrarvi ma concordando il programma, il governo Fanfani del 1962 e poi entrarono in forze nei governi diretti da Moro: i comunisti votarono contro. Ma è difficile cogliere una vera opposizione comunista. A partire dai primi anni sessanta e per tutto il decennio furono i socialisti a guidare la sinistra italiana e i comunisti non fecero che adattarsi, seppure sempre in difficoltà e in ritardo. Il capitalismo era sempre negato su un piano ideologico ma di fatto si doveva entrare in cento modi in rapporto con esso. L’intervento statale selettivo poteva sempre essere tacciato di neocapitalismo ma nei fatti i comunisti lo accettarono e lo promossero. Anche il distacco dall’Unione Sovietica, che nel 1956 era stato anticipato dai socialisti, e anche argomentato come difesa della democrazia, sarebbe maturato solo con enorme ritardo nel partito comunista. Se i comunisti, prendendo gradualmente le distanze dall’Urss, rimasero sempre (o almeno fino alla svolta di Occhetto del 1989) alla superficie tattica del problema, ciò dipese forse dal fatto che si trattava di una politica di assecondamento, i francesi direbbero di suivisme, nei confronti dei socialisti.
Nelle elezioni politiche però il partito socialista non riuscí mai a superare la quota del 15 per cento, piú o meno quella cui si era ridotto dopo i tragici errori del 1947-48. Di qui il divario a sinistra fra dato elettorale e influenza politica. I comunisti ebbero sempre molti piú voti dei socialisti anche quando la loro politica era priva di mordente. In alcune belle pagine della sua Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Paul Ginsborg spiega l’apparente contraddizione di un partito comunista cui non si consente di (o che non vuole) governare il paese ma che governa in modo esemplare, pulito ed efficace regioni, province e comuni. È la natura di questo governo che spiega il suo successo: è tutto proteso sugli amministrati, non appiattito sui loro bisogni dichiarati, ma con una selezione che spinge verso l’alto, verso una consapevolezza. Nella sfera decentrata la vocazione di governo è piú libera. Naturalmente la gente di potere ha sempre escluso i comunisti dichiarandoli diversi. Ed essi hanno accettato questa diversità, e l’hanno persino rivendicata.
Ma quali conseguenze comportò l’influenza politica dei socialisti? A parte il tentativo, del resto fallito, del compromesso storico, e fatte salve le radicali differenze morali, è possibile leggere una qualche continuità nella percezione socialista della politica dagli inizi del centrosinistra fino alla morte suicida del partito nel 1992. Il mondo morale di Nenni sicuramente era l’esatto opposto di quello di Craxi: Nenni credeva nel socialismo come sviluppo della grande tradizione democratica e repubblicana. Ma proprio mentre fu autore (e simbolo) della svolta degli anni sessanta, Nenni disvelava la sua concezione del potere politico, una concezione elementare, attraente per la sua facilità e non priva di una certa verità: il potere era la presenza nel governo, la possibilità di gestire. Il solo fatto che i socialisti entrassero nel governo cambiava il quadro politico, lo schieramento era tutto, i contenuti sarebbero venuti poi. Naturalmente il linguaggio non era tutto cosí elementare, stavano prendendo forma discorsi nuovi sulle riforme, sulla pianificazione. Ho ricordato i cattolici, ricordo adesso i socialisti Lombardi e Giolitti, il repubblicano Ugo La Malfa, gli amici del «Mondo» di Mario Pannunzio e poi anche un crescente sindacalismo critico. Ma il linguaggio prevalente, quello della maggioranza socialista, era quello della presenza: è una novità storica, i socialisti non sono mai stati nel governo (i governi di unità nazionale del 1944-47 erano considerati fuori della storia), adesso tutto doveva cambiare. Quel primato della presenza nel governo doveva sopravvivere a tutte le delusioni del centrosinistra. Nel 1964 Nenni aveva battezzato l’entrata nel governo del partito socialista in modo disarmante: «Siamo entrati nella stanza dei bottoni». A pensarci bene quella banalità non era specifica dei socialisti, apparteneva a tutta la sinistra. I comunisti la praticavano intensamente: era la cultura eucaristica della transustanziazione, la «propria» presenza, il tocco della «propria» mano cambiava la natura della politica. Questa visione iperpolitica della convivenza civile, questa rappresentazione della politica come pura gestione e distribuzione delle risorse si sarebbe ritrovata, in un quadro moralmente opposto a quello di Nenni, nel modello socialista degli anni ottanta calando un’ombra criminosa sulla politica. Viene da sorridere dell’ingenuità di Vittorio Valletta, capo della Fiat, che durante la visita in Italia del presidente Kennedy nel 1963 si disse favorevole a un governo di centrosinistra ma consigliò il presidente americano, se proprio voleva dare finalmente dei soldi anche al partito socialista, che glieli desse attraverso la democrazia cristiana!
Nel partito socialista non c’era solo Pietro Nenni con la sua idea astratta del potere. C’era anche Riccardo Lombardi, singolare combinazione di pragmatismo e di idealismo, tutto proteso a dare al centrosinistra un forte contenuto di riforme, E c’era Antonio Giolitti, che avrebbe dato alla politica delle riforme una dimensione piú organica e operativa, quella della programmazione. Per Lombardi il governo aveva senso solo se era socialmente mirato, cioè se voleva cambiare le cose. Con le riforme e con la programmazione, i socialisti si incontravano in modo positivo coi riformatori cattolici e con quelli laici, tutti profondamente sensibili agli squilibri territoriali, sociali e culturali cui il rapido sviluppo del paese apriva la strada. Con Lombardi ebbi un confronto pubblico al congresso socialista di Napoli del 1959. Fu un confronto significativo perché segnò le diverse strade che avremmo percorso dopo tanti anni di amicizia e contiguità, strade diverse che forse, entrambe, avrebbero mostrato la loro debolezza appunto perché unilaterali. Il primato del governo delle riforme per Lombardi, quello della partecipazione operaia e popolare per me. Lombardi naturalmente credeva nella partecipazione popolare alle riforme ma l’accento era tutto posto, con un taglio illuministico e in qualche modo giacobino, sulle decisioni dello stato; per parte mia credevo naturalmente nelle riforme come azione di governo ma davo un taglio prioritario e quindi illusorio al movimento di lotta trascurando la compiutezza e la stabilità delle soluzioni legislative. Forse una maggiore combinazione dei due elementi avrebbe dato piú spazio ai socialisti nel centrosinistra. Pensandoci adesso, a cose fatte, cosa voleva dire una piú esplicita partecipazione? Cos’era quell’insistenza mia e di altri come me sulla priorità da dare al «movimento», alle lotte della «base» popolare, operaia, contadina e intellettuale? Oggi mi appassiona l’idea che la sinistra avrebbe potuto allearsi coi riformatori Lombardi e Giolitti e impedire a Nenni quella «deriva» nel vuoto che egli ha imposto al partito socialista. Ma, appunto, cosa impediva a me e a quelli come me, di tentare una scelta cosí ragionevole e promettente? Ci doveva essere qualcosa di diverso, di profondamente diverso, nell’analisi della realtà. Vi tornerò subito, ma prima voglio dire qualche parola sulla scissione socialista del gennaio 1964 e della nascita del Psiup, partito socialista di unità proletaria, nato al momento della formazione del primo governo Moro.
Il Psiup era una realtà composita, punto di incontro di esperienze molto diverse tenute forse insieme da quella parola magica, la «sinistra». Due personaggi di collaudata indipendenza davano dignità al partito: penso a Lelio Basso, immune da contaminazioni staliniste e per questo già...