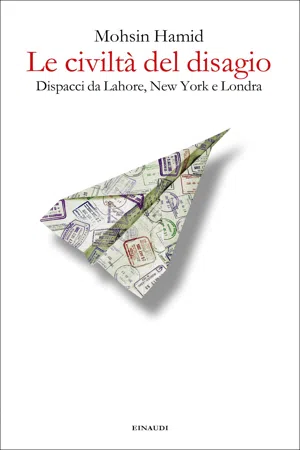![]()
![]()
![]()
Ricordo il momento in cui, da bambino a Lahore, scoprii che il Pakistan era diventato, ancora una volta, l’alleato degli Stati Uniti. Ero con mio cugino davanti alla casa di mio nonno. Pioveva, e sul prato c’erano tre centimetri d’acqua. Armati di tre mattoni, noi due stavamo combattendo contro la natura. Io mettevo giú un mattone e ci salivo sopra, mio cugino saliva su quello che io avevo lasciato libero e poi mi passava quello su cui era stato fino all’istante prima. Avevamo quasi finito la traversata quando mia madre ci disse di rientrare. Gli adulti stavano guardando il telegiornale. Mi spiegarono che adesso eravamo alleati degli Stati Uniti contro i sovietici in Afghanistan. Fico, pensai. Stavamo coi bravi e avremmo vinto. Avevo visto abbastanza cartoni animati e film da non avere dubbi in proposito.
La guerra continuò per tutto il resto della mia infanzia, ma era perlopiú una cosa distante, remota. Però crescendo cominciavo a rendermi conto che stavano accadendo cose bizzarre. Il nostro dittatore teneva discorsi in cui parlava di trasformare il Pakistan in una società basata sulla sua personale interpretazione dell’Islam. Sul retro degli autobus, sotto le parole «Dio è grande», si vedevano immagini dipinte di F-16 che avevamo ricevuto dagli Stati Uniti. Studenti universitari armati intimavano alle donne di coprirsi il capo.
Subito dopo la sconfitta sovietica, andai a studiare negli Stati Uniti. Sorprendentemente, pochi fra gli americani di mia conoscenza consideravano il Pakistan un alleato. E meno ancora erano quelli che sapevano dov’era. Dopo la guerra, gli Stati Uniti ci avevano voltato le spalle. Gli aiuti e le forniture militari erano stati sospesi. I miei amici a casa erano sbalorditi. Io, vivendo negli Stati Uniti, ero meno stupito. In America i luoghi sconosciuti e tenebrosi del resto del mondo sono schermi bianchi: vi si possono proiettare le saghe del male con la stessa facilità delle saghe del bene.
Ora il Pakistan viene trascinato ancora una volta in prima linea. In Pakistan c’erano già tensioni fra i diplomati delle madrase religiose e quelli delle scuole statali e private. Ma, dopo l’ultima guerra in Afghanistan, il paese si stava sforzando di raggiungere un compromesso fra questi gruppi contrapposti. È un genere di compromessi che matura lentamente, e viene alimentato dalla stabilità. Nell’agire adesso, gli americani devono considerare quali conseguenze avrà proiettare un film di guerra su quello che non è affatto uno schermo bianco. Devono avere compassione mentre valutano quale impatto avrà radicalizzare milioni di persone in nome della giustizia. In Pakistan, i miei amici e parenti sono spaventati, com’è giusto che sia quando il piú potente esercito del mondo viene dispiegato per svolgere un compito che spetterebbe piuttosto agli insegnanti, alle forze di polizia, alla persuasione e al tempo.
2001.
![]()
Quando nel 2004 mi recai per un reportage nella burrascosa provincia pachistana del Belucistan, mi aspettavo di trovare un certo astio nei confronti del governo centrale di Islamabad. Il Belucistan era in preda a un’insurrezione a bassa intensità con cui le popolazioni tribali chiedevano maggiore autonomia per la provincia. Pochi giorni prima del mio arrivo, in un attentato dinamitardo in una strada del villaggio di pescatori di Gwadar, erano rimasti uccisi alcuni ingegneri cinesi che lavoravano a uno dei piú avanzati progetti di sviluppo del Pakistan: un gigantesco nuovo porto. Perciò mi stupí vedere a Gwadar dei bambini che giocavano a cricket indossando la maglia della nazionale pachistana. Di fatto, l’unica ostilità che dovetti affrontare fu quella degli aggressivi agenti segreti che mi interrogarono in malo modo minacciando di requisirmi la macchina fotografica.
Piú tardi, sentendo che mi lamentavo al telefono del trattamento ricevuto, un negoziante mi invitò a pranzo a casa sua. «L’esercito ci manca di rispetto, – mi disse. – Portano via i nostri giovani e li picchiano senza motivo. Siamo pachistani, ma ci trattano come stranieri». E lo stesso, secondo lui, faceva il governo centrale. «Nessuno dei posti di lavoro al porto è stato assegnato a gente di Gwadar, – aggiunse. – Stanno spendendo miliardi di rupie, ma per noi non hanno costruito nemmeno un ospedale decente». Al pari dei bambini che giocavano a cricket, sembrava ritenersi molto pachistano. Ma pativa la mano pesante mostrata da Islamabad e lo spiegamento di truppe per imporre decisioni dall’alto. Lasciai Gwadar sentendomi piú solidale con i beluci e il loro desiderio di avere maggiore voce in capitolo in ciò che li riguardava.
A due anni di distanza, l’insurrezione in Belucistan è cresciuta. E l’annuncio da parte dell’esercito di aver ucciso la scorsa settimana Nawab Akbar Khan Bugti è segno che i militari non capiscono che le loro tattiche bellicose non fanno che peggiorare la situazione. Bugti era un leader ribelle e uno degli oppressivi capi tribali che controllano la maggior parte della provincia trattandola come un proprio feudo. Ma era anche un ex governatore, e un anziano rispettato da gran parte della popolazione locale. La sua morte, che in Belucistan ha scatenato disordini e sommosse, è simbolica del rifiuto da parte del nostro governo di dare ascolto alle lamentele di un gran numero di pachistani che si sentono ignorati e marginalizzati dalla politica di Islamabad. I beluci, ad esempio, ritengono di non ricevere una giusta percentuale degli introiti ricavati dal gas naturale prodotto nella loro provincia.
All’inizio sono stato un oppositore del colpo di stato che nel 1999 ha portato al potere il generale Pervez Musharraf. Ma, dopo l’11 settembre e la guerra contro i taliban in Afghanistan, il nuovo presidente sembrava poter garantire una gestione del paese stabile e per certi versi liberale in un periodo di grande incertezza. Sotto Musharraf abbiamo assistito a una rapida crescita economica e a un mercato azionario in grande fermento, a una liberalizzazione dei media privati e alla ripresa del processo di pace con l’India. Ma ora questo senso di speranza si sta spegnendo. Una delle eredità di sette anni di regime militare è un Pakistan sempre piú diviso.
Le spaccature sono visibili a vari livelli. L’esempio piú ovvio è quello degli elicotteri da combattimento che danno la caccia ai ribelli in Belucistan e nelle aree tribali della frontiera del Nordovest – ribelli che sono anche nostri concittadini. Ma altrettanto pericolosa è la cronica incapacità delle nostre province di accordarsi per la costruzione di nuove dighe, indispensabili per soddisfare il nostro futuro fabbisogno idrico. O il fatto che la nostra società non riesca a incanalare il dissenso in un dibattito, col risultato che la pubblicazione di alcune vignette su un giornale danese finisce per produrre non solo una reazione da parte dei nostri giornali, ma anche sommosse che trasformano le nostre città in campi di battaglia. L’incapacità di superare queste divisioni costituisce un grosso rischio per un paese come il Pakistan, in cui vivono una miriade di gruppi etnici e religiosi diversi. Il divario fra ricchi e poveri alimenta le ondate di crimine che investono metropoli come Karachi, mentre la guerra ideologica fra musulmani sunniti e sciiti è benzina sul fuoco per il terrorismo interno.
Il Pakistan ha bisogno di compromessi: fra le province, fra religione e laicità, fra il desiderio di crescita e l’imperativo di tenere a bada l’inflazione, fra noi e i nostri vicini. Ma un governo guidato da un presidente in divisa si è dimostrato inadatto ai compromessi. Quindi dobbiamo tentare l’alternativa: un ritorno alla democrazia, con tutto il suo corredo di mercanteggiamenti, caos e false partenze. Tale transizione non sarà priva di rischi, e molti pachistani temono un’eventuale instabilità. Ma l’altra possibilità, ovvero un prosieguo dello status quo, con un presidente cui manca la legittimità conferita da libere elezioni, e ampi segmenti della popolazione che non si sentono rappresentati dallo stato, è ancora piú rischiosa.
La prima sfida, ovviamente, è convincere Musharraf a farsi da parte al termine del suo mandato, cosí da permettere che le elezioni fissate per il 2007 si svolgano in modo corretto. Bisognerebbe tenere presente che la gente di Gwadar vuole lavoro e ospedali, non posti di blocco militari. E per quanti capi tribali vengano uccisi, in questo la gente di Gwadar non sarà mai sola.
2006.
![]()
Sessant’anni fa, l’India britannica si vide riconosciuta l’indipendenza e si divise in due: da una parte l’India a maggioranza indú e dall’altra il mio paese natio, il Pakistan a maggioranza musulmana. Fu un parto eccezionalmente doloroso.
Di generazione in generazione è giunta fino a me la storia dell’uomo di cui porto il nome, il mio bisnonno nato in Kashmir. Fu pugnalato da un musulmano durante la sua passeggiata quotidiana ai Lawrence Gardens di Lahore. All’indipendenza mancavano solo pochi mesi, e la violenza fra le comunità che avrebbe accompagnato la partizione cominciava a ribollire.
Il mio bisnonno fu aggredito perché lo scambiarono per un indú. Non c’è da stupirsene: essendo un avvocato, la maggior parte dei suoi colleghi era indú, e anche molti suoi amici. Durante le sanguinose sommosse che sarebbero seguite, avrebbe nascosto in casa sua alcune loro famiglie.
Ma il mio bisnonno era musulmano. Non solo: era membro della Lega musulmana, che si era battuta per l’indipendenza del Pakistan. Fin dal principio, il Pakistan ha avuto la tendenza a rivolgere il coltello contro se stesso.
Ciononostante, nella mia famiglia il 1947 è anche ricordato come un momento di enormi speranze. Il mio bisnonno sopravvisse. E quell’anno la nascita di suo nipote, mio padre, sancí la comparsa della prima generazione di qualcosa di nuovo: i pachistani.
Mia madre serba la memoria di un’infanzia di zucchero e farina razionati. Gli anni Cinquanta, dice, furono un decennio in cui un giovane paese imparava a reggersi sulle proprie gambe. È cresciuta in una piccola cittadina, e ricorda il fervente amore che lei e gli altri studenti provavano per il Pakistan. Il Pakistan apparteneva a loro, era una fonte di orgoglio e identità, era simbolicamente sia un genitore sia, dato che ispirava in loro quei sentimenti protettivi, un fratello.
Negli anni Sessanta la famiglia di mia madre si trasferí a Lahore, che era stata il centro culturale e politico del Punjab prima che la provincia si spaccasse in due al momento dell’indipendenza. In quel periodo l’economia del Pakistan era in forte espansione. I miei genitori raccontano di cinema che proiettavano i film piú recenti, college da cui uscivano laureati pieni di ideali e giovani coppie che passeggiavano lungo le sponde del fiume Ravi.
Ma all’epoca la vera gloria del Pakistan era il porto meridionale di Karachi, dove si era trasferito mio zio, all’epoca un giovane banchiere. Era, racconta, una metropoli vibrante e cosmopolita, un luogo di caffè e brezze marine ed equipaggi di voli internazionali che facevano scalo in città; pulsava dell’energia e dell’ingegnosità di milioni di ex rifugiati provenienti dall’India.
Tuttavia queste rosee memorie famigliari forniscono un quadro incompleto. Perché nel 1958 il governo civile del Pakistan era stato deposto da un colpo di stato militare. Il generale Muhammad Ayub Khan era un fedelissimo alleato degli Stati Uniti contro l’Unione Sovietica, e riceveva dagli americani grandi quantità di aiuti e armamenti.
Ma i pachistani, privati della democrazia per gran parte della giovinezza dei miei genitori, furono incapaci di articolare una visione inclusiva di quel che il loro paese desiderava. A peggiorare le cose, la nazione era divisa in due parti separate geograficamente dall’India. Il centro del potere militare era il Pakistan occidentale, che incamerava una quota di risorse molto superiore al dovuto. Dopo anni di ingiustizie e di elezioni truccate, il Pakistan orientale combatté una guerra d’indipendenza, con l’India schierata al suo fianco, e divenne una nazione a sé stante, il Bangladesh.
Io nacqui nel 1971, l’anno di questa seconda partizione, mentre ancora una volta il Pakistan volgeva il coltello contro se stesso.
Dopo il bagno di sangue, quel che restava del Pakistan fu costretto a chiedersi che cosa desiderava. La democrazia fu ripristinata, e il primo ministro Zulfikar Ali Bhutto si guadagnò una straordinaria popolarità con uno slogan molto semplice: «Pane, vestiti e una casa». In altre parole, il Pakistan esisteva per alleviare la povertà dei suoi cittadini.
Bhutto fu deposto nel 1977, e impiccato. Cosí, come già i miei genitori prima di me, anch’io sono nato in un Pakistan democratico ma ho trascorso la maggior parte della mia giovinezza sotto una dittatura. E, come già il generale Ayub prima di lui, anche il nuovo dittatore, il generale Muhammad Zia-ul-Haq, era un fedelissimo alleato degli Stati Uniti contro l’Unione Sovietica. Ma, mentre il generale Ayub era stato decisamente laico, il generale Zia immaginava il Pakistan come uno stato musulmano teocratico. Il paese divenne cosí una base logistica per la jihad antisovietica in Afghanistan e intraprese un clamoroso processo di ingegneria sociale chiamato islamizzazione.
Sebbene il nostro presidente non ci piacesse, io e i miei amici eravamo ferventi patrioti. Idolatravamo i campioni pachistani di cricket, hockey su prato e squash. Provavamo un brivido di trionfo quando ascoltavamo le cassette pirata dei primi gruppi rock pachistani. Per noi, il successo di ogni cosa pachistana era motivo d’orgoglio personale.
Nel 1988, poco prima che io partissi per andare a studiare negli Stati Uniti, il generale Zia morí in un misterioso incidente aereo e fu ripristinato un governo civile. Ma la democrazia degli anni Novanta è stata una delusione, con un alternarsi di governi inefficienti e litigiosi.
I miei amici si sono sposati e hanno avuto dei figli, una terza generazione di pachistani, però anche loro, come la generazione dei miei genitori e la mia, sono nati in una democrazia ma hanno trascorso la giovinezza sotto un regime militare filoamericano, questa volta guidato dal generale Pervez Musharraf.
E ora il Pakistan sta di nuovo rivolgendo il coltello contro se stesso. Nelle regioni lungo la frontiera con l’Afghanistan ribollono le rivolte, e gli attentatori suicidi hanno cominciato con allarmante frequenza ad ammazzare i loro concittadini pachistani.
Per me personalmente, il sessantesimo anniversario dell’indipendenza, per quanto significativo, non riveste grande importanza. Le mie speranze sono rivolte piú in là, alle elezioni in programma fra qualche mese.
Da una parte ci sono le forze dell’esclusione, che vogliono un Pakistan che rappresenti solo il loro tipo di pachistani. Si tratta degli eredi politici dell’uomo che ha pugnalato il mio bisnonno, persone che vorrebbero schiacciare quelli che si radono la barba o quelli che sgobbano per un tozzo di pane o quelli che vengono da province diverse dalla loro. Ma contro queste persone si è schierato qualcosa di completamente nuovo.
Adesso il Pakistan ha canali televisivi privati che non si lasciano imporre dal governo le notizie da trasmettere. Ha una Corte suprema che per la prima volta ha affermato la sua indipendenza reintegrando un proprio presidente sospeso da Musharraf. E ha un esercito messo sotto attacco dall’interno e alla disperata ricerca di un compromesso con la società civile.
Un sessantesimo anniversario comporta l’obbligo di nutrire qualche illusione. I pachistani devono capire di essere stati finora i propri peggiori nemici. Il mio augurio per questa ricorrenza è questo: che finalmente prendiamo il coltello che troppo spesso abbiamo rivolto contro noi stessi e lo rimettiamo nel fodero.
2007.
![]()
![]()
Nel valutare il discorso del presidente Obama al Cairo, bisognerebbe tener conto di una semplice verità: nessun essere umano è solo un musulmano e nessun essere umano è solo un americano. Le persone che possono essere definite musulmane, o americane, sono anche donne e uomini; madri, padri, figlie e figli; amanti e medici e scrittori e insegnanti; povere e ricche; politicamente impegnate e apatiche; sicure delle proprie idee ed estremamente incerte. Sono, in altre parole, complesse, pluridimensionali, uniche e in continuo cambiamento. Osservate da vicino la massa compatta dei musulmani e vedrete una nube di un miliardo di atomi ben distinti.
La religione e la nazionalità sono solo due della miriade di dimensioni che costituiscono la nostra identità di persone. Come esseri umani, lo comprendiamo istintivamente. Quando qualcuno allunga una mano per tenerci aperta la porta di un ascensore che si sta chiudendo, di quella persona non notiamo il fatto che è musulmana, o americana, ma il fatto che è premurosa. È quando siamo spaventati, e soprattutto quando qualcuno specula sulle nostre paure e le manipola a proprio vantaggio, che tendiamo a ridurre gli altri a identità univoche e semplificate (nonché artificiali) enfatizzando la religione, la nazionalità o la razza.
Il discorso del presidente Obama è stato un gradito tentativo di ridurre la paura che abbiamo gli uni degli altri. Ha detto che i musulmani e gli americani collimano in sette milioni di cittadini americani musulmani, in secoli di storia condivisa e anche nella sua stessa famiglia. Ha richiamato l’attenzione sulle somiglianze tra la fede musulmana, quella cristiana e quella ebraica. Ha preso posizione contro la rozzezza degli stereotipi. Ha respinto l’idea che l’Islam e gli Stati Uniti siano in competizione fra loro. Ha chiesto rispetto reciproco, maggiore impegno e piú apertura.
Il suo discorso è stato un inizio promettente, una benaccetta presa di distanza dal terrificante atteggiamento del governo statunitense che l’ha preceduto. Ma perché sia qualcosa di piú di un inizio, è necessario che alle parole seguano i fatti. In quanto romanziere, do grande importanza alle parole, e sono riconoscente per molte delle parole che ho sentito dire al presidente Obama. Un cambiamento di tono cosí drastico può rendere possibili azioni prima impossibili. Ma saranno le azioni a decidere in che modo questo discorso sarà giudicato dalla storia.
Ci sono motivi di ottimismo. Il passo del discorso che piú mi è rimasto impresso è: «Gli Stati Uniti non ammettono la legittimità dei continui insediamenti israeliani». Diventa sempre piú palese che il presidente Obama intende esercitare forti pressioni su Israele perché si raggiunga una pace duratura coi palestinesi. ...