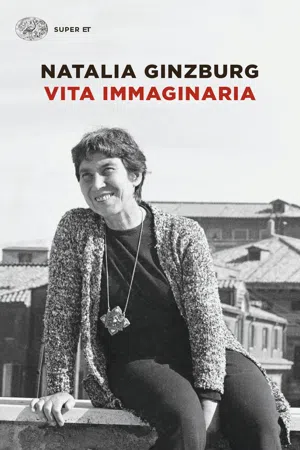Ieri, due giugno, festa della repubblica, sono andata a un ricevimento nei giardini del Quirinale. Vi ero stata altre volte; e mi sono accorta che ogni anno penso le stesse cose. Primo, che vorrei abitare al Quirinale; secondo, che quei giardini cosí belli noi li vediamo sempre sciupati dalla gente, dalle divise delle guardie, dai tavoli dei rinfreschi, e dev’essere molto bello poterli vedere vuoti e deserti; che i luoghi sono belli solo quando sono deserti; che però questo è un pensiero ignobile, perché in verità i bei giardini e i palazzi dovrebbero essere proprietà pubblica, e quindi essere sempre pieni di gente; e infine, che vorrei abitare al Quirinale non come presidente della repubblica, ma come re. Perché là mi venga in testa ogni volta un simile pensiero, lo ignoro: e giuro che in verità un regno è l’ultima cosa che mi propongo di ottenere al mondo. Se non vorrei essere un capo di Stato, ma un re, è perché non so immaginare l’attività di un capo di Stato; e invece potrei decidere di non fare niente come re. Inoltre, come capo di Stato, dovrei andarmene di là dopo qualche anno, e ne avrei dispiacere; io vorrei rimanere là per tutta la vita, alla maniera dei re. È pur vero che anche i re vengono mandati via a volte dai loro palazzi, come l’ultimo re che ebbe ad abitare in quei luoghi; cosí prendo a pensare che vorrei essere un re d’altri secoli, di epoche in cui per un re era difficile perdere il regno. Oggi, i pochi re che rimangono sulla terra non sono certo in una situazione né stabile, né sicura: sono pochi, sbandati, e quelli che sono ancora sul trono sembrano vivere quasi allo stesso modo di quelli che il trono l’hanno perduto: tanto che, quando li vediamo nei rotocalchi sulla neve o sul mare, per alcuni di essi dobbiamo fare uno sforzo per ricordare se siano in vacanza o in esilio.
Il pensiero dell’ultimo re che abitò al Quirinale, Vittorio Emanuele terzo, mi riconduce alla mia infanzia, quando egli ancora regnava; rivedo la sua faccia sui francobolli e sulla copertina della «Domenica del Corriere» (non c’erano rotocalchi a quel tempo), rugosa e nervosa, aggrondata sotto il berretto a visiera, e la corta persona insaccata in panni militari, come appariva a volte sullo schermo; gracile e per nulla regale, sempre stizzito per l’alta statura di chi gli stava accanto, sua moglie o Mussolini, e sempre molto di malumore, forse inquieto perché vagamente sapeva di avere ancora poche stagioni di regno.
Confesso d’essere stata monarchica, da bambina: per spirito di contraddizione, perché mio padre era repubblicano, e per invidia, perché avrei voluto essere io un re. I miei sentimenti monarchici erano cosí accesi, che arrossivo ogni volta che si nominava il re; e segretissimi, perché me ne vergognavo, confusamente sospettando che il re non meritasse grande stima; cosí che non ne feci mai parola ad anima viva. Ricordando quegli anni, ho la sensazione d’avere avuto davanti a me due emisferi; un emisfero fiabesco, puerile e confuso, dove il re fluttuava vestito di grigio-verde, ma con lembi di porpora e d’ermellino: stizzito ma innocuo, forse un gran pauroso come diceva mio padre, ma inerme e compassionevole come lo vedeva mia madre, e comunque da me venerato e dotato di qualità lusinghiere; e un emisfero fatto di cose vere, il fascismo, emisfero funerario e sanguinario, con cortei e pennacchi neri, situato in luoghi ben veri e precisi, le strade e i viali a Torino intorno alla mia casa: luoghi che esso aveva il potere di intorbidare con la sua presenza, e anche trasformare in uno scenario di tenebre e di morte. Perché lo spirito di contraddizione, che mi faceva essere segretamente amica del re, non operava in me nei riguardi del fascismo, che odiavo sapendolo odiato dai miei, e che mi ispirava spavento.
Conversavo col re, quando giocavo sola, e gli davo consigli sul governo dell’Italia. Gli suggerivo inoltre maniere per salvare l’Italia, rovesciare il fascismo e uccidere Mussolini; i nostri colloqui si svolgevano di solito in un corridoio del suo palazzo, luogo da me inventato ma che ancora oggi vedo davanti a me come fosse vero, lucidato a cera e pieno di colonne; e là, dove io ero penetrata insinuandomi fra i soldati e le guardie, tramavo con il re e la regina astute congiure. Mi ero infatti nominata ministro. Quello che amavo, nel re, era proprio quello che da adulti ci induce a rifiutare la monarchia, e cioè il fatto che egli fosse stato scelto dal caso, senza nessun suo merito speciale: gli invidiavo questo destino, e mi sforzavo di condividerlo, o almeno di esservi coinvolta. Molto piú tardi, avendo cessato da tempo di essere monarchica, e di immaginare mie gloriose imprese a fianco del re, tuttavia nel ricordo di quell’antico segretissimo sodalizio mi interessavo a quello che a lui accadeva; e ancora molto piú tardi, nei giorni dell’armistizio, quando seppi che era fuggito, nella piena dell’odio mi fermai un attimo a piangere i tradimenti e la miserevole fine di quell’amico della mia infanzia, e le rovine di quel corridoio a colonne dove con lui avevo tramato complotti, e che esisteva soltanto nella mia fantasia. Perché sulle nostre reazioni ai fatti che ci accadono nella vita adulta, si stende stranamente una ragnatela segreta, intessuta nei nostri giorni infantili; e in penombra nella nostra anima cresce una flora e una fauna che non ha alcun rapporto con le nostre convinzioni maturate nel tempo, col pensiero e con la ragione.
C’è soprattutto un punto che mi piace molto nei giardini del Quirinale, un piazzale erboso, con una balaustrata di pietra, da cui si domina la città dall’alto; e Roma è bella ormai solo vista dall’alto, perché nelle sue strade ci si muove stretti in una fiumana di macchine; guardata dall’alto, quella fiumana di macchine diventa una cosa sola col tramonto e le nuvole, con gli alberi, il fiume, i ponti e le fontane; se io fossi il padrone di quei luoghi, me ne starei sempre là, in compagnia dei tetti grigio-rosa dove volano i colombi; dall’alto, anche quella fiumana di macchine sembra uno stormo di colombi, e dà un suono che la distanza rende simile alla voce dei colombi, un suono animale, gutturale e dolce, che non strazia il silenzio ma sembra fatto del silenzio stesso. Cosí io vorrei regnare su quei luoghi per sempre, con cani e servi. Provando stupore per un simile desiderio, che non assomiglia in nulla ai miei desideri e propositi veri, mi chiedo se quello che vorrei è il potere, o se invece vorrei solo isolamento e silenzio. Non credo di amare il potere; non saprei come usarlo. L’unico potere che vorrei sarebbe quello di scegliermi nella città l’abitazione che piú mi piacesse: l’unico dominio che vorrei sarebbe il dominio dello sguardo. È però vero che, per avere isolamento e silenzio, e il dominio dello sguardo sulle città, non è necessario essere né un re, né un capo di Stato, e basterebbe essere un monaco in un convento: i conventi sorgono spesso su alte colline, e dominano pianure e città. Ma io non vorrei essere un monaco, la vita dei monaci non mi incuriosisce né mi seduce: quella sorta di pace cosí celestiale, e la compagnia di altri monaci assorti in preghiera mi annoierebbe a morte; e difatti, vedendo bei conventi, ho pensato spesso che erano bei luoghi sprecati. Quello che vorrei essere è proprio un re. Sarei un re del tutto privo di voleri, una volta appagato nella scelta del luogo dove vivere; e un re del tutto privo d’occupazioni; non vorrei intorno a me soldati, e pregherei che mi fosse permesso di non presenziare a nessuna festa pubblica; semplicemente me ne starei là, appoggiato a quella balaustrata, totalmente inutile, forse felice. Non so se scriverei dei libri; una volta credevo che la condizione ideale per scrivere fosse il trovarsi in un luogo bellissimo e avere ozio, solitudine e silenzio; ma invece poi ho scoperto che in una simile condizione non si scrive piú, ci si sente come imbalsamati, e invece si lavora con profitto in posti squallidi, scomodi, nell’ansia, nel disagio e nel rumore.
Ogni volta, al ricevimento del Quirinale per la festa della repubblica, mi chiedo se anche gli altri che vedo camminare per quei giardini nascondano nelle pieghe del loro spirito un simile stupido sogno: essere un monarca e vivere per sempre nel luogo piú bello della città. Credevo che, invecchiando, uno dovesse liberarsi di questa sorta di sogni; essi invece continuano a vegetare nella nostra anima, come funghi o muschio nel folto d’un sottobosco; e non li uccide né il sapere che non si realizzeranno mai, né il sapere che non hanno nessun senso. Da un simile sogno, nasce in me immediatamente il suo contrario, il desiderio di non avere niente e di non essere niente, il desiderio di non avere mai non dico il Quirinale, ma nemmeno una catinella; e il pensiero che se fossi un re sarei disperata, non amerei né spazio né silenzio e sarei sommersa da un senso di colpa cosí inesorabile, che mi butterei a giacere in abbandono come un paio di ciabatte vecchie nell’angolo piú remoto di quei luoghi.
3 giugno ’69.
Benché sembri fare di tutto per essere piú brutta possibile, questa città in cui vivo, e che è Roma, io la trovo sempre bellissima. Oltre al fatto che la trovo bellissima, essa mi è cara e non vorrei lasciarla per nessuna ragione al mondo. È però diventato ben difficile amarla e anche abitarla essendo essa ormai un bosco di automobili. Se c’era una città al mondo che era fatta per camminare a piedi, era questa, e le automobili sembrano averla invasa di sorpresa e come una disgrazia. Queste automobili non si capisce chi le ha volute perché tutti le maledicono. Dilagano nella città come un fiume in piena, sembrano essere state rovesciate fuori dalle viscere della terra, e a tratti riempiono la città di un lungo urlo esasperato e beffardo, che sembra insieme canzonare la gente e invocare aiuto.
Le città che abbiamo scelto da adulti e che diventano nostre, sono insieme quello che di loro abbiamo immaginato nell’infanzia senza conoscerle, quello che di loro ci è apparso quando le abbiamo viste per la prima volta, il desiderio che ne abbiamo provato standone lontani, e infine l’insensibilità o la rabbia con le quali vi camminiamo abitandole ormai da molti anni. I sentimenti che esse ci ispirano abitandole da molti anni, non sono diversi dai sentimenti che ci ispirano le persone, quando una lunga e giornaliera abitudine di convivenza mescola nell’affetto insofferenza e rabbia. A un certo punto ci accorgiamo che l’insofferenza e la rabbia, cresciute sopra l’affetto come dei licheni, non hanno logorato l’affetto ma l’hanno invece reso piú forte, profondo e inestinguibile. Allora cerchiamo nella memoria le immagini remote di quelle persone, o di quei luoghi, quando per la prima volta ci sono venuti incontro, e noi non sapevamo ancora se era un incontro secondario e fuggevole, o invece duraturo ed essenziale.
Le città che abbiamo scelto da adulti, noi usiamo confrontarle spesso nel nostro pensiero con le città dove abbiamo trascorso l’infanzia. Spesso ci rallegriamo con noi stessi per aver strappato le nostre radici dai luoghi dell’infanzia, per avere steso radici e abitudini in altri luoghi. Lo strano è che, anche diventati vecchi, conserviamo una singolare fierezza per avere affondato radici e abitudini lontano dai nostri paesaggi infantili. La ragione di questa fierezza ci è oscura, perché non abbiamo in genere, nell’essercene andati via dalla nostra città d’origine, nessun merito di nessuna specie. E tuttavia sulle città che ci siamo scelti da adulti, sventola fino al termine dei nostri giorni la bandiera inesplicabile del nostro orgoglio.
Una volta, quando mi trovavo a Roma da poco tempo o quando la rievocavo con rimpianto essendone lontana, usavo enumerare in me le ragioni per cui pensavo di amarla. Pensavo che amavo in lei una strana aria di sembrare piccola essendo enorme. La notte, uno aveva a Roma la sensazione di camminare nei vicoli d’un paese. Quello che la faceva assomigliare a un paese erano forse i gatti, o il silenzio, o la piena pace di certe piazze vaste e deserte, o il fatto che ovunque si sentisse la strana vicinanza d’una campagna invisibile, selvosa e sterminata. Come mai la campagna sembrasse cosí vicina tanto che, trovandoci sommersi nella pietra, pareva d’avere intorno nel buio una frusciante distesa di campi e alberi, io non lo so. Potevamo metterci seduti su una gradinata, guardare i gatti, l’erba, la luna, le fontane e le rovine, e godere di uno strano silenzio campestre e solenne. Potevamo pensare che era estate quando magari era inverno. Trovavo che le stagioni in questa città erano spesso confuse, e questo, a me che ero cresciuta a Torino, sembrava una cosa straordinaria. Ero avvezza agli inverni di Torino interminabili e gelidi, quando la nebbia e il buio tengono la città inchiodata e irrigidita in un sonno severo e impenetrabile. Pensavo che Roma non cadeva mai totalmente nell’inverno, perché si poteva sempre sorprendere, di là dal freddo, uno strano soffio di ozio, di vacanza e d’estate. Pensavo che era un luogo dove succedeva sempre qualcosa d’imprevedibile. Quando pioveva e l’intiera città diventava come un’enorme pozzanghera, ti arrivava a un tratto da non so dove, nella pioggia, un tepore e un chiarore di primavera. In un cielo pesante di nuvole gonfie e gialle poteva accendersi a un tratto un tramonto color fuoco. Queste erano le ragioni per cui pensavo che mi piaceva. È pur vero che, a Roma, nei primi anni che ci abitavo, mi struggevo di nostalgia per Torino e per i suoi inverni interminabili. Quando camminavo per Roma o mi affacciavo alle balaustrate e pensavo com’era qui sempre tiepida e dolce la pietra, avevo una profonda nostalgia di Torino e precisamente d’una strada di Torino che era via Nizza. Perché desiderassi tanto via Nizza non lo so. Era la strada d’un quartiere dove avevo abitato ma non era la strada dove si trovava casa mia. Comunque avrei dato non so cosa per essere in via Nizza, camminare fra le case altissime e sigillate nel gelo e respirare nebbia, inverno e malinconia.
Credo del resto che nel mio affetto per Roma si sia mescolata all’inizio proprio la nostalgia della mia città d’origine, e cioè Torino, da cui allora mi divideva la guerra. I nostri sentimenti per le città, come quelli per le persone, sono sempre molto confusi e vi si mescola ogni specie di cose. Quello che è certo è che le città, come le persone, non le amiamo per le ragioni che abbiamo enumerato dentro di noi. Non vedo oggi in Roma nemmeno un’ombra degli aspetti per cui un tempo affermavo di amarla. Non è piú possibile ora, qui, né guardare il cielo né accorgersi delle stagioni. Semplicemente non è piú possibile scambiare con la città né una parola né uno sguardo d’affetto. Le automobili invadono i marciapiedi. Essa sembra colpita dalle automobili come da una malattia maligna. E nulla ora qui sembra lontano e remoto come la campagna. Ci sono sempre i gatti e le rovine, ma non viene in testa di guardarli, perché bisognerebbe cercarli dietro alle automobili. La notte, certo Roma non sembra piú un paese. Non sembra però nemmeno una grande e febbrile città, né di notte né di giorno, e il fatto è che non sembra nulla. È come se non sapesse piú cosa essere. Di notte, le automobili diradano, ma il silenzio nelle strade non è adesso mai tranquillo e profondo. È un silenzio senza pace, un silenzio d’attesa, di stanchezza e di prostrazione. È un silenzio dove ancora vibra l’eco di quell’urlo lacerante e querulo, l’urlo delle automobili incatenate nel traffico, e tutta la città aspetta che di nuovo fra pochissimo ricominci quell’urlo, con la sua straziante e beffarda invocazione d’aiuto. Intorno alla città, sono cresciute e crescono di continuo case che non le assomigliano, e non si assomigliano fra loro essendo tutte orribili, ma riuscendo a essere orribili ciascuna in una sua maniera particolare. Sono case che appena costruite si coprono di lebbra e appaiono decrepite. Anche loro non sanno cosa essere, se case di città o di paese, e sembrano però desiderare un rapporto con il centro della città, ma l’unica rassomiglianza che ottengono con il centro della città è che anche loro si dibattono nella stretta delle automobili. Anni fa, la città già aveva intorno a sé una vegetazione di nuove case, vegetazione intricata, malforme e fragile, ma sembrava ospitare e sopportare ogni specie di malformazione nella sua suprema e immemore indifferenza. Ora nella sua indifferenza che sembrava destinata a durare eterna, sembra essere sorta una confusa stanchezza, una perplessità e una tristezza segreta, in questa città che non era mai né stanca, né perplessa, né triste. È la tristezza d’avere perduto la sua natura essenziale e di essere tuttavia incapace di averne un’altra. Questa è Roma oggi, che a me non piace piú, che sembra non piacere piú a nessuno e che però tutti amiamo, perché le città, come gli esseri, si amano in verità senza nessuna ragione o per un intrico di ragioni che sono per ognuno diverse. A Roma, durante la guerra, ero nascosta in un convento in via Nomentana e dividevo la stanza con una vecchietta ebrea viennese, con la quale strinsi amicizia. Era molto gentile e quando io uscivo, badava alla mia bambina di pochi mesi. Siccome io avevo un fornelletto elettrico, questa vecchietta ogni tanto mi chiedeva di adoperarlo. Benché le avessi detto piú volte che poteva adoperarlo quando voleva, mi annunciava però ogni volta che l’avrebbe adoperato. In certi freddi pomeriggi, si alzava a sedere sul letto e diceva: «Signora cara, io se fa tè». Mi si potrà chiedere cosa mai c’entri con i miei sentimenti per la città questa vecchietta in esilio, che non ho mai rivisto e che sarà da lungo tempo morta. Ma per me via Nomentana e il corridoio buio di quel convento e le alte finestre lambite dagli alberi, sono inseparabili dal ricordo di quella piccolissima vecchietta che stava seduta sul letto con uno scialle marrone, e io credo d’aver cominciato ad amare Roma cercando una sorta di protezione materna in quella vecchietta che a sua volta desiderava la mia protezione insieme al mio fornellino. Cosí quando passo per via Nomentana ormai sotterrata nelle automobili e irriconoscibile, mi ricordo quanto mi è cara questa strada e ritrovo le chiavi dell’affetto ripetendo quelle lontane parole: «Signora cara, io se fa tè».
Dicembre ’70.
Nelle donne, la prima cosa che diventa vecchia è il collo. Un giorno, si guardano nello specchio il collo pieno di rughe. Dicono: «Ma come è successo?» Intendono dire: «Ma come mai questo è successo a me? a me, che ero giovane per mia natura e per sempre?»
Avevano l’abitudine di lavarsi il viso col sapone. Nei periodici, dove si parla della cura della pelle, è scritto che non bisogna mai toccare il viso col sapone. Esse tuttavia pensavano che il loro viso fosse un’eccezione, che fosse refrattario alle creme e fatto per essere insaponato con energia.
Tuttavia a poco a poco, sentono che si è insediata nella loro testa l’idea che il sapone fa malissimo. Smettono di insaponarsi il viso. Comprano acqua tonica e latte detergente.
Ogni sera, spruzzando un poco di quel latte su un batuffolo d’ovatta, gli torna alla memoria una frase che hanno letto sui periodici: «Fai al tuo collo tutto quello che fai al tuo viso». Ogni sera, questa frase gli sembra strana, perché pensano che al collo andrebbero prodigate piú devote e sottili attenzioni.
Nel pulirsi la pelle con il latte, con l’acqua tonica, si chiedono se queste sostanze servano a qualcosa. Si chiedono cosa diavolo ci sia dentro. Annusano la bottiglietta dell’acqua tonica, la trovano totalmente inodore. Si chiedono se ci sia una vera differenza fra questa acqua e l’acqua dei rubinetti. Pensano intanto che in fondo non glie...