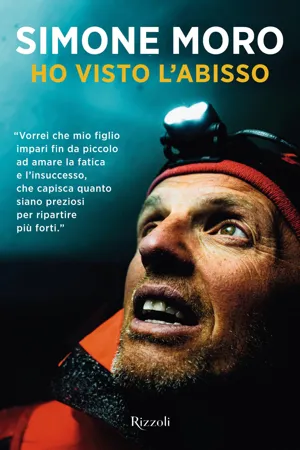È il 26 novembre del 2019 quando con Tamara Lunger annunciamo, nel corso di una presentazione a Milano del mio libro I sogni non sono in discesa, la nostra prossima spedizione invernale.
C’è molto pubblico, siamo carichi e pieni di entusiasmo: come se dire a tutti che stiamo andando, che tutto è pronto, lo rendesse più vero.
Il progetto che abbiamo in mente è quello di riproporre nella stagione invernale una famosissima traversata di Reinhold Messner e Hans Kammerlander che, nel 1984, riuscirono per la prima volta a concatenare due Ottomila, salendo prima il Gasherbrum II e, da quello, il Gasherbrum I (queste due cime vengono chiamate anche G1 e G2). Qualcuno ricorda bene quell’impresa, altri non ne hanno quasi sentito parlare e vogliono saperne di più.
Racconto come quella di Messner e Kammerlander fu una prima assoluta: ancora non era capitato che qualcuno riuscisse a salire in successione due montagne, senza fare ritorno al campo base ma rimanendo quasi interamente sulla linea di cresta e unendo così, in un’unica cavalcata, le due cime. All’epoca, tutti ritenevano impossibile rimanere tanto a lungo a una tale quota in uno sforzo così prolungato: be’, i due ragazzi altoatesini dimostrarono non per la prima e neanche per l’ultima volta che l’impossibile non esiste.
C’è poi un passaggio nel resoconto di Messner di quella spedizione epocale che è rimasto celebre. Ed è quando, tornato a casa, Messner raccontò con grande naturalezza di essersi sentito, una volta salito il G2 assieme al suo compagno, abbastanza forte, fisicamente e mentalmente, per decidere di continuare in direzione del G1. Stava bene e quindi perché non provarci: una decisione apparentemente semplice ma in grado di cambiare la storia del nostro mondo verticale. Nei trentacinque anni successivi, nonostante parecchi tentativi, nessuno era più stato in grado di ripetere la loro impresa neppure d’estate.
La nostra idea, spiego, è andarci d’inverno e, a differenza loro, saliremo prima sul G1 e da lì, passando dal colle che separa le due cime, proseguiremo per il G2. Lo dico e penso sia un sogno ma, come nel caso di altri miei, è un sogno ben ponderato.
Il pubblico ci ascolta, parliamo della traversata G1 e G2 come se l’avessimo decisa pochi minuti prima ma il progetto è ovviamente già avviato da tempo. Sappiamo precisamente quando partiremo e sappiamo anche come vogliamo muoverci.
«Come sarà la cordata?» domanda uno.
Racconto che l’idea di fondo, anche in coerenza con quanto fatto da Messner-Kammerlander, è quella di essere leggeri. Fin dall’inizio so di voler partire con un solo compagno e che quel compagno, come già nelle ultime spedizioni, sarà Tamara Lunger. Insieme a noi, ma non nella cordata, ci saranno due professionisti amici come l’operatore Matteo Zanga e il fotografo Matteo Pavana a cui chiediamo di seguirci fino al campo base per documentare al meglio sia la prima parte della spedizione sia di filmare gli eventuali altri campi, per quanto possibile, con il drone.
«Poi?» domanda un altro.
Proseguo.
Nell’ottica della leggerezza, non useremo mezzi meccanici: rinunceremo all’elicottero, sia per ragioni etiche che per favorire il lavoro della povera gente del posto, nonostante il salario di un portatore d’inverno sia, non è difficile capirne il perché, quasi quattro volte più alto rispetto alla stagione estiva. Sarebbe in effetti più veloce e conveniente usare l’elicottero ma faremo invece tutto a piedi. Infine, sempre rispettando il principio dell’inverno astronomico, intendiamo partire dopo il 21 dicembre.
La scelta del Gasherbrum non è ovviamente casuale né solo dettata da ragioni sentimentali: a confortarmi c’è anche il peso dell’esperienza maturata durante la prima invernale del G2 insieme a Denis Urubko e Cory Richards. L’obiettivo di concatenare quella montagna con il G1 è grandissimo ma, come già in altri miei tentativi, non è un salto nel buio: pensare di aver già raggiunto una delle due vette in prima assoluta in inverno mi dà la tranquillità necessaria a sognare così in grande. Conosco, per così dire «di persona», il G2 e altrettanto bene conosco il ghiacciaio che dovrò attraversare per arrivare ai piedi di entrambi, una serie di crepacci e seracchi che già ho superato in stile leggero con Urubko e Richards. Si tratta di trovare la via e di farlo il più velocemente possibile: il ricordo di come sia riuscito a trovarla facilmente nel 2011 mi infonde fiducia nonostante sia consapevole che ogni volta è diverso. A dire il vero, a preoccuparmi in questa spedizione è altro.
Mi domando se saremo entrambi in grado di resistere a uno sforzo così intenso e duro, se riusciremo a sopportare condizioni climatiche tanto rigide. Mi chiedo se con Tamara avremo sufficienti gambe e fiato per aprire l’itinerario dentro la neve, per fare la traccia: non ci sarà nessuno ovviamente a precederci. C’è anche altro a impensierirmi: la gestione dell’allestimento dei campi, le scelte e la strategia che prenderemo che in questo caso non saranno rapportate a una sola montagna ma a ben due.
La serata prosegue. C’è infatti un’altra novità o curiosità da soddisfare ed è che qualche tempo prima di quell’incontro siamo stati contattati da un centro scientifico all’avanguardia, l’EURAC di Bolzano, specializzato in analisi climatiche, fisiologiche, tecnologiche e ingegneristiche. L’obiettivo loro è di far avanzare, in caso di nostra disponibilità, le loro ricerche sulla ipossia per le quali servono soggetti sperimentali sani e avvezzi all’alta quota. Io e Tamara, ci dicono, saremmo perfetti per valutare attraverso una serie di adattamenti fisiologici, ormonali ed ematici cui saremo sottoposti quali siano le migliori modalità per relazionarci all’alta quota. Ci anticipano che la maggior parte dei test saranno effettuati grazie a una camera ipobarica, presente nel loro centro, capace di riprodurre tutti i climi del pianeta e tutte le condizioni di quota e di aria. Li ascoltiamo e a convincerci è anche la possibilità di renderci utili visto che scopo ulteriore dell’operazione è quello di contribuire alla ricerca su pazienti che, in situazioni normali, quindi di bassa quota, soffrono di patologie cardiopolmonari e cardiovascolari.
Ci sembra un’ottima idea e, nel momento in cui ne parliamo, nessuno fiata.
«Grazie a tutti» diciamo salutando. Giornalisti e appassionati ci augurano un bell’in bocca al lupo, la serata finisce e quando con Tamara torniamo a Bolzano, nel nostro bunker, siamo ancora più ottimisti.
Nei giorni successivi, dentro e fuori dall’EURAC, ci rendiamo però conto di quanto severe siano le condizioni che questo impegno che abbiamo preso comporta. Ci domandiamo sempre più incessantemente come faremo a gestire appuntamenti e programmazione della spedizione sapendo che, dopo una prima fase iniziale in cui la nostra presenza prevede degli intervalli, principalmente dentro di notte e fuori di giorno, col passare del tempo dovremo rimanere reclusi a tempo pieno. Il programma prevede infatti che da quota 3500 ci porteranno sempre più su fino a raggiungere, verso la conclusione del protocollo, i 7700 metri.
È un rompicapo: ci sono mille cose da organizzare, l’equipaggiamento, i bagagli, i biglietti d’aereo… la situazione è tale che i nostri sponsor sono costretti a portarci il materiale direttamente lì dentro perché noi lo si possa testare, assemblare e preparare.
Ma il meglio non è ancora arrivato. Se infatti gestiamo a fatica l’impegno che ci viene richiesto, rimaniamo letteralmente basiti quando, nelle poche ore in cui usciamo da questo pianeta parallelo, ci rendiamo conto di come stiano montando le accuse e le polemiche contro di noi e la nostra scelta di aderire in modo manifesto e dichiarato alla richiesta dell’EURAC. Ci accusano di barare, di essere a caccia di scorciatoie: sui social nascono discussioni volte a stigmatizzare quella che viene da molti definita come l’ennesima deriva dell’alpinismo. Si crea una situazione paradossale: trascorriamo le ore all’interno pensando a quanto ci mancano amici e familiari, a quanto sarebbe stato meglio acclimatarsi salendo di quota circondati da ghiacciai e cime innevate come abbiamo sempre e solo fatto e, quando usciamo, al posto del sollievo di luce naturale e affetti, ci troviamo costretti a difenderci dalle critiche e da accuse feroci, cattiverie velenose…
Gli insulti non arrivano solo dai soliti odiatori di professione ma anche dal nostro mondo, colleghi e addirittura amici, che scrivono e commentano sui social scagliandosi contro noi. Mi arrabbio e mi sorprendo di come l’utilizzo dei social abbia ormai raggiunto e oltrepassato il livello di guardia e di come, anche nel mio mondo, nessuno sia più in grado di dirti di persona, in faccia, quello che pensa di te ma preferisca affidare i suoi pensieri a post che circolano fra migliaia, e in alcuni casi milioni di persone. C’è molta malafede e anche parecchia ignoranza. Nessuno ricorda che mai nella mia carriera ho fatto acclimatamento artificiale preventivo prima di scalare. Né che mai io ho usato l’ossigeno in una invernale, cosa che mi è invece capitata, l’ho sempre dichiarato e lo faccio anche ora, nelle mie salite all’Everest. Penso, sbagliando, che la mia carriera dovrebbe parlare per me ma per questa scelta di acclimatamento in remoto, presa alla luce del sole e tutt’altro che per fini dopanti, veniamo massacrati. Tutti parlano, tutti sanno tutto e nessuno, ad esempio, ricorda come questa attività di adattamento in camera ipobarica non sia certo una novità nella storia dell’alpinismo. Ma forse i social hanno cambiato il mondo.
I test si concludono e qualche giorno prima di Natale riusciamo finalmente a imbarcarci a Malpensa e a metterci alle spalle tutta questa miseria. Arriviamo a Islamabad, trascorriamo i soliti giorni in mezzo a formalità da espletare e alla preparazione dei materiali da completare e poi ci accingiamo a salire su un aereo che, in quarantacinque minuti, ci porterà a Skardu. Ma, dopo aver visto il nostro volo cancellato per due giorni di fila, ci rassegniamo e al posto di quella breve tratta ci spariamo trentasei ore di pulmino lungo i settecento chilometri della famosa, e tortuosa, Karakorum Highway. Da Skardu, un’altra giornata in jeep fino ad Askole e poi, finalmente, iniziamo il nostro cammino di avvicinamento lungo il ghiacciaio del Baltoro. In quel mondo ancora selvaggio, in quella bellezza straordinaria ci dimentichiamo per fortuna delle polemiche e cominciamo a entrare nella mentalità giusta per la spedizione. Il paesaggio, che già conosco per averlo percorso sia d’estate sia d’inverno per andare al Broad Peak nel 2007 e nel 2008, è straordinario e avanziamo per una decina di giorni accompagnati da temperature che scendono abbondantemente sotto i trenta gradi sotto zero e un sole che ci scalda solo per poche ore al giorno visto che, come spunta all’improvviso da dietro le altissime montagne che circondano la lingua del ghiacciaio, altrettanto rapidamente va a nascondersi dietro le stesse.
È un trekking fantastico, sulla grande valle del fiume Braldu è scesa moltissima neve ma a tratti riusciamo a intuire la traccia lasciata da un’altra cordata che ci ha preceduti, composta dall’amico Denis Urubko, da Don Bowie e dalla fidanzata di quest’ultimo, Lotta Hintsa, a loro volta diretti al Broad Peak. Assieme a noi, con me Tamara e i due «Mattei» ci sono settantacinque portatori, di cui alcuni trasportano il cibo per i portatori stessi e altri materiali suddivisi in bagagli e in carichi da quindici chili a testa. La traccia di Denis e dei suoi ogni tanto compare, facilitandoci nella nostra marcia, per poi scomparire, a causa del vento, finché non arriviamo al Concordia, dove confluiscono le tre lingue glaciali di K2, Broad Peak e Gasherbrum e il percorso si biforca: da una parte si va al K2 e al Broad Peak e dall’altra al gruppo dei Gasherbrum dove siamo diretti noi.
Da quel momento in avanti, non ci siamo che noi lungo il cammino verso il campo base. Giungiamo a destinazione il 2 di gennaio e decidiamo di installarci, come già fatto nel 2011, molto vicino all’accampamento militare permanente, costruito quasi quattro decenni fa ai piedi del G1, in quella che qui chiamano la disputed zone, una zona di confine fra India e Pakistan, contesa per via di tensioni territoriali permanenti fra i due Paesi e riportata sulle carte come linea tratteggiata a indicare una non definita e mai concordata linea di frontiera. Per quanto possa sembrare strano in una zona per il resto incontaminata, la base vicina a noi non è la sola postazione militare: sempre in questa area, ce n’è un’altra più in alto a seimila metri sulla quale, per quanto ne so, si registrano più morti per il freddo e per la quota che non a causa di eventuali scontri a fuoco con il nemico indiano.
Faccio mettere le tende in un avvallamento marcato che d’estate rappresenta il letto del torrente che nasce dal ghiacciaio e, nelle settimane a venire, garantirà che le nostre tende non si trovino esposte ai venti nelle giornate di bufera e tormenta col rischio che vengano strappate via.
Vado a presentarmi ai militari, a spiegare chi siamo e cosa abbiamo in mente, e la sensazione è che siano gentilissimi anche perché con la nostra presenza riusciamo a lenire parte della noia di rimanere bloccati in un posto completamente isolato e nel quale, diversamente che nella stagione estiva in cui viene preso d’assalto dai trekker e dalle spedizioni, passano dei mesi senza che si veda anima viva. Sono amichevoli, ci offrono il tè e nei giorni successivi, quando non siamo impegnati a trovare la via, spesso capita che ci si faccia reciprocamente visita.
Con Tamara ci mettiamo subito al lavoro: vogliamo guadagnare tempo per il campo 1 e iniziamo a cercare il percorso migliore lungo e attraverso la prima parte del ghiacciaio con l’obiettivo di cavarcela in pochi giorni. L’obiettivo è quello di arrivare, dai 5000 metri dell’avvallamento in cui siamo accampati, fino a 5500 metri, dove ricordavo, dalla passata esperienza invernale, che si concludeva la parte ripida e sarebbe stato più agevole installarci. Ricordavo anche come nel 2011, con Denis e Corey, avessimo impiegato solo pochi giorni per individuare, fra i numerosi seracchi e crepacci, la via giusta in mezzo a questo labirinto. Si era trattato giusto di non essere troppo impazienti, di fare un po’ di avanti e indietro alla ricerca dei passaggi meno pericolosi o rischiosi e poi si poteva proseguire fino ai piedi della montagna e da lì cominciare a pensare a come salirci.
Non ci mettiamo molto a capire che lo scenario, quest’anno, è del tutto diverso. Avanziamo, camminiamo, trascorriamo tutti i primi giorni alla ricerca del migliore percorso ma mi risulta immediatamente chiaro che quello che ricordo non serve a niente e che il ghiacciaio, meno di dieci anni dopo, è cambiato. I motivi credo siano riconducibili a una combinazione di fattori: il riscaldamento globale, sicuramente, lo scioglimento veloce di dieci anni di ghiacciaio e, forse, una situazione congiunturale di frattura data dallo scivolamento veloce verso il basso del ghiacciaio. I militari ci dicono anche di aver visto gli effetti dei forti terremoti che recentemente hanno colpito la zona. Non so se ciò sia vero o meno ma quello che so con sicurezza è che venire a capo di questo labirinto che già conosco questa volta mi sembra cento volte più complicato.
Quando arriva il terzo giorno, quello in cui teoricamente avevamo previsto di piazzare il campo 1, siamo poco più che all’inizio del nostro cammino e la sensazione è che il ghiacciaio ci respinga, non voglia farci passare. Ci impegniamo come pazzi ma giriamo quasi a vuoto o in cerchio, troviamo delle vie che pochi metri dopo si rivelano inaccessibili e ci costringono a tornare sui nostri passi e a domandarci quale altra soluzione possiamo prendere. Finiamo le giornate estenuati ma dopo i primi giorni di avanzamento la seconda settimana trascorre senza che vi siano sostanziali miglioramenti: fatichiamo come pazzi, ogni tanto vado avanti io a fare la traccia, ogni tanto Tamara, ci sfiniamo alla ricerca di una soluzione ma, appunto, non solo non riusciamo a uscire dal labirinto, ma non siamo in grado neppure di entrarci. Non portiamo con noi scalette, non montiamo quasi nessuna corda fissa se non pochissimi metri, quelli minimi e necessari: la nostra idea è quella di andare veloci, leggeri, non vogliamo perdere tempo e quindi in prossimità dei crepacci quello che facciamo è meramente saltarli quando possibile, metterci alla ricerca di ponti naturali sospesi fra un lato e l’altro dei crepacci facendoci sicura fra di noi o, addirittura, nel caso di quelli meno profondi, scendere direttamente sul fondo e attraversarli fino al punto di uscita sperando che da lì si possa continuare.
«Non si passa… torniamo indietro.»
«Di lì, Tamara?»
«No, non si passa neanche qui…»
Quello che ho raccontato a Tamara, quello che le ho anticipato dalla mia passata esperienza sembra tutto un altro film: di giorno in giorno, mi domando quanto, oltre al cambiamento climatico, possa aver influito nel creare queste fratture anche il terremoto di cui mi hanno parlato i militari, in effetti verificatosi non troppo lontano in linea d’aria da dove ci troviamo.
Cerchiamo di mantenerci calmi ma è difficile tenere a freno l’impazienza che ormai è pura frustrazione. E quindi andiamo avanti, trascorriamo intere giornate su questo cammino, spesso torniamo quando è già buio, ogni volta cercando di evitare gli sguardi dei nostri compagni che vorrebbero chiederci se abbiamo fatto qualche progresso importante.
Non ci fermiamo mai, non ci diamo tregua, ogni giorno partiamo alla ricerca di un varco. Quando lo troviamo, quando la via che percorriamo crediamo possa essere promettente, lasciamo dietro di noi delle bandierine ogni cento, centocinquanta metri. Sono fatte di bambù, con un nastro rosso sull’estremità superiore, e diventano le nostre briciole di Pollicino per garantirci il rientro la sera in caso di penombra e nebbia e di ripartire non da zero la mattina dopo. Seguiamo il programma, non ci risparmiamo mai ma, trascorsi quasi quindici giorni, ci rendiamo conto di non essere ancora stati in grado di raggiungere la cima di questa prima parte del ghiacciaio. Le registrazioni del GPS, come se ne avessimo davvero bisogno, ci confermano impietosamente quello che già sappiamo. E cioè che nelle ultime giornate la nostra progressione è, a volte, davvero ridicola: settanta, ottanta metri lineari, non di dislivello. Insomma, continuiamo senza soluzione di continuità ad avanzare e tornare indietro, per poi cambiare itinerario e di nuovo avanzare e fermarci e tornare indietro.
Nonostante tutto, non ci arrendiamo, non ci perdiamo d’animo e, nei...