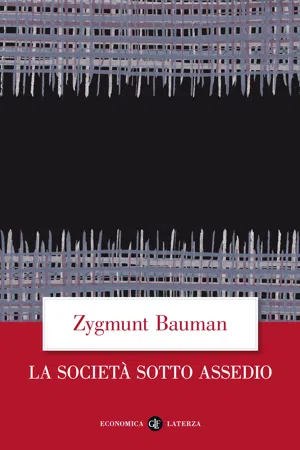
- 326 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La società sotto assedio
Informazioni su questo libro
Esiste ancora la società nel senso tradizionale del termine, ovvero: vicinanza, prossimità, aggregazione, legami reciproci tra le persone? Siamo soli, in ansia cronica, ipercompetitivi. Siamo sotto assedio. Lo scrive Bauman nel suo splendido libro: poco sociologico in senso tradizionale, coinvolgente, caldo. Lelio Demichelis, "Tuttolibri"
Una foto cruda delle metropoli contemporanee. Zygmunt Bauman è tra i più autorevoli teorizzatori della postmodernità. "Corriere della Sera"
Il consiglio di lettura di Ezio Mauro
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
Sozialwissenschaften1.
A caccia della società elusiva
Oggi, come ai tempi di C. Wright Mills, il compito dell’immaginazione sociologica consiste in una simultanea conversione reciproca tra storie private e pubbliche: conversione di problemi affrontati individualmente e gestiti privatamente in tematiche pubbliche, fronteggiate collettivamente, e di interessi pubblici in strategie di vita perseguite individualmente. Sin dalla sua nascita, il luogo deputato della sociologia è stato l’agorà, quel punto d’incontro pubblico-privato in cui (come Cornelius Castoriadis ci ricordava sempre) l’oikos e l’ecclesia si ponevano l’uno di fronte all’altra, nella speranza di comprendersi reciprocamente attraverso un dialogo rigoroso ma cordiale, e soprattutto ricettivo.
La materia prima lavorata dall’immaginazione sociologica è l’esperienza umana. Il prodotto finito dell’immaginazione sociologica, chiamato «realtà sociale», è il frutto del metallo depurato dal minerale grezzo dell’esperienza. Sebbene la sua composizione chimica rifletta inevitabilmente quella del minerale d’origine, esso è anche il risultato del processo di depurazione che separa le sostanze della materia grezza in prodotto utile e scorie, mentre la sua forma dipende dallo stampo (vale a dire la cornice cognitiva) in cui il metallo liquefatto è stato versato.
I prodotti dell’immaginazione sociologica, le realtà sociali immaginate, possono dunque variare di composizione e forma anche se la materia prima da lavorare è fornita dalla medesima esperienza. Non tutte le realtà sociali possono tuttavia essere fuse e plasmate dalla materia grezza fornita dall’esperienza umana; si potrebbe supporre che prodotti contemporanei, per quanto possano essere diversi, presentino una stessa «aria di famiglia» che tradisce la loro origine comune. Ma possiamo anche immaginare che allorché i depositi di un dato minerale grezzo si esauriscono e si passa a fondere un altro tipo di minerale, le tecniche di depurazione vengano prima o poi modificate e gli stampi rimodellati.
Personalmente ritengo che le radici dell’odierno riorientamento dell’indagine sociologica, i mutamenti nella nostra visione dei prodotti da cercare e le tecniche che potrebbero portare a scoprirli siano meglio compresi se correlati al radicale mutamento avvenuto nell’esperienza comune dell’essere-nel-mondo.
L’immaginazione manageriale
Il tipo di immaginazione destinato a condurre al «consenso ortodosso» (così definito da Anthony Giddens), ancora prevalente una ventina d’anni fa in quasi tutti i dipartimenti di sociologia, fu innescato e diffuso dall’esperienza di vita condotta nell’ambito di uno «spazio essenzialmente coordinato» (per citare come al solito Talcott Parsons). Seguendo l’abitudine della civetta di Minerva, che volava solo sul far della notte (vale a dire, non molto tempo prima che il sole sorgesse non semplicemente su un altro giorno, ma su un giorno diverso), Parsons ha compendiato la storia del pensiero sociale come un tentativo pervicace, anche se eccessivamente prolungato, viziato e contorto, di svelare quello che considerava il principale mistero dell’intera esistenza umana, suggerito per primo da Hobbes: come mai le azioni di attori volontari risultano tuttavia non casuali, e come mai dalla trama di azioni basate su motivazioni personali si dipanano modelli regolari e duraturi? Come a voler seguire la massima di Karl Marx secondo cui «l’anatomia dell’uomo fornisce una chiave per l’anatomia della scimmia», Parsons avrebbe anche riscritto la storia della sociologia come un lungo pellegrinaggio verso una destinazione preordinata, e segnatamente la sua stessa scoperta del «sistema» quale ultima, disperatamente cercata e definitiva risposta al quesito hobbesiano. Un «sistema» dotato di due forti braccia: una (la «struttura») che attanaglia gli attori dall’esterno e stabilisce limiti alla loro libertà; l’altra (la «cultura») che penetra nell’intimo degli attori, il luogo in cui nascono e si sviluppano desideri e propositi, e che forgia il libero arbitrio in una forma che fa apparire la più ferrea delle morse strutturali un confortevole e premuroso abbraccio.
A tale «sistema» Parsons attribuì un fine, e questo fine era la sopravvivenza stessa del sistema: restare vivi il più a lungo possibile in una forma modificata il meno possibile. Qualunque altra finalità potesse apparentemente avere, questo sistema mirava innanzitutto a garantire la propria stabilità nel tempo. A tal fine, esso «preservò il proprio modello» gestendo – riducendo e neutralizzando – le tensioni che lo minacciavano. Qualunque cosa svolgesse tale compito, contribuisse a preservare lo status quo e la sua invulnerabilità a forze tangenti o di taglio, era «funzionale»; qualsiasi cosa contravvenisse a tali tentativi, premesse a favore del cambiamento e quindi aggiungesse tensione, era «disfunzionale». Il sistema era in buono stato di salute (definito da Parsons «autoequilibrio omeostatico») se e solo se coltivava con successo la prima categoria di attributi e rifiutava la seconda. Struttura e cultura erano i principali strumenti al servizio del duplice compito. Operavano in modo diverso e con meccanismi diversi, ma convergevano verso il medesimo obiettivo. Cooperavano e si completavano a vicenda nella guerra di attrito in corso contro la casualità e la contingenza, nonché contro i mutamenti del modello. Entrambe erano essenzialmente forze conservatrici, preposte a mantenere le cose in una forma immutata.
Per quanto strano possa apparire questo ritratto della realtà sociale, a noi che abbiamo la ventura di vivere nella fase di modernità software anziché hardware, liquida anziché solida, esso ben si adattava alla società immaginata sul modello di un ufficio amministrativo. Nella fase hardware, solida, della modernità, buona parte dell’evidenza empirica spingeva l’immaginazione in quella direzione. La pressione maggiore cui erano più probabilmente soggetti uomini e donne di quella società era l’imperativo della conformità agli standard e dell’ossequio alle procedure assegnate a ciascun ruolo e status. Quel tipo di società aveva forse poco tempo e ancor meno simpatia per le restrizioni che aveva ereditate e mostrava pochi scrupoli nello spazzarle via, ma era intenta a costruirsi «nuove e migliori» restrizioni, e comunque non tollerava alcuna forma individuale di cincischiamento con le regole. La linea di confine tra rispetto e deviazione dalla norma era nettamente delineata e ben controllata. L’antichità dei costumi poteva forse essersi svalutata come titolo di autorità, ma si provvide a creare nuove routine, destinate a legare ancor più saldamente, e – a differenza di quelle dilapidate e putrefatte che andarono a sostituire – per un tempo lunghissimo. Forse le singole piante umane erano state sradicate a forza dai siti in cui erano germinate e spuntate durante l’ancien régime, ma esclusivamente al fine di essere reimpiantate in un giardino societario progettato meglio e disegnato razionalmente.
La modernità fu una risposta alla graduale, ma incessante e allarmante, disintegrazione dell’ancien régime, con il suo arcipelago di comunità locali sparpagliate ed essenzialmente autonome, governate da poteri sovralocali noti per la loro smodata cupidigia, ma con scarsissime ambizioni e capacità manageriali. Si trattava, secondo la memorabile espressione di Ernest Gellner, di uno «stato di odontoiatria», specializzato nella pratica dell’estrazione mediante tortura. Nel complesso, le doti manageriali dei prìncipi si limitavano alla confisca delle eccedenze di prodotto; essi si guardavano bene dall’intervenire nel sistema di produzione.
La «ricchezza delle nazioni» – se mai tale idea germogliò davvero – era ritenuta dai governanti dello stato premoderno qualcosa da godere o da subire, ma che andava docilmente accettata, così come avveniva con tutti agli altri imperscrutabili verdetti del destino. Fu considerata un compito da perseguire, e dunque un oggetto di esame, interesse, progettazione e azione, solo nell’epoca in cui non si poté più contare sul monotono autoriprodursi delle condizioni in cui si era soliti produrre i beni – e soprattutto sulla solidità di quello che finì con l’essere visto come l’ordine «sociale», in quanto distinto da quello divino. Come Alexis de Tocqueville dimostrò, l’ancien régime crollò molto prima che i rivoluzionari francesi si spingessero laddove nessuno aveva mai osato entrare prima: nell’ancora inesplorato territorio della codificazione di un nuovo ordine artificialmente progettato, controllato e amministrato dall’uomo e della sua introduzione nei caotici e poco maneggevoli affari umani.
La modernità nacque sotto il segno di siffatto ordine: l’ordine visto come compito, come una questione di pianificazione razionale, di controllo accurato e soprattutto di minuziosa gestione. La modernità votò se stessa a rendere il mondo gestibile e quindi a gestirlo quotidianamente; tale ardore manageriale era instillato dalla convinzione non del tutto infondata che le cose, se lasciate a se stesse, finiscono in malora o fuori controllo. La modernità cominciò a eliminare l’accidentale e il contingente. Se mai si può davvero parlare del tristemente noto «progetto della modernità», lo si può immaginare soltanto come una glossa retrospettiva alla ferma intenzione di introdurre determinazione laddove avrebbero altrimenti dominato casualità e fatalità; di rendere l’ambiguo eindeutig, l’opaco trasparente, lo spontaneo calcolabile e l’incerto prevedibile; di introdurre il riconoscimento del fine nelle cose e quindi farle lottare per il conseguimento di quel fine.
Nel riflettere, riciclare e rielaborare l’esperienza moderna, le scienze sociali, esse stesse un’invenzione moderna, presero a esplorare i misteriosi modi in cui il libero arbitrio interviene nella produzione di regole, norme e modelli – quei «fatti sociali» di Émile Durkheim: esterni, coercitivi, ciechi alle contese individuali e sordi agli struggimenti individuali. Nella loro applicazione pratica – questo era quanto speravano le incipienti scienze sociali – tali scoperte sarebbero servite a costruire regole, norme e modelli nuovi e migliori, e ad assicurarne l’adempimento e il rispetto una volta introdotte. La teoria sociale condivideva con il resto delle scienze moderne lo stimolo a «conoscere la natura per poterla padroneggiare» e dunque a meglio conformarla alle esigenze della specie umana; nel caso delle scienze sociali, tuttavia, «padroneggiare la natura» significò essenzialmente padroneggiare la stessa specie umana, e ciò a sua volta significò guidare e ottimizzare i movimenti di ogni singolo membro di quella specie.
Ricordo che all’epoca in cui ero studente, mezzo secolo fa, la psicologia sociale veniva insegnata principalmente in base ai risultati di esperimenti di laboratorio in cui si introducevano dei topi affamati in una specie di labirinto e quindi si registrava la velocità con cui essi imparavano, tramite tentativi ed errori, la strada più breve per raggiungere un pezzetto di cibo posto all’estremità opposta del labirinto. Meno tempo impiegavano per raggiungere l’ambito obiettivo, più veniva considerato riuscito il loro processo di apprendimento, la strada maestra alla sopravvivenza. Sono stato abbastanza fortunato da avere avuto insegnanti giudiziosi, e nessuno di essi affermò mai che «i topi sono come gli uomini»: ma comune a tutti, insegnanti e studenti, era il tacito presupposto che dal comportamento dei ratti nel labirinto avremmo potuto imparare moltissime cose sulla logica umana nel nostro mondo così simile a un labirinto; non perché i ratti fossero «come gli uomini», ma perché il labirinto costruito in laboratorio sembrava così simile al mondo in cui noi esseri umani cercavamo, scoprivamo e imparavamo il modo di comportarci nella vita quotidiana. Al pari di un labirinto, il nostro mondo sembrava fatto di mura solide, impenetrabili e impervie, impossibili da abbattere e destinate a durare immutate, se non per sempre, di certo per tutta la durata del nostro processo di apprendimento. Al pari del labirinto, il nostro mondo era pieno di bivi e incroci, ciascuno dei quali presentava una sola strada giusta e tante vie seducenti ma ingannevoli, che finivano in un vicolo cieco o allontanavano dall’obiettivo. Come nel labirinto del laboratorio, anche nel nostro mondo la ricompensa veniva collocata sempre nello stesso posto; imparare la strada che portava in quel luogo e quindi seguirla con incessante monotonia era evidentemente l’unica arte che occorresse padroneggiare.
In poche parole: il labirinto del laboratorio era una replica in miniatura del «grande mondo» degli esseri umani; più esattamente, della visualizzaz...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Parte prima. Politica globale
- 1. A caccia della società elusiva
- 2. La grande separazione-stadio 2
- 3. Vivere e morire nella terra di frontiera planetaria
- Parte seconda. La politica della vita
- 4. La (in)felicità dei piaceri incerti
- 5. Come appare in TV
- 6. Vita che consuma
- 7. Da spettatore ad attore
- Conclusione. Utopia senza «topos»
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a La società sotto assedio di Zygmunt Bauman, Sergio Minucci in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Sozialwissenschaften e Essays in Politik & Internationale Beziehungen. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.