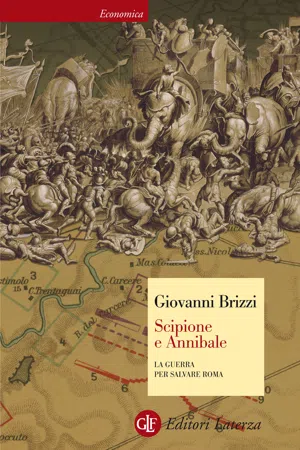
This is a test
- 416 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Dettagli del libro
Anteprima del libro
Indice dei contenuti
Citazioni
Informazioni sul libro
Con l'elmo di Scipio e la spada del cartaginese ridotti entrambi a caricatura, era difficile tentare una biografia parallela dei due. Ci riesce alla grande Giovanni Brizzi in questo testo acrobatico che non solo rovescia lo schema storico di partenza e ri-umanizza i due generali ma – riscattando Annibale – ne fa il modello cui Scipione tenta per tutta la vita di uniformarsi e non solo sul piano militare.Paolo Rumiz, "la Repubblica"Storia, politica e strategia nelle vite parallele di due grandi uomini: racconto e ricerca si intrecciano in pagine più verosimili del vero.
Domande frequenti
È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui
Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì, puoi accedere a Scipione e Annibale di Giovanni Brizzi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia antica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia anticaCapitolo II. Le strade divergono
1. Scipione a Roma
La scomparsa di Fabio Massimo non aveva sopito, in Roma, l’ostilità di una parte almeno della nobilitas nei confronti di Publio; e, anzi, persino alcuni degli amici di un tempo erano giunti ora a schierarsi contro di lui. La fronda era cominciata ben avanti il suo ritorno. All’indomani della vittoria ai Campi Magni, quando la prima legazione di Cartagine si era presentata in senato a proporre la ratifica della pace concordata con Publio, vi era stato un tentativo, orchestrato da Marco Livio e subito appoggiato da Valerio Levino e soprattutto dai Servilii, una gens allora emergente e fino a quel momento amica degli Scipioni, di imporre la continuazione della guerra. Vi era stata, poco dopo, l’esplicita richiesta di entrambi i consoli dell’anno seguente di essere inviati oltremare – chissà perché, tutti, adesso, volevano andarci! –; e se, certo, i comizî, interpellati dai tribuni della plebe avevano espresso la volontà precisa che le operazioni continuassero ad essere condotte da Publio, alla successiva rottura della tregua Claudio Nerone aveva, nondimeno, ottenuto l’Africa come provincia – perché potesse soccorrere Scipione, beninteso... – con un imperium equiparato a quello di lui. Per l’anno seguente ancora i Servilii avevano manovrato onde ritardare i comizî. Il console Marco, valendosi dello strumento della religione – non solo il vecchio Fabio sapeva servirsi degli auguri... –, era riuscito a rimanere in carica assai più a lungo della norma; e finalmente aveva nominato dittatore il fratello Caio perché indicesse le elezioni quando più gli faceva comodo, vale a dire dopo le idi di marzo. Da ultimo uno dei consoli eletti – Lentulo, un gentilis di Scipione, ma, certo, non un suo amico – aveva tentato nuovamente di impedire la ratifica ultima della pace fino a che non fosse entrato in carica egli stesso, onde potersene occupare di persona; e solo l’azione decisa di due fedeli seguaci dell’Africano, Quinto Minucio Thermo e Manio Acilio Glabrione, allora tribuni della plebe, ne aveva sventato le manovre. Si era dovuto ricorrere al voto dei comitia tributa; ma, nonostante il parere delle assemblee, unanimemente favorevoli a Publio, il senato aveva cercato un ulteriore compromesso, affidando al console in carica una flotta e inviandolo in Sicilia perché salpasse alla volta dell’Africa nel caso in cui fossero fallite le trattative. Benché Lentulo avesse proposto poi – ancora! – di prolungare la guerra, di nuovo, convocato dai tribuni, il popolo aveva premiato col suo voto le scelte di Scipione; che erano, questa volta, anche quelle della maggioranza senatoria. Riuscendo a opporsi anche alla distruzione di Cartagine, chiesta invano da ultimo da uno dei partigiani dello stesso Lentulo, Publio aveva completato con un pieno successo politico la sua brillantissima campagna militare.
Ratificata la pace dai feziali, era venuto il momento di tornare a Roma; e Scipione decise di assaporare appieno il proprio successo sbarcando con una parte dell’esercito a Lilibeo invece che a Ostia, per poi risalire la penisola accolto ovunque, durante una marcia che durò settimane, da folle in delirio; le quali esultavano per la fine di una guerra spaventosa e, insieme, osannavano l’imperator che aveva ottenuto per loro la più completa vittoria, accorrendo spontaneamente per manifestargli, al passaggio, riconoscenza e affetto. Non si poté naturalmente impedire, questa volta, che il vincitore di Annibale celebrasse uno splendido trionfo; e organizzasse, l’anno dopo, i giochi promessi mentre era in Africa. Non solo a sé, tuttavia, pensò Scipione, ma al popolo e soprattutto ai soldati. La plebe urbana fu gratificata con una vendita straordinaria di grano a quattro assi per misura, un prezzo ben lontano da quelli allora vigenti in città; e ce ne fu per tutti. Quanto ai veterani, benché fossero piccoli proprietarî, molti di loro erano ridotti in gravi difficoltà economiche da periodi di ferma talvolta più che decennali; sicché Publio ottenne che si concedessero loro, traendo il terreno dall’ager publicus confiscato in Sannio e in Apulia, due iugeri di terra per ogni anno di servizio trascorso sotto le armi in Spagna o in Africa. Era un ben piccolo compenso per le loro passate sofferenze e per i loro meriti attuali; e il senato fu lieto di concederlo. Il provvedimento non fu tuttavia lasciato gestire a Scipione, ma fu affidato al pretore urbano, che nominò allo scopo una commissione apposita; e a Publio riuscì solo di introdurvi, per controllarne l’operato e riferirgli, uno dei suoi amici, Quinto Cecilio Metello. Poco più tardi al vincitore di Annibale si concessero gli onori supremi: fu infatti, malgrado la giovane età, eletto censore, e il collega plebeo, Publio Elio Paeto, scavalcando con loro grande scorno tutti i censori più anziani, lo nominò poi princeps senatus, attribuendo così a lui quel titolo che era rimasto vacante dopo la morte di Fabio Massimo.
Questa ininterrotta serie di successi accrebbe però a dismisura la gelosia dei suoi pari. Publio – si mormorava – aveva detenuto l’imperium ininterrottamente per dieci anni, ben più a lungo di quanto non avessero fatto, malgrado l’emergenza della guerra, Marcello e lo stesso Fabio; era passato di vittoria in vittoria in Spagna e in Africa; vantava di essere ispirato nelle sue azioni direttamente dagli dei – era ben noto, per esempio, che, prima di prendere una decisione importante soleva ritirarsi per ore in raccoglimento nel tempio di Giove Capitolino –; ed era amato o rispettato, oltre che dai suoi soldati e dal popolo, dagli Spagnoli, che lo avevano salutato come re, e dagli stessi Cartaginesi. Tornò allora a circolare nella Curia, sia pur solo come un perfido bisbiglio, la voce, estremamente insidiosa, già propalata anni prima da Fabio, di adfectatio regni, di aspirazione alla regalità. Anche per questo Publio accettò senza reagire la posizione apparentemente sempre più forte dei Servilii e dei Claudii; e preferì poi usare con estrema moderazione l’arma della censura, evitando di servirsene per attaccare gli avversari politici. Qualcuno avrebbe senz’altro visto in ciò un segno della sua inettitudine politica; ma, attraverso una lectio senatus assolutamente pacifica, egli volle inviare invece un segnale di buona volontà a tutti i nobiles. A dire il vero, per chi aveva conosciuto i lunghi e pericolosi giorni di milizia oltremare quell’attività prestigiosa ma senza scosse costituiva un’uggia mortale; sicché nacque addirittura, in lui, la tentazione – che l’Africano non si peritò di ostentare in pubblico – di concedersi un periodo di otium e di riprendere i contatti con la cultura greca interrotti alla sua partenza da Siracusa.
E tuttavia egli fu, da subito, indotto a rinunciare all’idea; e, anzi, a intervenire sia pur occultamente nella vita pubblica romana. Quanto si attendeva da anni stava infatti cominciando puntualmente a prodursi; e la svolta che andava manifestandosi entro il panorama politico della res publica proiettava, ovviamente, un’ombra minacciosa proprio su quel mondo greco che Publio continuava, malgrado tutto, ad amare. Sul sentire della gente comune, ma anche di una parte dei patres, agivano, in quel momento, impulsi tra loro contrastanti. Al sollievo nato con la fine stessa dell’incubo annibalico e al desiderio di una tranquillità finalmente duratura facevano cioè da contrappeso gli istinti inconsci generati dalla lunga e spaventosa guerra che aveva infuriato per quindici anni sul suolo d’Italia; sicché non solo nei vicoli di Roma, ma nella stessa solenne aula del senato ombre e futili terrori nascevano allora più numerosi che le mosche in un letamaio. Aggravato dal rancore verso gli ex alleati fedifraghi e verso quegli Stati che, come la Macedonia, erano intervenuti arbitrariamente nel conflitto, incombeva infatti sull’Urbe un nefasto strascico di dubbi e di paure. Sulla diffidenza si basava ormai, da un lato, il rapporto con i socii italici. La prova non sempre felice che la federazione aveva offerto di sé, lo strappo imprevisto di quel tessuto di intese e di vincoli famigliari sul quale la res publica aveva fondato fino ad allora la sua forza avevano generato inevitabilmente la più profonda sfiducia nei confronti degli alleati, e non solo di quelli infedeli. Solo i Latini – si diceva – e non sempre nemmeno loro, avevano risposto senza riserve all’appello; e Roma mostrava ora di sentirsi latina, dimenticando secoli della sua storia. Le stesse misure volte ad alimentare la resistenza contro l’invasore punico avevano esaltato i riscoperti caratteri etnici della città; e avevano scatenato con ciò un’orgogliosa coscienza di sé, che ancora non aveva potuto essere né rimossa né sopita.
Esisteva dunque, inespresso ma avvertibile, il timore che anche quanti avevano retto alla prova annibalica potessero, un giorno, defezionare a loro volta; ma, peggio ancora, il sospetto si proiettava ben oltre i limiti stessi della federazione, gettando una luce sinistra sul panorama politico internazionale e popolandolo di inquietudini spesso infondate, ma non per questo meno intensamente sentite. Durante il conflitto appena concluso la res publica era stata indotta a lungo a dubitare persino della propria capacità di sopravvivere; a nessun costo, dunque, doveva essere rivissuto, mai più, l’incubo di un’invasione della penisola. Afflitti da una specie di percezione distorta, da uno stato anormale e disordinato dello spirito – Scipione lo aveva avvertito immediatamente, simile a un miasma malsano, nel momento stesso in cui era rientrato a Roma dalla Spagna –, i Quiriti avevano cominciato adesso a scrutare il Mediterraneo con occhi nuovi, guatando preoccupati qualunque movimento si verificasse entro il loro orizzonte.
Particolarmente allarmante appariva quindi, in quel momento, la serie di azioni militari intraprese dal vecchio nemico, Filippo V. Due anni dopo la fine della guerra con Roma – era il cinquecentocinquantunesimo anno dell’Urbe, il secondo della centoquarantaquattresima Olimpiade58; consoli erano Cneo Servilio Cepione e Caio Servilio Gemino – il sovrano macedone aveva stretto un’intesa segreta con il re di Siria, Antioco III, il più potente dei monarchi ellenistici, reduce dalla vittoriosa spedizione contro le satrapie orientali del suo regno: la mira, comune ai due dinasti, era quella di spartirsi i possedimenti extra egiziani dello Stato tolemaico, che traversava allora una fase di estrema difficoltà.
Durante le operazioni condotte in Egeo nel corso degli anni immediatamente successivi il sovrano antigonide era riuscito a occupare alcune delle fortezze e delle basi appartenute all’Egitto; ma la serie di attacchi indiscriminati sferrati dalla flotta sua e dei suoi alleati Cretesi contro ogni tipo di naviglio mercantile e, più ancora, gli atti di crudeltà commessi nel corso della conquista – contro Cio, per esempio – gli avevano attirato l’ostilità dei Rodii. La vittoria ottenuta da Filippo nelle acque di Lade aveva spinto a entrare in guerra anche il regno di Pergamo; e le flotte dei coalizzati, ormai superiori a quella macedone, lo avevano costretto ad accettare, al largo di Chio, una seconda, più grande battaglia navale che, se era stata di esito incerto – una vittoria «alla Cadmea» per Filippo, l’avrebbero definita i Greci –, aveva segnato però di fatto la fine del sogno antigonide di talassocrazia sull’Egeo.
Per terra, invece, la superiorità macedone era indiscussa; e preoccupante al punto da indurre i Rodii e i Pergameni a inviare, nell’anno cinquecentocinquantatreesimo ab Urbe condita, un’ambascieria congiunta per chiedere a Roma di intervenire. Era stato in questa circostanza che il senato aveva appreso dell’intesa segreta tra Antioco e Filippo; sicché, allarmati da tale notizia e, a un tempo, formalmente preoccupati per la sorte di Pergamo, culla dell’avita stirpe troiana, i patres avevano inviato una legazione che verificasse lo stato delle cose in oriente. Questa, arrogandosi arbitrariamente un diritto che non le competeva, aveva consegnato – tramite il più giovane dei suoi membri, Marco Emilio Lepido, figlio del Marco Emilio già amico degli Scipioni – un ultimatum al re di Macedonia, intimandogli di non attaccare i territori di Tolemeo, di non far guerra ai Greci, di accettare un arbitrato per la contesa con Attalo e i Rodii.
Apparentemente sopita, la rivalità tra le due potenze, la greca e l’italica, sopravviveva in effetti latente anche dopo la pace di Fenice, e i movimenti che il sovrano antigonide aveva intrapreso a levante erano indubbiamente riusciti a rinfocolarla. Il rancore per l’aiuto prestato ad Annibale, pur senz’altro presente e vivo tra il popolo di Roma e, ciò ch’era peggio, all’interno del senato, non era tuttavia, in sé, uno stimolo sufficiente per spingere alla guerra uno Stato che di guerra era mortalmente stanco, né a muoverlo bastava più, come era accaduto a volte in passato, una semplice richiesta da parte di una popolazione greca: già l’anno prima Roma aveva respinto, e non senza rudezza, un’ambascieria degli Etoli venuta a chiedere aiuto. Ora, però, l’intesa segreta tra Filippo e Antioco era sentita dai più, all’interno del senato, come un’effettiva minaccia. L’incubo di una coalizione ostile non aveva in realtà, nell’occasione, il minimo fondamento, poiché i piani dei due re non concernevano in alcun modo la penisola italica; ma, come Scipione aveva purtroppo previsto da tempo, l’approccio con la grecità oltremare, complicato dalle precedenti incomprensioni e dai nuovi, gravissimi sintomi, si era fatto subito difficile. Al momento di allargare all’intero Oriente mediterraneo la sfera dei loro interessi, i Romani sembravano non comprender nulla della singolare natura di quel mondo. Alla classe dirigente della res publica, abituata dalle vicende recenti a pensare in termini di strategia globale, l’assurdo gioco politico che i Greci praticavano da sempre tra loro riusciva per lo più indecifrabile. In realtà, le lotte per l’egemonia che, vieppiù, turbavano i sonni di Roma erano lotte interne, coinvolgevano cioè solo l’ambito ellenico senza toccare, di fatto, per nulla gli ambiti circostanti; e lo stesso frenetico dinamismo politico che – con le sue contese intestine, gli oscuri intrighi, le alleanze provvisorie e mutevoli – agitava senza sosta la superficie di quel mondo era più apparente che reale. Proprio le incessanti trasformazioni al suo interno costituivano, infatti, le fasi di una sorta di processo vitale costantemente in atto, destinato di volta in volta a ristabilirne i delicati equilibri.
E tuttavia, con il suo inconsulto agitarsi ai limiti dell’orizzonte, Filippo V rischiava di attirarsi da parte di Roma un’attenzione che, Scipione ne era certo, avrebbe potuto riuscirgli gravemente nefasta; e rischiava di pagare anche per la pugnalata che – ahilui, con mano malferma... – aveva inferto quindici anni prima alle spalle della res publica. Proprio nell’intento di calmare le paure inconscie dei Romani, una parte dei quali avrebbe voluto addirittura distruggere la città africana, Publio aveva disarmato definitivamente Cartagine per trattato; e, nel far questo, aveva inteso ispirarsi – traendone le clausole da Tucidide, che ben conosceva – a un criterio politico familiare e diffuso nel mondo greco: quello della dissuasione militare. Intendeva continuare così, rafforzando al massimo le difese della penisola, tanto quelle attive – col render pronto ed efficiente l’apparato bellico di Roma –, quanto quelle passive – col disarmare, dopo Cartagine, anche gli altri nemici vinti, privandoli soprattutto della flotta perché fosse loro preclusa ogni possibilità di invadere l’Italia –; e sperava, in tal modo, di sopire pian piano le angosce che avvertiva, non sempre espresse eppure palesi e fortissime, all’interno del popolo e dello stesso senato.
Questa linea strategica – per di più ancora indefinita, in lui – non sarebbe tuttavia bastata a risolvere, in quel momento, il problema che andava profilandosi a levante. L’idea di rendere innocua o di limitare politicamente la Macedonia non era infatti applicabile a una Potenza che, come quella antigonide, non era stata ancora militarmente sconfitta in modo decisivo. Quanto alla forza di Roma – che Scipione sapeva esser soverchiante... –, il sovrano macedone, fidando nel valore delle sue falangi, che non erano state mai battute sul campo da alcuna armata esterna al mondo greco, e a capo oltretutto di quello che era pur sempre un grande Stato autonomo, non ne era pienamente conscio; e rifiutava quindi, malgrado i moniti fattigli pervenire privatamente dallo stesso Publio, di lasciarsi distogliere dai suoi disegni politici.
Proprio perché, come Scipione, erano ben consapevoli che quello con la Macedonia era uno scontro in fondo senza grossi rischi, vi erano però in quel momento, in Roma, alcuni uomini che, diversamente da Publio, volevano a tutti i costi la guerra. Erano gli esponenti di un gruppo di pressione allora emergente in senato, che riuniva i principali esperti nelle questioni orientali: oltre al giovane Lepido, che vi si era accostato solo di recente, ne facevano parte, tra gli altri – ed erano tutti ben più influenti di lui – Publio Sempronio Tuditano, Marco Valerio Levino e Publio Sulpicio Galba. Galba, in particolare, non aveva scrupoli a dipingere la minaccia macedone con le tinte più fosche possibile; fosse pure, Filippo, inferiore ad Annibale – andava dicendo –, era certo però che egli e la Macedonia rappresentavano una minaccia ben più formidabile di quella a suo tempo costituita da Pirro, e che erano sul punto di invadere l’Italia. Meglio, dunque, prevenirli; e attaccare il nemico sul suo stesso territorio, risparmiando nuovi orrori alla penisola. I suoi propositi erano, per l’Africano, assolutamente chiari: dal contenuto stesso dei suoi discorsi era facile intuire come il primo risultato che egli si proponeva di ottenere da una vittoria considerata sicura era quello, se non di scalfire la sua posizione, almeno di creare rispetto a lui un’alternativa politica precisa, nata da un analogo successo militare.
Benché fallace, l’argomento della «minaccia» macedone cominciava però a pesare; sicché, emotivamente sollecitato in maniera adeguata da uomini nella cui competenz...
Indice dei contenuti
- Parte prima
- Prologo. Scipione: La vigilia di Zama
- Capitolo I. Rumori di guerra
- Capitolo II. La disfatta e la riscossa
- Capitolo III. Dalla Spagna all’Africa
- Parte seconda
- Prologo. Annibale: la vigilia di Zama
- Capitolo I. L’incontro e lo scontro
- Capitolo II. Le strade divergono
- Capitolo III. Testamenti e congedi
- Nota sulle fonti
- Per ulteriori letture