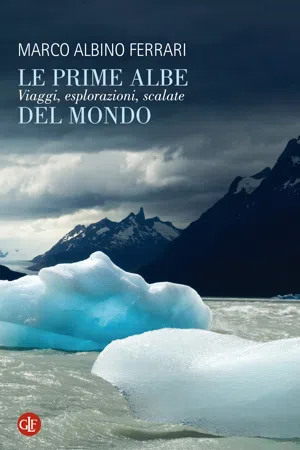Seconda parte
Sul Pilone Centrale del Frêney, verso la cuspide sommitale (4.400 m).
1
Ci fu un momento che le giornate della segretaria di redazione Camilla divennero improvvisamente più frenetiche. Telefonava di continuo, prendeva appunti, correva nell’ufficio dell’editore a riferire. Stava organizzando un incontro allargato tra diversi collaboratori scelti per dare il via alla nuova avventura editoriale che da mesi era nell’aria. Si trattava del varo di una collana di letteratura di montagna.
Le idee partorite dal piccolo cenacolo letterario che si riunì di lì a breve puntavano su certe novità in lingua inglese, affiancate dal ritorno di vecchi classici, magari con nuove traduzioni. La rivista “Alp”, questo era l’intento dell’editore, avrebbe poi rullato la grancassa promuovendone le uscite. Ma il comitato editoriale – così venne seriosamente definito il piccolo cenacolo nel quale in quei primi tempi io non ero stato ammesso – voleva mirare anche a un obiettivo non secondario: pubblicare libri migliori della concorrenza, cioè della collana partorita dalla “Rivista della montagna”. Il che, a ripensarci ora, non era poi così difficile. La casa editrice della “Rivista” era molto più forte nella pubblicazione delle guide, mentre la collana di lettura aveva un’immagine un po’ vecchiotta, e contava su una successione di volumi diversi tra loro per formato e grafica, con copertine non particolarmente attraenti. Ed era chiamata, in un moto di seriosità sabauda, “Biblioteca della montagna”. Quella di “Alp”, invece, avrebbe avuto un nome ben più fantasioso: “I Licheni”. E il motivo fu spiegato in un testo riportato sull’aletta di copertina del primo volume. Testo che – a dire il vero – rivela oggi un mieloso andazzo new-age. «I licheni sono organismi che vivono in condizioni estreme, dunque sono il simbolo degli ultimi terreni selvaggi, dell’esplorazione e dell’avventura, della perseveranza verso un obiettivo. Ma anche il simbolo della complessità e della solidarietà, da intendere come unica via praticabile per il raggiungimento di un’armonia con la natura».
Qualche tempo dopo apparve nelle librerie italiane il primo volume dei “Licheni”. In copertina campeggiava un’immagine stilizzata, essenziale e al tempo stesso drammatica: una corda sul limite della lacerazione e tenuta insieme da un ultimo, esile refolo al quale, con ogni probabilità, doveva essere attaccata la vita di qualcuno. Il titolo, che duettava con quella corda malridotta, era La morte sospesa, traduzione di Touching the Void, grande successo internazionale e opera prima dell’alpinista scrittore inglese Joe Simpson.
L’odissea di Simpson in Perù, dai 6.536 metri della cima del Siula Grande fino al campo base, era una pagina di letteratura che aveva lasciato senza fiato lettori in tutto il mondo. E già durante la traduzione si era capito che sarebbe stato un successo anche in Italia. La forza di quella lama d’acciaio che brilla nella notte avvicinandosi alla corda dove è appeso Joe, e tutto il resto che ne consegue, era esattamente ciò che si voleva editare, e che il pubblico di quegli anni voleva leggere. A Simon era bastato appoggiare la lama al nylon in tensione e, senza neppure premere, la corda era esplosa lasciando cadere Joe Simpson ferito per quaranta metri nel baratro nero del crepaccio. Ma Joe era veramente morto? La vita si era davvero spenta dentro di lui dopo gli sforzi della tremenda discesa con la gamba maciullata, dopo la fatica nel gelo dell’alta quota, il digiuno, il dondolare a testa in giù tra le slavine per un tempo incalcolabile, e infine dopo il volo nel crepaccio?
«Sì, è morto», si era detto il suo compagno Simon guardando il moncone sfilacciato di quella maledetta corda che lo aveva schiacciato contro la parete e trascinato verso il vuoto. «Sono vivo, ma devo dimenticare Joe fino a domani mattina se voglio resistere».
Joe, invece, non era affatto morto. E nelle ore successive sarebbe riuscito a risalire fino al labbro superiore del crepaccio. Poi, una volta uscito, avrebbe trascinato per ore il suo corpo rotto sul ghiacciaio, fino alla morena, fino al campo base. Arrivando appena in tempo per farsi soccorrere, prima che i compagni fossero partiti credendolo morto.
C’era un particolare che il volume di Simpson mostrava in alto e ben in evidenza sulla costola, il numero “1”. Segno che la nuova collana avrebbe avuto una continuazione e che, in questo modo, avrebbe più o meno raccolto l’eredità storica delle diverse collane varate e poi chiuse nei decenni precedenti: per esempio quella di Adolfo Balliano avviata nel 1929 con il titolo “La piccozza e la penna”, o la collana “Montagna” dell’Editrice L’Eroica pubblicata dagli anni Trenta, o ancora la celebre “Montagne” di Zanichelli iniziata nel 1961, o la “Voci dai monti” di Tamari degli anni Sessanta e Settanta, o, infine, i più completi “Exploit” della dall’Oglio in gran voga negli anni Settanta.
Bene, si dissero quelli del comitato dopo l’uscita di Joe Simpson, e adesso? Si trattava di riordinare con una certa logica una vera e propria geografia di storie e di personaggi. La scelta era vastissima, anche perché da quando sul finire del Settecento era nato l’alpinismo con lo scienziato ginevrino Horace-Bénédict de Saussure (lo ritroveremo in questa storia) non si era mai smesso di pubblicare libri di memorie legate alla montagna.
Gli scaffali delle biblioteche si piegano sotto il peso di volumi che raccontano esplorazioni di vario tipo. E a dirlo era più di tutti la biblioteca di via Barbaroux, stracolma di libri d’annata. Non viene in mente esploratore o alpinista di una certa notorietà che non si sia in qualche modo raccontato. E ciò per ragioni ovvie. Questo tipo di imprese si svolgono in luoghi dove lo sguardo del pubblico non può arrivare: la letteratura di montagna è prima di tutto una letteratura necessaria. Scrivere per essere visti. Raccontare per esistere. Ma ovviamente nei libri di montagna non c’è solo l’aspetto prettamente testimoniale, c’è di più. Spesso c’è il tentativo di spiegare il perché di un’attività in fondo insensata e a volte al limite della follia.
Cosa spinge un individuo a sfidare il vuoto? Qual è il motivo per il quale si decide di patire freddo, disagi, intemperie, fatiche inumane?
Per esempio, c’è una risposta a quel perché delle scalate nello zelo scientifico dell’illuminista de Saussure che, arrivando in cima al Monte Bianco, scrive: «Osservai l’igrometro, l’elettronomo, la struttura delle rocce che ci circondavano; raccolsi vari campioni di quelle stesse rocce; ammirammo l’immensa distesa nell’aspetto che si offriva a noi»; o nel trascendentalismo misticheggiante dell’americano di metà Ottocento John Muir: «Ora siamo nelle montagne e le montagne sono dentro di noi»; o nel decadentismo di Eugen Guido Lammer: «Grazie, ché mi avete fatto sorseggiare il più dolce di tutti i dolci godimenti che la vita può offrire: di aver bagnato le mie labbra nella coppa della morte»; o nel ribellismo di fine anni Sessanta dell’americano Steve Roper: «Forse ce ne stavamo vicini alle pareti perché non volevamo far parte della società. Noi, topi di parete della Yosemite Valley negli anni Sessanta, avevamo lasciato il college, senza meta, con passo veloce». Dunque, volenti o no, ci si sarebbe spinti sul terreno scivoloso dei diversi perché di un’attività così «inutile», come l’aveva definita Lionel Terray nel suo imperdibile I conquistatori dell’inutile.
2
Chi avrebbe pubblicato il comitato editoriale dopo Joe Simpson? Quale altro autore poteva dare subito l’impressione che la collana avrebbe allargato il suo sguardo? Leslie Stephen, il docente a Cambridge che era in aperto contrasto con le visioni estetizzanti del Romanticismo vittoriano, e che nel suo libro The Playground of Europe aveva dato una svolta sportiva alle scalate sulle Alpi? O Albert Frederick Mummery, morto sul Nanga Parbat nel 1895, e considerato il primo alpinista “senza guida”? O Edward Whymper, il conquistatore del Cervino? O ancora Ugo de Amicis? O Emilio Comici? O Riccardo Cassin? O Anderl Heckmair, primo a passare illeso lungo la parete nord dell’Eiger e premiato dal baffetto in una Berlino plaudente? O l’orientalista Fosco Maraini? O ancora Kurt Diemberger? O ancora lo scalatore di Erto Mauro Corona che avrebbe esordito di lì a poco con un suo libro di racconti un po’ favoleggianti e naïf?
Il comitato editoriale decise per Gabriele Boccalatte. Il secondo titolo della collana sarebbe stato dunque Piccole e grandi ore alpine. Si trattava della raccolta dei diari dello scalatore torinese scomparso a trentun anni sotto una scarica di sassi durante una scalata sul Gruppo del Monte Bianco. Diari scritti non per essere pubblicati (come sono quasi sempre i diari), eppure enormemente coinvolgenti, attraverso quella prima persona così spontaneamente data, alla quale subito ci si affezionava. Era uno dei testi che amavo di più: portava a immedesimarsi nello spirito che aveva animato il suo autore durante le ore vissute in montagna.
Boccalatte era morto lasciando la moglie incinta e con un bambino piccolo. E lasciando anche quella serie di preziosi scritti. Gli scritti di Boccalatte erano stati ripresi dalla moglie e compagna di cordata Ninì Pietrasanta, che già poco dopo la tragedia, vincendo lo strazio, aveva trovato la forza di rileggere e selezionare tutte le pagine con i ricordi e le avventure vissute insieme, e di affidarle alla stampa.
Ninì, figlia dell’alta borghesia milanese, e Gabriele, avviato alla carriera concertistica come pianista, avevano formato una delle cordate più agguerrite tra quelle in circolazione negli anni Trenta. Passavano da una vita di agi in città, alle condizioni più disagevoli protratte per mesi in alta quota. Nelle immagini seppiate inserite nel libro dei “Licheni”, Ninì e Gabriele sembrano i perfetti rappresentanti di una borghesia che vedeva nelle scalate una forma di educazione al rigore, un’educazione alla sobrietà, dunque all’eleganza. Come Gervasutti e gli altri della banda, Ninì e Gabriele erano abituati a passare le notti appesi in parete, con i piedi penzolanti nel vuoto, magari tremando sotto un temporale, in attesa di ripartire il giorno dopo lungo la parete. E pur di non rinunciare a una “prima” – come era chiamata allora la salita di una parete vergine – erano disposti a rischiare fino in fondo la vita. Puntavano soprattutto a lanciarsi dove nessuno era ancora stato, a salire nel sole inanellando tiri e tiri di corda negli ambienti più severi delle altezze. Vivevano nella smania del nuovo, dell’esotico, dell’inesplorato. Vivevano lunghe estati tra le Alpi Occidentali e le Dolomiti. E le letture dei diari di Boccalatte portavano dritti in quel cuore nutrito di sogni, in un mondo a due dimensioni: le scalate e l’amore.
Boccalatte era piccolo di statura, ma ben proporzionato, arrampicava in modo elegante, cioè tenendo il corpo sempre ben distanziato dalla roccia e compiendo movimenti fluidi. E il suo terreno preferito era, appunto, la roccia, soprattutto il granito, il protogino del Bianco, sul quale con Ninì aveva compiuto alcune delle imprese più notevoli dell’epoca. Ninì aveva un viso sorridente, dolce, rotondo, gli occhi ardenti di vita. Le molte fotografie che ci ha lasciato – insieme ad alcuni filmati, perché Ninì si dilettava oltre che di fotografia anche di cinema – ce la restituiscono sovente accanto al marito, con le spalle premute dagli spallacci dello zaino, i pantaloni alla zuava che le si allargano sotto il ginocchio. Sulla testa, una riga netta separa i capelli, che sono raccolti in uno chignon dietro la nuca. E il sorriso, il sorriso perenne, con la testa lievemente piegata in avanti in un gesto di leggera pudicizia.
Ma quello che Gabriele e Ninì vivevano era soprattutto un “alpinismo senza automobile”, con un proprio e specifico approccio alla montagna, come racconta lo scrittore alpinista Massimo Mila (prefatore del libro di Boccalatte). L’utilizzo dell’automobile, diffusosi massicciamente con il boom economico dalla fine degli anni Cinquanta, avrebbe cambiato i ritmi delle scalate, le convenzioni, l’avvicinamento a rocce e ghiacciai; e avrebbe rappresentato la conquista del tempo libero e la montagna anche fuori stagione. Potendo sfruttare i fine settimana già dalla primavera grazie alle prime uscite con gli sci e le pelli di foca, gli alpinisti dagli anni Sessanta arrivavano già ben allenati all’appuntamento estivo con le montagne. L’acclimatamento, l’“oliatura delle ginocchia” avvenivano gradualmente. La domenica in quota e il lunedì di nuovo al lavoro: questo permetteva l’“alpinismo con l’automobile”. Ma negli anni di Boccalatte e Ninì tutto ciò non poteva avvenire. Era l’alpinismo “senza automobile”, appiedato, al quale ci si doveva consegnare senza riserve. Certo, erano raggiungibili le palestre di roccia a un paio d’ore di bicicletta da Torino, come la Rocca Sbarua, i Denti di Cumiana, le pietre intorno ai laghi di Avigliana. Ma per il “grosso” non rimaneva che attendere.
Poi, ogni anno, ai primi di giugno, arrivava il momento atteso. Si salutava la città partendo in treno con un grosso zaino sulle spalle, sapendo che si sarebbe tornati solo a fine stagione, dopo ottanta, cento giorni di vita nomade. Alla vista del paesino sotto la montagna, dopo ore di viaggio inseguendo coincidenze fra treni e corriere, terminava finalmente l’attesa durata mesi, e i sogni erano liberi di avverarsi nel lido appena raggiunto.
Per mantenersi, molti dovevano contare sul rotolo di soldi più o meno consistente preparato prima di partire: certo, bisognava farli durare, e si era spesso costretti a una vita di risparmio. Si faceva base in una pensione a conduzione famigliare – la solita da anni e la stessa frequentata da altri alpinisti – e si chiedeva un angolino dove sistemare il bagaglio eccedente da lasciare quando, di lì a pochi giorni, ci si sarebbe trasferiti col bel tempo nei rifugi in quota.
A quel punto i preliminari erano terminati. Ma ancora non era giunto il momento di lasciare il mondo abitato. Prima di affrontare l’alta quota era necessario un periodo di adattamento progressivo. Era necessario cioè “comprare l’aria” – così si diceva –, salire a rate, progressivamente, graduando i dislivelli. Solo alla fine di questo periodo di adattamento alla montagna si poteva iniziare la cosiddetta “campagna estiva”.
A quel punto, era un continuo errare da rifugio a rifugio, da cima a cima, da un gruppo montuoso a un altro, sempre a piedi, coprendo chilometri di sentieri, morene, ghiacciai, e poi chissà. Presto il fisico si sarebbe adattato alla nuova vita. Dopo un paio di settimane il volto già appariva cambiato, smagrito, cotto dal sole; la schiena, l’addome, i muscoli delle gambe si erano temprati nelle fatiche ripetute; le dita e gli avambracci avevano ritrovato la capacità di stringere la roccia e il manico della piccozza. Era una felicità silenziosa. Poi, quando la bassa pressione diventava persistente, stanchi e bagnati si tornava sotto la pioggia alla pensione. Qualche giorno di riposo fino al ritorno del sole. Una visita alla Casa delle guide per informare e chiedere aggiornamenti sulle condizioni della montagna. E si ripartiva con la nuova scorta di viveri, i vestiti freschi di bucato, vagando ancora come nomadi delle alte quote per fare di nuovo base temporanea nei diversi rifugi.
Al tempo di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta, i rifugi e i bivacchi incustoditi – simili a stive di navi con le pareti di legno incise dal coltello dagli avventori – costituivano isole certe nei grandi spazi vuoti tra i ghiacciai. Erano luoghi sicuri (rifugi, appunto, come erano allora, e non alberghi d’alta quota con cucina prelibata come sono oggi), dove trovare riparo e un pasto frugale, e dove trascorrere una notte e magari un giorno o due in attesa del sole dopo una perturbazione passeggera. Ed essendo dei crocevia obbligati per chi frequentava l’alta quota, i rifugi diventavano anche luoghi di incontro tra gli alpinisti. C’era il gestore, che governava l’ambiente con piglio deciso e che era un prezioso informatore su chi in quel momento si trovasse in parete, su chi fosse passato nei giorni precedenti e dove fosse diretto. Ma soprattutto in quelle casette sperdute c’era qualcosa di fondamentale: il libro del rifugio, il documento sovrano, il registro delle autodichiarazioni che diceva di passaggi, imprese, vie nuove, piccole o grandi esplorazioni compiute nelle vicinanze.
Oggi quasi tutti quei libri ingialliti dal tempo sono conservati sotto strati di polvere al Museo della montagna di Torino, e durante alcune ricerche per la rivista ho avuto occasione di vivere un’avventura riflessa – e indolore – leggendoli alla stregua di diari delle montagne, standomene lì, nella penombra, e sotto il cono di luce di una apposita lampada nel piccolo ufficio messomi a disposizione dagli inservienti del museo. Rimasti per anni dentro le più sperdute capanne in quota, quei vecchi libri mi riportavano la lenta scansione cronologica delle cose. C’erano i libri della capanna Gamba, per esempio, del rifugio Borrelli, del Torino, del Quintino Sella. Trovavo annotate le mete raggiunte, le mete esteriori e quelle interiori. Di fianco alle date si svelavano nomi e note con speranze, timori, rinunce, tragedie, azioni di soccorso, brevi considerazioni. Molti di quei nomi ritornavano da un libro a un altro, da un rifugio a un altro, sparivano per qualche periodo. Poi, gli stessi nomi, erano di nuovo lì, in compagnia di altri convenuti. E mi davano la prova che in quegli anni, gli anni dell’“alpinismo senza automobile”, tutti si conoscessero e insieme formassero una grande rete nella quale ognuno aveva il proprio ruolo. Mi divertivo a seguire gli spostamenti di qualcuno fino a incrociare i passi di qualcun altro. E procedendo lungo le tracce di quest’ultimo arrivavo ad altri ancora. Il rifugio era un’isola per Gervasutti, Boccalatte, Ninì Pietrasanta, un luogo dove si incrociavano i destini. Ogni arrivo al rifugio si caricava di soprese: chi ci sarebbe stato oltre quella porta?
3
Finita l’avventura sulla parete nord delle Grandes Jorasses, Giusto Gervasutti racconta nel libro Scalate nelle Alpi che con il suo compagno di cordata Renato Chabod si reca al rifugio Torino. E ...