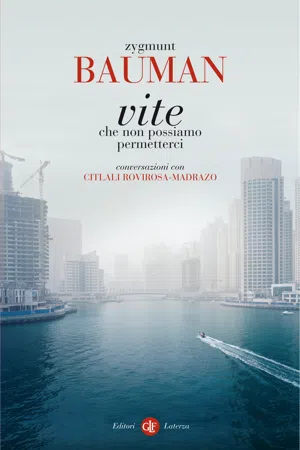Conversazione III
Quella cosa chiamata «Stato»: ripensando democrazia, sovranità e diritti umani
Citlali Rovirosa-Madrazo Negli ultimi decenni la «rottura epistemologica» con la modernità e la diffusione del cosiddetto pensiero post-moderno e post-strutturalista hanno prodotto idee ricche di stimoli e suggestioni. Pochi sono sfuggiti al loro fascino, e io stessa sono stata vittima dell’incantesimo. È stato forse per questo che nel 1995 mi sono spinta a scrivere che lo Stato-nazione (o meglio lo Stato tout court) e altre istituzioni peculiari alle nostre civiltà non erano altro che costrutti etnocentrici, o meglio illusioni patriarcali dell’Occidente (un’idea che non ho ritrattato...)1. Perdutamente innamorati del post-modernismo, ci siamo tutti ribellati ai nostri «progenitori» europei e mediterranei (dalla tradizione giudaico-cristiana ai greci, a Marx e oltre; dalla modernità alla post-modernità e ritorno) e abbiamo tutti bevuto nel Graal (gradevole o piuttosto indigesto?). Che cosa ci salverà da quello che spesso ci appare come un «crollo» che ha travolto «più o meno tutto»? Quali sono le prospettive dell’utopia, e quali sono le sue sensazioni al riguardo, rispetto ad allora (ricorda quando scrisse che «il socialismo piombò sull’Europa del XIX secolo come utopia»)?2 In altre parole, «dove andiamo da qui?» (e mi scusi se le do questo fardello...)
Zygmunt Bauman Il momento del «grande crollo» di «più o meno tutto», probabile destinazione ultima di una tendenza che domina nella nostra attuale forma di vita, non è «qui», almeno non ancora. Ma fino a poco tempo fa sembrava che fosse arrivato o che fosse imminente...
La possibilità di un’isola di Michel Houellebecq3 si conclude con queste frasi di Daniel25, ultimo (per sua scelta) di una lunga serie di cloni del Daniel originario (nelle intenzioni infinita):
Mi restavano forse sessant’anni da vivere; più di ventimila giornate che sarebbero state identiche. Avrei evitato il pensiero, come avrei evitato la sofferenza. Gli scogli della vita erano molto dietro di me; ero entrato adesso in uno spazio tranquillo da cui mi avrebbe allontanato solo il processo letale.
Facevo lunghi bagni, per ore e ore, sotto il sole come sotto la luce delle stelle, e non provavo null’altro che una leggera sensazione oscura e nutritiva [...].
Ero, non ero più. La vita era reale (pp. 397-398).
Nel mezzo di queste meditazioni Daniel25 conclude: «La felicità non era un orizzonte possibile. Il mondo aveva tradito» (p. 397). Nella storia narrata da Houellebecq, questa era la fine. Ma come era iniziata?
L’inizio risaliva a venticinque cloni prima, ai tempi tumultuosi e inebrianti della «trasgressione epistemologica» che lei ha ricordato, che aveva preceduto la «Prima Diminuzione» e la «Seconda Diminuzione» della popolazione umana sul pianeta (la crisi del credito o il disastro ambientale?): due catastrofi che avevano trasformato i resti della specie umana in bande disperse di cannibali, mentre la memoria del passato dell’uomo era rimasta affidata al possesso, alla tutela e alla cura di «neoumani» che si autoclonavano all’infinito, «dotat[i] di un sistema di riproduzione affidabile e di una rete di comunicazioni autonoma» e «riunit[i] in enclavi protette da un sistema di sicurezza infallibile», con l’intenzione (secondo quanto immaginato a posteriori da Daniel25) di «mantene[re] al riparo dalla distruzione e dal saccheggio l’integralità delle conoscenze umane» (pp. 367-368). A quel tempo Daniel1 (l’ultimo Daniel della serie partorito da una madre) aveva annotato nel suo diario: «Adesso non sento più odio in me, più nulla cui aggrapparmi, più alcun punto di riferimento [...] Non c’è più alcun mondo reale, non c’è più mondo sociale, mondo umano. Sono uscito dal tempo, non ho più passato né futuro, non ho più tristezza, progetti, nostalgia, abbandono o speranza» (p. 350).
Come Daniel25 si rese conto venticinque cloni dopo (in netto contrasto con la sua ipotesi iniziale sulle motivazioni originarie di tutta la vicenda), Daniel1 era stato «particolarmente eloquente» sulla nostalgia per il desiderio. Era stata soprattutto questa nostalgia – possiamo supporre – a indurre Daniel1 a cogliere l’opportunità di un Nuovo Inizio definitivo, ossia di una serie infinita di resurrezioni/reincarnazioni/rinascite sotto forma di repliche mediante clonazione dei precedenti io. Non sorprende che il capostipite dei Daniel clonati (l’ultimo cioè nato da una madre) fosse stato allettato dall’offerta, poiché, come aveva annotato egli stesso, nella «vita reale» (leggi: nella vita che conosceva, l’unica che poteva conoscere prima che la clonazione all’infinito diventasse una prospettiva realistica) le possibilità di «nuovi inizi» diminuiscono bruscamente molto prima di quanto si vorrebbe: «La vita inizia a cinquant’anni, è vero; a parte che finisce a quaranta»... (p. 23).
Il primo Daniel era stato il compendio del successo, in base a qualsiasi standard di felicità: un beniamino dei salotti, pieno di denaro e costantemente sotto i riflettori, cui le grazie femminili si offrivano in quantità molto superiore alla sua capacità di consumo. In tutto quel bendiddio l’unica grave spina nel fianco era l’ossessione che prima o poi dovesse finire. Fino ai quaranta, o giù di lì, si poteva anche sdrammatizzare o ignorare lo spettro della fine. Ma la felicità andava liberata dal pensiero della fine, così come non ci si può lasciar rovinare l’euforia della sbornia dall’idea che ad essa seguiranno i postumi. Ai tempi di Daniel1 – cioè nel tempo reale in cui viviamo lei ed io – la ricerca della felicità si basava su un’ipotesi di autoripetizione all’infinito: almeno da questo punto di vista, la nostra idea di «vivere per essere felici, sempre più felici» è forse l’archetipo del progetto di clonazione, il più recente surrogato high-tech dell’immortalità.
Ma la prospettiva dell’inevitabile fine si insinua furtiva dentro di te senza che te ne accorga, e una volta arrivato ai quaranta o ai cinquanta prende dimora in quel luogo che chiami «presente», trovandoti di solito impreparato e confuso. In fin dei conti, nulla o quasi della tua vita di successo ti ha insegnato e preparato ad accettare la presenza invadente e ineluttabile della fine. Improvvisamente quella che sei stato addestrato e che sei giunto a considerare «vita», quel flusso rigoglioso di piaceri, si assottiglia e si prosciuga sempre più. Daniel allora ricorda e comprende l’inquietante messaggio di Schopenhauer: «Nessuno può vedere sopra di sé». Per sua fortuna Isabelle, l’oggetto sfuggente del suo desiderio, era ancora nei paraggi (poco prima di scomparire per sempre dalla sua vita) e «in quel momento, evidentemente, [...] poteva vedere sopra di me» (p. 73).
Che cosa vedeva Isabelle? Gli spiegò che «quando s’invecchia, si ha bisogno di pensare a cose rassicuranti e dolci. Di immaginare che qualcosa di bello ci aspetta in cielo» (pp. 70-71). E poi aggiunse: «ci si allena un po’ a morire. Quando non si è né troppo stupidi né troppo ricchi». Se tu fossi troppo ricco (o troppo stupido, anche se in tal caso, data la definizione di stupidità, non te ne renderesti conto) ti sarebbe terribilmente difficile immaginare (se mai cercassi di farlo) che i piaceri «seriali» finiscano. In questo caso si fa prima a vedere che a immaginare. La fine deve guardarti fisso negli occhi perché tu capisca quanto essa sia inconcepibile (e soprattutto insopportabile).
Ci vollero venticinque rinascite perché Daniel notasse, a proposito dei «neoumani»: «Le gioie dell’essere umano ci restano insondabili; i suoi dolori, viceversa, non possono distruggerci; le nostre notti non vibrano più di terrore né di estasi. Però viviamo, attraversiamo la vita, senza gioia e senza mistero» (p. 11).
Fu questa scoperta, possiamo supporre, a indurre Daniel25 a revocare la decisione di Daniel1 scegliendo ciò da cui quest’ultimo aveva scelto di fuggire: abbandonando cioè (o meglio rifiutando) il carattere eterno/infinito della sua esistenza assicurato dalla clonazione, e liberandosi del futuro (ossia delle sue future rinascite). «Come tutti i neoumani, ero inaccessibile alla noia. [...] Ero [...] assai lontano dalla gioia e anche dalla vera pace; il solo fatto di esistere è già una sciagura. Abbandonando spontaneamente il ciclo delle rinascite e delle morti, mi dirigevo verso un nulla semplice, una pura assenza di contenuto» (p. 395). Fu lo stesso Daniel25 a pronunciare quella sentenza (poiché non c’era nessuno attorno a lui che potesse farlo al suo posto, né lì e in quel momento, né in futuro): 20.000 giorni da trascorrere in purgatorio prima di raggiungere il paradiso della non-esistenza – una visione che cercò di descrivere prendendo in prestito parole di Samuel Beckett:
non ci sono che io, con le mie chimere, stasera, qui sulla terra, e una voce che non fa rumore, perché non va verso nessuno [...] Vedo quello che succede qui, dove non c’è nessuno, dove non succede niente [...] So bene che non c’è nessuno qui, né io né nessuno, ma non sono cose da dire, allora non dico niente. Altrove non dico di no, altrove, [ma] può avere un altrove questo qui infinito?4
In effetti l’infinito – in quanto ha assorbito tutto ciò che può divorare, mentre nulla del passato, del presente e del futuro è al sicuro dalla sua voracità onnivora – equivale all’impossibilità di un «altrove». E ciò che i neoumani erano tragicamente riusciti a dimenticare era che senza un qualche «altrove», situato al di là di un certo numero di «dietro l’angolo» e «al mattino seguente», non c’è e non ci può essere umanità, o almeno quel genere di umanità noto a tutti, anche agli inventori di distopie.
In un significativo articolo sulla sopravvivenza dell’utopia5 Miguel Abensour cita la tesi, avanzata nel 1886 da William Morris, secondo cui «gli uomini lottano e perdono la loro battaglia; ciò per cui avevano combattuto si realizza comunque, malgrado la loro sconfitta, ma poi si rivela altro da ciò che essi credevano, e allora altri uomini devono continuare a lottare per ciò che i primi chiamavano con un altro nome»6. Morris si riferiva a tutti gli uomini, agli «uomini come tali», presumendo che gli uomini, tutti gli uomini, lottino per «qualcosa che non è», e che questo sia anzi proprio il segno caratteristico dell’«uomo». Egli sosteneva che per gli uomini (o le donne, aggiungeremmo noi) questa lotta fosse una necessità, facesse parte della loro natura (come ha scritto Ernst Bloch, il «Non» – o Nicht – è «mancanza di qualcosa e allo stesso modo fuga da questa mancanza; così è impulso verso quel che gli manca»7). Se ci troviamo d’accordo con Morris, possiamo considerare le utopie come espressioni elaborate e sistematizzate di questo aspetto cruciale della natura umana. Utopie erano dunque molti dei tentativi di descrivere in modo dettagliato ed esauriente la «cosa» per la quale si sarebbe combattuta la nuova battaglia.
Notiamo subito, però, che tutte le utopie formulate dai predecessori e contemporanei di Morris (lui compreso) circa un secolo prima che la mente visionaria di Houellebecq potesse concepire i Daniel «seriali», per quanto diverse tra loro da tutti i punti di vista, avevano in comune il fatto di prefigurare un mondo in cui non fossero più all’ordine del giorno battaglie per «cose che non sono»: quelle battaglie non sarebbero più state necessarie né auspicate, perché in quel mondo ogni strada era ormai stata battuta, e tentarne altre non poteva che allontanare dalla perfezione raggiunta. Perciò, se concordiamo con Morris, la «cosa principale» che non c’era, e per cui lottava chi considerava naturale lottare per qualcosa che non c’era e di cui si sentiva l’assenza (quale che fosse il nome provvisorio e sostanzialmente controverso di quel qualcosa), era paradossalmente la fine delle ostilità, la fine della necessità, dell’impulso o del desiderio (e della stessa desiderabilità) della lotta. E la cosa principale che puntualmente «accadeva» all’indomani dell’ennesima battaglia persa (che non faceva altro che andare «diversamente da come si voleva» e costringeva altri a scendere di nuovo in campo per la stessa cosa chiamata in un altro modo) era di non dover più continuare a combattere: come l’armistizio che segue i combattimenti e di solito si rivela molto inferiore alla gioia che si pensava e sperava fosse la pace per cui si era combattuto. Lo sforzo compulsivo e irrefrenabile dei progettisti e cacciatori di utopie era alimentato e sostenuto dall’immane desiderio di tregua. Si accorreva sul campo di battaglia per inseguire il sogno di deporre le armi per sempre.
Un altro elemento caratteristico delle utopie, ai tempi di William Morris, e nel successivo secolo o giù di lì, era il loro radicalismo. Azioni, iniziative, mezzi e misure si possono definire «radicali» quando si spingono fino alle radici di un problema, di una sfida, di un compito. Si noti però che la parola latina radix, da cui derivano i significati metaforici del termine «radicale», non si riferisce solo alle radici, ma anche alle fondamenta e alle origini. E questi tre concetti – radici, fondamento e origine – hanno in comune qualcosa: per l’esattezza, due attributi.
Primo attributo. In circostanze normali, i referenti materiali di tutti e tre i concetti si possono soltanto presumere, indovinare, immaginare: sono in ultima analisi invisibili, non li si può analizzare né farne esperienza diretta, sensoriale. Tutto ciò che germina e cresce a partire da essi – tronchi o steli dalle radici, edifici dalle fondamenta o conseguenze dalle origini – li avvolge in un tessuto fitto, spesso e impenetrabile di «storia successiva» che nel momento in cui emerge li copre e li nasconde alla vista con la propria ombra: se si desidera giungere all’obiettivo di pensare o agire in modo «radicale», occorre prima lacerare, rimuovere o distruggere quell’involucro.
Secondo attributo. Nel corso del processo con cui ci si apre la strada verso quell’obiettivo, il risultato di quello sviluppo dev’essere concettualmente decostruito o materialmente «tolto di mezzo» e smantellato. È molto probabile che dall’opera di decostruzione e smantellamento l’obiettivo uscirà depotenziato e invalidato in termini pratici. Esso potrebbe non essere più in grado di germogliare, accogliere o innescare un’altra crescita, né tanto meno di replicare quella che è stata decomposta o soffocata. Assumere una posizione «radicale» segnala l’intenzione di distruggere, e comunque la disponibilità ad assumersi il rischio di una distruzione; quasi sempre una posizione radicale punta alla «distruzione creatrice», «rimuovendo le macerie» o sommovendo e arando il terreno per una nuova semina o impianto e preparandolo ad accogliere un altro tipo di radici. Quando si accettano tutte quelle condizioni e ci si lascia guidare da tutte queste intenzioni e obiettivi, si assume una «posizione radicale».
Secondo Russell Jacoby, nel pens...