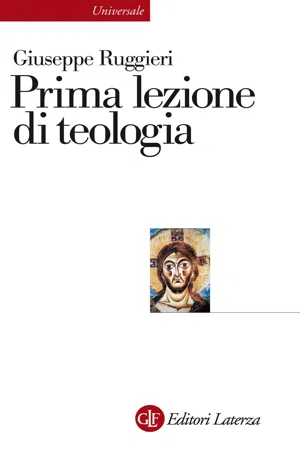
This is a test
- 170 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Prima lezione di teologia
Dettagli del libro
Anteprima del libro
Indice dei contenuti
Citazioni
Informazioni sul libro
La teologia applica la metodologia scientifica al discorso su Dio e vuole quindi accordare il pensiero di questo mondo con il messaggio cristiano. Ma il discorso su Dio nel cristianesimo del Nuovo Testamento non è in ultima analisi una negazione del sapere di questo mondo? E, allora, la teologia è compatibile con il cristianesimo? Ed è possibile una teologia che resti fedele al messaggio di Gesù di Nazaret?
Domande frequenti
È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui
Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì, puoi accedere a Prima lezione di teologia di Giuseppe Ruggieri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia del cristianesimo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Teologia e religioneCategoria
Storia del cristianesimoIII. Erramenti
1. Il linguaggio come pellegrinaggio
Il teologare è soggetto, come ogni discorso umano, alla legge del pellegrinaggio. Noi, parlando, ci mettiamo in cammino verso qualcosa. Quando parliamo, infatti, non diciamo solo qualcosa, ma al tempo stesso accendiamo il motore della nostra mente che quindi si muove verso una meta. Questa meta per il teologo è Dio. E allora il suo pellegrinare acquista una densità particolare. Raggiungere la meta, anche solo con il pensiero, in questo caso significa raggiungere tutto, l’origine di noi stessi. Ma questo presuppone che Dio sia appunto conoscibile, che di lui noi possiamo formulare pensieri «veri», che noi possiamo dire la verità su Dio.
Cosa intendiamo con la parola «verità»? Il pensiero occidentale mediante la categoria della verità ha sostanzialmente espresso, sia pure attraverso innumerevoli varianti, il rapporto di omogeneità tra la realtà esterna e l’intelligenza: ciò che esiste è conforme e quindi accessibile all’intelletto. Giacché ciò che esiste è conforme all’intelletto, questo è in grado di «riprodurre» la realtà e di emettere affermazioni «vere». Oppure, nella tendenza «idealista», la realtà è accessibile perché lo spirito umano «impone» ad essa la propria struttura e «organizza» la realtà in maniera conforme a se stesso. Alla base delle varie concezioni della verità esiste cioè, come nocciolo duro, l’idea della corrispondenza: la verità è data dalla corrispondenza di ciò che viene detto con ciò su cui qualcosa viene detto. Questa concezione fondamentale della verità è presupposta non solo dal senso comune e dal linguaggio della vita quotidiana, ma anche dalle varie forme di negazione scettica della verità, come impossibilità da parte dell’uomo di accedere ad essa, e da quelle forme di concezione della verità come mistero ultimamente inaccessibile, che potremmo chiamare «mistiche». La teoria della corrispondenza è presupposta ad esempio nell’asserzione del Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein, secondo cui «su ciò di cui non si può parlare si deve tacere». E, accanto a questa asserzione che è quella conclusiva del Tractatus, si può vedere anche l’analoga asserzione 5.61, il cui contesto permette di coglierne meglio il significato: «La logica riempie il mondo; i limiti del mondo sono anche i suoi limiti. Non possiamo dunque dire nella logica: Questo e quest’altro v’è nel mondo, quello no. Ciò parrebbe infatti presupporre che noi escludiamo certe possibilità, e questo non può essere, poiché altrimenti la logica dovrebbe trascendere i limiti del mondo; solo così potrebbe considerare questi limiti anche dall’altro lato. Ciò, che non possiamo pensare, non possiamo pensare; né dunque possiamo dire ciò che non possiamo pensare». E lo stesso presupposto della corrispondenza è presente nella concezione heideggeriana della verità in quanto tratto fondamentale dell’essere per cui questo, nel momento stesso in cui si svela, si nasconde tuttavia nell’ente, con una sottolineatura quindi del momento del nascondimento e dell’oblio rispetto a quello dello svelamento: «Questo nascondimento della sua essenza e della sua origine essenziale è il tratto in cui l’essere inizialmente si illumina, in modo tale tuttavia che il pensiero propriamente non lo segua» [Sentieri interrotti, Firenze 1968, 310]. Si presuppone quindi che esista un nesso tra realtà e linguaggio, tra essere e spirito. Solo che nel «silenzio» di Wittgenstein ciò che permette la parola è la corrispondenza «definita» tra il mondo e il pensiero, mentre in Heidegger si sottolinea l’inadeguatezza della corrispondenza, che in lui è concepita piuttosto come un «errare» (Beirrung) attorno all’essere. Dove è da notare che questa inadeguatezza della corrispondenza è originata dall’essere stesso, che salvaguarda se stesso dalla piena oggettivazione. Per cui l’epocheˉ (che in greco vuol dire «sospensione») non è, come in Husserl, una sospensione del giudizio operata dall’uomo, ma appartiene all’essere stesso, che quindi dà origine alle varie «epoche», alla storia dell’uomo (occidentale) come «erramento».
Il teologare fa forse eccezione a questa legge dell’erramento? Sembrerebbe di sì. Infatti la fede nel Dio di Gesù Cristo non è certamente una prestazione autonoma dell’uomo ma, almeno secondo la convinzione di tutti i cristiani, cattolici, ortodossi e protestanti, essa è un dono di Dio accolto liberamente dall’uomo. Essa partecipa quindi della stessa luce di cui Dio è origine, e quindi la conoscenza di Dio che essa contiene, punto di partenza del teologare, non può che essere vera, proprio perché le è data da Dio stesso. A tal proposito gli antichi formulavano un principio, che purtroppo poi nella pratica viene dimenticato più o meno consapevolmente: la fede non è il prodotto di un’argomentazione, ma sostiene l’argomentazione. Essi partivano da un detto di Gregorio Magno: «Una fede alla quale la ragione umana offra una prova (experimentum) è priva di meriti». Conseguentemente è la fede a fornire prove, ma essa non è il frutto di prove razionali. E così un autore come Alessandro di Hales, vissuto dal 1185 circa al 1245 e chiamato «dottore irrefragabile» – che per primo utilizzò le Sentenze di Pietro Lombardo come libro di testo nell’insegnamento della teologia –, chiosando il testo latino della lettera agli Ebrei, al cap. 11, 1, in cui è detto che la fede è argumentum non apparentium, prova delle cose che non si vedono, afferma nella sua Summa che allora essa è probans, non probatum, sta cioè all’origine dei vari argomenti umani e non è un prodotto o una conclusione di argomenti di altra natura, sia pure razionali. E come Alessandro parlavano gli altri autori medievali.
Quando in epoca moderna si cominciò a negare la plausibilità razionale della fede, molti teologi dimenticarono questa natura specifica delle convinzioni di fede e si gettarono nell’impresa disperata della prova della fede, anche se poi, con un’inevitabile incoerenza interna, cercavano di salvare il carattere gratuito della fede, giacché essa è puro dono che Dio dà a chi vuole, quando vuole, come vuole. Ma su questo tornerò in seguito. Qui invece mi preme ritornare sulla domanda che ho già formulato: il parlare cristiano su Dio ammette «erramenti», cioè quel continuo aggirarsi attorno alla verità a cui è sottomesso ogni linguaggio umano?
A questa domanda si può dare una risposta adeguata solo se si prende in considerazione l’altro aspetto della fede. Essa infatti secondo la tradizione cristiana è «certa», ma rimane «oscura». Già Paolo è un chiaro testimone di quest’ambiguità della conoscenza della fede. Egli con orgoglio ribadiva che la conoscenza di Gesù Cristo gli era stata comunicata direttamente da Dio, quando Dio, avendolo chiamato per pura grazia, si era compiaciuto di rivelare in lui il Figlio suo [Gal 1, 15-16]. Ma era lo stesso Paolo ad affermare che adesso noi «vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma dopo vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente» [1 Cor 13, 12]. E se Paolo non conosce il termine heideggeriano dell’erramento, non dice d’altra parte una cosa molto diversa quando sostiene, con un gioco di parole intraducibile in italiano (endemeoˉ-/ekdemeoˉ- = sono in patria/vado lontano dalla patria), che fin quando la nostra patria è il corpo, noi siamo esuli da Dio [2 Cor 5, 6]. La traduzione latina detta Volgata, il cui autore è san Girolamo, traduce con molta finezza: peregrinamur a Domino, siamo nella condizione dei pellegrini lontani dalla loro patria che è Dio.
A ciò si aggiunga l’ambiguità del linguaggio umano. Quando descrive, il linguaggio «afferra» un oggetto e pretende di possederlo. Non è un caso che il termine «concetto» e il verbo corrispondente «concepire», non solo nelle lingue occidentali che vengono dal latino ma anche nel tedesco, portino con sé l’immagine del prendere, dell’afferrare (cum-capere, be-greifen). E un teologo greco, noto con lo pseudonimo di Dionigi Areopagita e vissuto a cavallo tra V e VI secolo, per chiarire come i nostri concetti su Dio non riescano ad afferrarne la presenza, anzi siano esclusi dallo stato di unione con Dio, li qualifica come antileˉpseis-concezioni, anche qui con l’idea dell’afferrare, per cui un fine traduttore latino del Seicento, il gesuita Balthasar Cordier, li rendeva con apprehensiones, gesti con cui si afferra una cosa. Una pretesa, questa dell’afferrare, che raggiunge il suo punto estremo nella definizione filosofica.
Ma la realtà non è mai completamente afferrata nei concetti. Tutti sappiamo che ci sono aspetti dell’esperienza che restano fuori dalle nostre descrizioni. I poeti che non usano concetti, ma evocano e alludono, da questo punto di vista sono più rispettosi, meno presuntuosi, e permettono una percezione profonda delle cose. Percezione che arriva a una profondità ancora maggiore nel linguaggio musicale. Qui la profondità è tuttavia raggiunta a prezzo di un abbandono dell’istanza legittima che porta con sé il concetto. Questo, che nella sua ricerca di precisione si sottomette a una verifica comune, può essere smentito da un concetto ancora più preciso. Il linguaggio che evoca e allude, invece, sfugge al controllo intersoggettivo. E non è data all’uomo la possibilità di sfuggire a quest’ambiguità fondamentale del suo linguaggio: la precisione a scapito della profondità, la profondità a scapito della precisione.
Non soltanto quindi la conoscenza umana di Dio resta sempre limitata, ma anche le parole che impieghiamo lo sono. Questa constatazione tuttavia non coglie ancora la drammaticità dei discorsi umani su Dio, giacché è anche vero che le parole nella loro limitatezza condizionano e coinvolgono il pensiero e la conoscenza. E ciò ha dei riverberi fortissimi nel linguaggio intersoggettivo, dove la comunicazione dei nostri pensieri è legata al linguaggio e questo condiziona quindi la modalità dei nostri rapporti, compresi quelli della comunità che confessa la propria fede nel Dio di Gesù Cristo. Ma per i cristiani questo equivale a dire che l’immagine che si fanno di Dio è condizionata dai linguaggi che hanno corso all’interno della chiesa, nel bene e nel male, sia in ciò che questi rendono possibile, sia in ciò che velano e nascondono.
Di questo erano perfettamente coscienti i medievali con le loro riflessioni sugli «articoli di fede». Essi erano preoccupati di evitare un malinteso, che cioè il linguaggio normativo della fede fosse esaustivo. Gli articoli di fede sono le formulazioni che racchiudono l’oggetto della fede cristiana: Dio che ha creato tutto ciò che esiste; il Padre che invia il Figlio suo e lo Spirito; il Figlio che nasce da una donna, muore e risorge; lo Spirito che opera nella chiesa etc. In pratica si tratta delle varie enunciazioni contenute nel simbolo di fede che i cristiani recitano durante l’eucaristia. Enunciazioni che sono quindi obbliganti e servono da criterio per riconoscere la fede autentica, quella che viene chiamata fede ortodossa. Ma per impedire l’equivoco secondo cui la fede potesse essere racchiusa dentro un qualsiasi linguaggio, compreso quello degli articoli del simbolo di fede, i teologi medievali vi introducevano un dinamismo interno e costitutivo. Per un verso molti di essi collegavano l’articulus ad arctare: stringere, obbligare. Spiegavano quindi che gli articoli di fede ci obbligano a credere in Dio. Ma non si fermavano qui, giacché per altro verso precisavano che gli articoli contenevano una «percezione della verità di Dio che tende verso di lui» [L. Hödl, Articulus fidei, in J. Ratzinger - H. Fries, Einsicht und Glaube, Freiburg 1962, 358-376]. E cioè, anche il linguaggio normativo su Dio non esaurisce la conoscenza di Dio, ma pone la percezione che noi abbiamo di lui in movimento verso di lui. Ma questo è proprio l’erramento heideggeriano che quindi, storicamente, dà vita a varie epoche della verità. Prima tuttavia di accennare ad alcuni di questi erramenti, occorre ancora parlare del luogo originario della verità cristiana, della sua dimora. Dove sta la manifestazione adeguata di Dio, cioè la verità?
2. La dislocazione cristiana della verità
Ho già detto come il motore interno che ha dato inizio al dinamismo dottrinale dell’esperienza cristiana sia stato già in Gesù di Nazaret l’interpretazione del proprio ruolo e della propria persona, un’interpretazione che poi è stata sviluppata dalla primitiva comunità dei suoi discepoli. Tuttavia, per cogliere le vicissitudini di queste interpretazioni e quindi del teologare stesso, occorre aggiungere un’altra considerazione, che risulta fondamentale per comprendere il sistema dottrinale cristiano. E questa considerazione verte sull’evento genetico nel quale si costituisce il processo interpretativo che segna ogni prassi del teologare cristiano. Esso infatti opera una dislocazione della verità stessa, con un’operazione che, almeno con questa intensità, non si riscontra in nessun’altra esperienza religiosa.
Presupposto comune ad ogni sistema religioso è che esso sia vero, che esso contenga cioè riti, credenze, norme che rendono possibile la comunicazione con il mondo di Dio. Che di Dio si abbiano scritture e persone ispirate da lui stesso, che lo hanno manifestato agli uomini indicando la via per unirsi a lui, essergli fedeli, raggiungerlo etc., anche questo fa parte di molte esperienze religiose. Ma i primi discepoli di Gesù operarono una dislocazione unica della verità religiosa, identificandola con una precisa figura della storia, Gesù di Nazaret. Infatti Dio non lo ha visto nessuno, è stato Gesù che ne ha «fatto l’esegesi», lo ha «dispiegato» davanti agli occhi dei primi discepoli. E giacché lui e il Padre sono «una sola cosa», perché egli è il Figlio che fin dall’eternità vive rivolto al Padre, il cui essere è cioè un «essere-volto-a», allora lui è «la» verità e chi vede lui vede il Padre. In questa dislocazione della verità c’è una vera e propria rivoluzione della logica comune, giacché ormai non è un’idea per quanto alta e pura a rendere in maniera adeguata la natura di Dio, ma un uomo preciso, un’esistenza concreta e determinata. Ma cosa ha reso possibile questa dislocazione della verità? Si tratta infatti di sapere se questa operazione ermeneutica, forse la più originale di tutta la storia spirituale dell’umanità, possa essere collegata ad un evento determinato della storia umana.
Sulla base delle testimonianze del cristianesimo primitivo possiamo tranquillamente affermare che questo evento, costitutivo di ogni ermeneutica cristiana, sta nel passaggio dal Gesù storico al Cristo annunciato, cioè nel momento stesso in cui si costituì la fede dei primi discepoli. Questo momento costitutivo della fede cristiana è dato da quelle che vengono chiamate le «apparizioni» di Gesù risorto. I discepoli hanno creduto in Gesù, nelle parole che aveva detto durante gli anni in cui lo avevano praticato, nella sua predicazione del regno, per una ragione fondamentale: perché Gesù si è manifestato ad essi dopo la sua morte come «vivente», non come uno che apparteneva al regno dei morti [Lc 24, 5]. La fede nel Cristo risorto per se stessa imponeva infatti ai discepoli la missione, la coscienza di essere inviati ad annunciarlo come colui nel quale si erano realizzate le promesse dei profeti, e quindi richiedeva un’attività di comprensione di ciò che Gesù era veramente stato. Anzi, il fenomeno delle apparizioni imponeva di comprendere, ancora prima di ogni altra cosa, chi era colui che appariva. Per compiere questa operazione interpretativa i discepoli presero a prestito dal linguaggio apocalittico del tempo la metafora del risveglio dal sonno, o del mettere in piedi: Dio aveva svegliato dal sonno della morte e aveva messo in piedi Gesù che giaceva nel sepolcro. Erano infatti i gruppi apocalittici che sottolineavano come alla fine del mondo Dio avrebbe fatto risorgere, svegliare cioè dal sonno della morte, gli uomini.
La modalità di queste apparizioni è tuttavia difficile da determinare perché i racconti ben presto vennero arricchiti e ulteriormente interpretati in funzione apologetica. Nel Nuovo Testamento noi troviamo due generi radicalmente diversi di testimonianza sulle apparizioni. Alcune di queste testimonianze sono infatti molto ricche di particolari, parlano di un Gesù risuscitato dai morti che passeggia sulla riva del lago al primo mattino e prepara la brace per arrostire il pesce, che mangia a tavola con i discepoli, che fa vedere il suo costato aperto etc. Altre invece sono molto più sobrie e al tempo stesso molto più antiche, giacché risalgono ad appena pochi anni dopo la morte di Gesù. Gli esegeti giustamente sottolineano come siano queste a possedere un grado di storicità maggiore delle altre.
La più famosa di queste testimonianze è quella contenuta nella prima lettera ai Corinzi 15, 3-7, che a sua volta risale a una tradizione precedente e che in più è arricchita dal racconto di un testimone di prima mano, Paolo di Tarso, il quale fu beneficiario diretto dell’esperienza. Qui la cito traducendola nella maniera che ritengo la più fedele: «Io ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che fu fatto vedere a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito fu fatto vedere a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre fu fatto vedere a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli». E poi Paolo aggiunge ancora nel versetto 8: «In fine fu fatto vedere anche a me, come all’aborto» (corsivi miei).
Il brano è stato oggetto di innumerevoli studi che da soli riempiono svariati scaffali di una biblioteca. Esso contiene molti punti oscuri: in che misura Paolo ha messo mano al testo che gli è stato tramandato? Chi sono i «più di cinquecento fratelli»? L’apparizione a Pietro/Cefa corrisponde a una delle apparizioni raccontate nei vangeli? Perché si parla di Dodici e non di Undici, dato che Giuda non entra certamente nel conto? E chi sono gli «apostoli» distinti dai Dodici? Ma io qui voglio limitarmi soltanto al versetto 8, quello in cui Paolo parla di sé. E la prima cosa da notare è il fatto che Paolo parli dell’apparizione ricevuta usando lo stesso termine impiegato per le altre apparizioni: «fu visto», aoristo passivo del verbo horaoˉ-vedo: oˉphtheˉ-fu visto. Da altri brani del Nuovo Testamento sappiamo infatti che questo termine veniva comunemente impiegato proprio per parlare delle apparizioni di Gesù dopo la sua morte. Si tratta quindi di un evento giudicato da Paolo della stessa natura degli altri. Io l’ho tradotto con un «fu fatto vedere», a motivo di una particolarità specifica del greco biblico. Infatti la traduzione letterale dovrebbe essere «fu visto a Cefa, ai Dodici etc.», giacché i vari destinatari delle apparizioni sono resi con il dativo, complemento di termine. Ma «fu visto a» è un chiaro errore, a meno che non ci venga in aiuto un uso tipico della traduzione greca dell’Antico Testamento, i cosiddetti Settanta, che ricorrono a questo anacoluto quando il vero soggetto è Dio, che tuttavia non può essere nominato. Da qui la traduzione da me scelta: «Fu fatto vedere (da Dio) a Pietro», così come a tutti gli altri. La visione che quindi Paolo ha sperimentato è un’azione attribuita a Dio.
Il testo di Paolo ha un valore unico, perché laddove Paolo non si sente legato al linguaggio tradizionale, ma parla in proprio dell’esperienza vissuta, la descrive con i termini che i veggenti apocalittici usavano per le loro visioni: «Colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare in me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani» [Gal 1, 15-16]. Stando quindi alla testimonianza di Paolo, il solo testimone diretto che ce ne parla, l’evento costitutivo della fede dei primi discepoli fu un’esperienza che essi attribuiscono a Dio, esperienza collocata dopo la morte di Gesù, e nella quale Gesù venne fatto conoscere per quello che è: il Cristo, il Figlio di Dio, nel quale si realizzano tutte le promesse di salvezza contenute nelle Scritture dell’Antico Testamento. È quindi Gesù Cristo la perfetta manifestazione di Dio, la sua verità, che adesso i cristiani confessano nella fede che hanno ricevuto da Dio stesso. Fu questa la dislocazione originaria della verità operata dai primi discepoli e che quindi resta costitutiva per tutti coloro che si rapportano alla loro testimonianza, alla «fede apostolica». Il comune sentire cristiano ha reso al meglio questa dislocazione quando, nel linguaggio tradizionale, la Verità è diventato sinonimo di Cristo.
L’identificazione tra Cristo e la verità può quindi essere afferrata nella sua valenza propria solo a partire dal significato fondamentale della vicenda stessa di Cristo quale emerge dalla testimonianza neotestamentaria, anche se questo non esclude affatto che altri tratti di que...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- I. Teologia e cristianesimo
- II. La dimensione dottrinale dell’esperienza cristiana
- III. Erramenti
- IV. Trascendenza e forma
- V. Il nano sotto la scacchiera
- VI. La fine di questo mondo. Ovvero: Gesù di Nazaret e la teologia cristiana