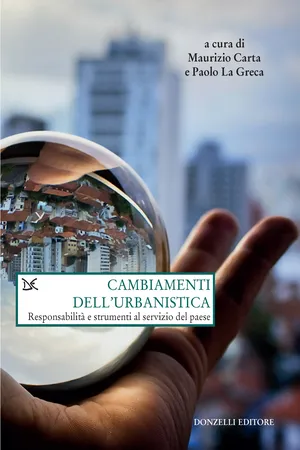![]()
Parte terza
Azioni e semi per il cambiamento
Tra parentesi si citano gli autori dei paper discussi alla XIX Conferenza nazionale della Società italiana degli urbanisti (Catania, 16-18 giugno 2016), consultabili in Aa.Vv. 2017.
![]()
I. Il nuovo patto città-campagna: ambiente, agricoltura, paesaggio (economie, turismo, produzione)
di Antonio Leone e Mariavaleria Mininni*
1. L’Atelier 1. «Ambiente, agricoltura, paesaggio».
Questo atelier ha proposto una riflessione su pianificazione territoriale e caratteri identitari del paesaggio, difesa dell’ambiente e agricoltura. Per questi temi è fondamentale la chiave di lettura in termini dinamici, perché occorre superare la concezione rigidamente conservazionista. Bisogna quindi individuare e modulare le necessità di conservazione (che sono soprattutto della natura) da quelle ascrivibili alla sfera antropica e culturale del paesaggio, caratterizzate da maggiore dinamicità. In altri termini, esclusa ovviamente qualsiasi logica di valorizzazione non sostenibile del paesaggio, occorre superare l’equivoco della pura conservazione. Esso nasce dalla mancata considerazione della diversissima scala temporale di ambiente e paesaggio. Premesso che nell’universo nulla è fermo e tutto è incessante movimento e interazione, Darwin insegna che anche l’ambiente ha una sua dinamicità, ma essa è talmente lenta rispetto ai tempi della civiltà umana (la scala temporale è quella della Geologia) da giustificare l’assoluta conservazione degli ecosistemi naturali. Lasciare un ambiente intatto alle generazioni future è quindi assolutamente doveroso e indiscutibile.
La scala temporale del paesaggio è ben diversa: questo è prodotto dalla sintesi fra natura e cultura, appartiene quindi alla sfera della civiltà dell’uomo, che è in grado di apprezzarne e influenzarne le dinamiche. Di conseguenza, in tema di paesaggio, il testimone fra generazioni non consiste nel lasciare qualcosa di immutato e immutabile, ma l’eredità giusta è il progresso, ovvero quel mix virtuoso fra sviluppo e tutela che genera complessità e resilienza del socio-ecosistema.
La fisica moderna e la teoria dei giochi dimostrano che il caos è fattore ineluttabile di evoluzione, è il prezzo entropico da pagare al progresso. L’alternativa è il cristallo amorfo.
Obbligo morale di ogni generazione, quindi, è quello di lasciare alla successiva ecosistemi intatti e paesaggi migliori, alias più complessi. Il problema è la semplificazione-cristallizzazione.
In questo quadro l’agricoltura ha un ruolo fondamentale, come specifico sistema paesaggistico, ma ancora più come componente del tutto, in continua interazione, sia con il territorio che con la città. Per altro, anche l’agricoltura è prodotto della sintesi fra natura e cultura, per cui la crisi del paesaggio è soprattutto lì: cesura fra le risorse locali e il servizio diretto alla città, databile con la cosiddetta «rivoluzione verde» della seconda metà del Novecento. Se è vero che all’epoca in cui questo slogan è stato coniato il concetto di verde era ben diverso dall’attuale, è anche vero che esso è stato fortemente mistificatorio, smascherato già nel 1962 dalla «primavera silenziosa» di Rachel Carson. Nei fatti, più che «verde», è stata una «rivoluzione chimica e meccanica», il cui successo in termini di sicurezza alimentare ha avuto un salato costo termodinamico (incremento del disordine: inquinamento, dissesti ecc.) in termini di banalizzazione e distruzione del paesaggio. Non bisogna per altro dimenticare che la sicurezza alimentare ha riguardato, e riguarda, il solo Occidente, che ne inizia a pagare il conto entropico oggi, con le migrazioni dei disperati economici.
In questi casi è sempre bene ricordare che quando si parla di banalizzazione e distruzione del paesaggio non si fanno solo discorsi di carattere estetico, da romantiche anime belle, ma si coinvolge anche l’economia e la stessa vita delle persone, in primis (ma non solo) le migliaia di morti e di miliardi di euro di danni legati all’inquinamento e al dissesto idrogeologico degli ultimi cinquanta-sessanta anni. Per non parlare dei costi energetici e di vite umane «prodotti» dal paesaggio urbano: uno studio della Global Commission on the Economy and Climate stima in 17 000 miliardi di dollari entro il 2050 il risparmio energetico nelle più grandi città del mondo che dovessero attuare concrete tecnologie green.
Quindi enorme rilevanza dell’agricoltura: Sereni insegna che tutti i paesaggi-area vasta, almeno fino alla rivoluzione verde, sono prodotti dall’uomo agricoltore, pastore e silvicultore, con la città che è organica al disegno del paesaggio, perché l’organizzazione del territorio risponde essenzialmente ai suoi bisogni: alimentari, forniti dai sistemi agro-pastorali, energetici e dei materiali da costruzione, provenienti dai sistemi forestali.
La stessa città, con i suoi orti, possiede una importante componente agraria, non a caso mancata quando è defunto il paesaggio urbano, con i non-luoghi che si è iniziato a costruire nella seconda metà del Novecento e che tuttora crescono, sebbene con una qualche consapevolezza degli errori commessi, ma anche con una perniciosa tendenza al maquillage verde. E, sempre non a caso, tutto ciò è coevo alla radicale trasformazione dell’agricoltura della rivoluzione verde, che, divenuta intensiva e «industriale», da genitrice di paesaggi si è trasformata in assassina.
L’Atelier 1 ha interpretato questi concetti, dimostrando come colture vitivinicole di pregio possano generare identità territoriale, oltre che economia fondamentale per aree interne altrimenti in difficoltà di sviluppo. È l’eterno tema dei servizi offerti dai sistemi naturali, a cui si sovrappone la cultura del fare ruralità, generatrice di paesaggio. Oggi si parla di servizi eco sistemici, termine contemporaneo che però evoca una tradizione mai interrotta, se non negli ultimi cinquanta-sessanta anni, sin dai tempi della centuriazione romana. La necessità di stretti rapporti fra urbano e rurale emerge in tutti i contributi, pur nelle diverse coniugazioni geografiche, spaziali e sociali: dalla Lombardia alle Marche, alla Sardegna; dall’agricoltura della campagna profonda a quella peri-urbana e urbana; dalla necessità di gestione delle risorse di fruizione comune a quella di incentivare il ripopolamento e la fruizione lenta delle aree rurali.
Scaturisce la centralità della pianificazione delle aree agricole e rurali in genere, ma che ancora non trova sbocchi adeguati, con l’ovvia inadeguatezza dei piani comunali, imprigionati in una legge che risale al 1942: oltre settanta anni di democrazia non sono stati sufficienti ad avere un’organica riforma urbanistica. Grandi potenzialità le avrebbero i piani di bacino, ma essi non hanno mai assunto l’autentica dimensione territoriale e forse per questo sono in stato comatoso, nonostante la splendida e defunta legge 183/1989. Anche i piani di sviluppo rurale potrebbero avere un ruolo strategico, ma, puntualmente, glissano il problema.
Rimangono allora le strategie per singoli elementi naturalistici, tutte degnamente rappresentate nell’Atelier 1: dai contratti di fiume alla riqualificazione delle coste, ai piani di gestione dei siti Natura 2000, ma è chiaro che tali strategie, pur fondamentali, non risolvono la questione della visione olistica che la cura del paesaggio richiede. Di conseguenza, ultima spes è la nuova generazione dei piani paesaggistici e, soprattutto, la loro applicazione e gestione, che devono saper costruire paesaggio riprendendo il filo della complessità perduta.
2. Cosa è emerso dal dibattito.
In coerenza con gli obiettivi che hanno mosso la XIX Conferenza della Siu sul tema dei Cambiamenti e sulla capacità degli strumenti dell’urbanistica e del senso di responsabilità degli urbanisti di accompagnare il cambiamento, la prima traccia del Workshop 1 (sdoppiato in 2 sottogruppi A e B) ha posto al centro dell’attenzione le questioni della crisi ambientale, dei cambiamenti climatici, delle sfide sempre più complesse della dimensione ambientale alla scala del territorio e della città. Le tre parole che identificavano l’atelier, ambiente, agricoltura, paesaggio, fanno riferimento a nozioni e problemi che non sono facilmente riconducibili lungo una stessa linea concettuale, capace di tenere in tensione argomenti e campi problematici complessi e tra loro diversificati. Le proposte arrivate, infatti, hanno dato risalto alla varietà delle questioni che erano in quelle parole configurabili, dimostrando una ricchezza del territori straordinaria, ancora più articolata della stessa traccia, esprimendo punti di domanda che i territori pongono al nostro sapere disciplinare, chiamando in causa altre discipline, allargando le competenze necessarie per affrontare i problemi e il senso di responsabilità per porvi rimedio.
Per questo motivo, prima dell’invio dei full paper, nella interlocuzione che da sempre la conferenza instaura con gli autori che decidono di aderire alle diverse sessioni, si è cercato di suddividere il workshop in quattro sottosistemi intendendoli campi problematici che gli stessi abstract inviati avevano delineato: 1) politiche, istituzioni e attori per il territorio, che definivano aspetti di messa in coerenza con la interscalarità e intersettorialità dei soggetti coinvolti sui temi di politiche ambientali e paesaggistiche; 2) problemi e risorse per le aree interne, come l’emergere di una geografia delle aree interne connessa ai temi della tutela e sviluppo del territorio; 3) dalla parte delle politiche agricole, che individuava una sempre più calzante domanda di connessione tra le politiche urbane e agricole perché si operasse in una visione comune; 4) strumenti tra città e campagna, un tema ormai molto dibattuto e che aggiorna le domande e la ricerca di strumenti adeguati per darvi operatività.
La discussione emersa ha mostrato la ricchezza dei territori e le numerose domande che le comunità pongono agli strumenti dell’urbanistica, ai modelli di governance che non sempre riescono ad essere capaci di cogliere la complessità delle nuove geografie istituzionali che si delineano, ma anche sollecitano ampliamenti concettuali del dibattito disciplinare.
Le aree geografiche dalle quali sono arrivate le proposte e le loro collocazioni dentro ai campi problematici forniti dai coordinatori della sessione hanno delineato una statistica, che proviamo a commentare: dei 13 contributi pervenuti, 2 sono del Nord Italia, 1 del Centro Italia e 7 del Sud Italia (2 sono stranieri e 1 è una trattazione metodologica). Inoltre, 4 contributi sono relativi al tema dalla parte delle politiche agricole alle politiche, 3 contributi riguardano il tema delle istituzioni e attori per il territorio, ai problemi e alle risorse per le aree interne, mentre 2 trattano degli strumenti tra città e campagna.
Emerge una più forte domanda di dibattito sui temi ambiente, agricoltura, paesaggio dai territori del Sud, un consolidamento e una sempre più forte articolazione delle questioni inerenti al rapporto tra politiche urbane e politiche agricole e l’emergere dell’agricoltura come componente sempre più coinvolta nel progetto urbanistico che richiama città e territorio. Inoltre in questo ambito di questioni emerge con sempre più evidenza una domanda di progettualità sulle aree interne, che richiama le politiche di valorizzazione e sviluppo sostenibile dei territori meno coinvolti dalle dinamiche di sviluppo, a bassa densità e con sottodotazioni di infrastrutture.
Da una disamina più dettagliata dei differenti contributi, emerge una nuova domanda di politiche agro-urbane capaci di accogliere attivamente il ruolo della campagna in città.
La visione agro-urbana è chiave del progetto dello spazio in senso multiscalare, capace di elaborare modelli agricoli multifunzionali, ma è anche sensibile a tutelare i territori agricoli periurbani a sfruttamento intensivo (Tucci), e a dare ascolto ai processi di cittadinanza attiva che emergono dai «movimenti di ruralizzazione della città» (Caprotti - Nofroni).
Le infrastrutture richiedono strumenti progettuali aggiornati poiché attraversano pianificazioni intersettoriali che devono farsi capaci di accogliere le tante questioni che questo genere di progettualità pone: la necessità di attivare processi di valorizzazione per trasformare le antiche itineranze per farne nuove narratività che aggiornino le maniere di attraversare il territorio (Interlandi - Saggiomo); le istanze che provengono da un paesaggio agricolo a bassa densità ma altamente produttivo, in cui vanno contemplate le politiche urbane dei territori attraversati e le richieste di mobilità veloce (Saloriani).
La gestione del rischio a livello territoriale riguardo ai territori fluviali (Ramirez-Avila, Schauweker, Prince Czarnecki) o a livello di territorialità metropolitane (Lüder - Ferretti) chiede strumenti capaci di gestire livelli di incertezza e con dati in contino aggiornamento utilizzando modelli progettuali come scenari, vision, in cui le relazioni tra istituzioni e attori per il territorio si rinnovano.
Le aree interne sono geografie critiche che non hanno distinzioni tra Nord e Sud, accumulate da problemi di bassa densità, spopolamento e invecchiamento della popolazione, scarse infrastrutture ma alti livelli di dotazioni di patrimoni materiali e immateriali, risorse ambientali e storico culturali. Le questioni sono quelle di capire se vanno adeguati gli strumenti già a disposizione come le visioni strutturali del piano perché si facciano carico di accogliere le istanze della pianificazione locale accogliendo i servizi ecosistemici dentro un modello prosumer (Arena - Nigro), oppure ponendosi dentro un paradigma di smart land con l’obiettivo di trasformare gli arcipelaghi territoriali dei territori interni in nodi di un complesso sistema integrato (Contato - Orlando), o di farne territori dell’innovazione sperimentando processi di recycle-based cityforming (Lauretta - Torrisi). Le politiche agricole mostrano sempre di più un coinvolgimento nelle politiche delle città (Mininni) e dei territori coinvolgendo soprattutto i nuovi soggetti rurali che animano la scena di un territorio che pur essendo prodotto dall’agricoltura si fa portavoce di complesse domande di abitabilità tra nuovi contadini portatori di un progetto di neo-ruralità e nuovi valori (Zamponi - De Bonis); inoltre l’imprenditore agricolo è sempre più coinvolto nella costruzione di paesaggi agricoli innovativi (Natalia).
Per concludere, le giornate del workshop hanno aperto una finestra sui territori facendo emergere un variegato panorama nazionale a declinazione regionale, ponendo domande alla disciplina perché questa metta a disposizione conoscenza utile e utilizzabile, capace di farsi carico delle tante questioni di abitabilità che la realtà pone. Si chiede, in altri termini, che l’urbanistica metta a frutto quello che da sempre la connota, ovvero di essere sempre all’altezza di interpretare i territori, di descrivere in maniera tecnicamente pertinente la loro complessità e le loro esigenze, descrizioni che possano delineare progetti impliciti e cogliere le domande dei soggetti che non hanno luoghi per esporle. Temi e questioni che mettono l’urbanistica «in fase» con il progetto paese, sui nuovi temi che sempre più numerosi provengono dalla triade ambiente, agricoltura e paesaggio.
![]()
II. Strategie per le aree interne: integrare i servizi ecosistemici e le azioni di tutela e sviluppo nel Puc di Volturara Irpina
di Antonia Arena e Antonio Nigro*
Il contributo presentato nel Workshop 1 «Ambiente, agricoltura, paesaggio» ha messo in luce come i temi dell’accesso ai beni comuni e la fornitura di servizi ecosistemici possano entrare nella pianificazione urbanistica comunale. Il caso del Piano urbanistico comunale (d’ora in poi Puc) di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, mostra, infatti, come le strategie definite per lo sviluppo futuro del comune si fondino su questi temi – integrando il sistema rurale-ricettivo-turistico con quello agricolo-produttivo – e cerchino di rispondere, al contempo, all’esigenza di contrasto all’abbandono delle aree interne del paese. La pianificazione dei «piccoli», per dimensione demografica, comuni consente di sperimentare forme di integrazione tra sistema agricolorurale, insediativo e produttivo come concreta prospettiva di sviluppo, e in questi casi sopravvivenza, in un’epoca in cui la competizione tra i territori si gioca sul recupero dei valori e dei patrimoni generati alla scala locale (Magnaghi 2007) e mediante la tutela dei valori ecologici (Moccia 2009b).
In Italia, dagli anni ottanta del secolo scorso, è stata evidenziata l’esistenza di territori «deboli», caratterizzati da indici demografici negativi, in cui si verificano stagnazione economica, calo della domanda di residenze e servizi (Becchi Collidà, Cicciotti, Mela 1989), abbandono di aree agricole e rurali, con conseguenze negative in termini di qualità ecologica e produttività agricola (Pelorosso e altri 2011).
Il calo demografico, verificatosi nelle ultime decadi in numerosi piccoli comuni italiani, localizzati prevalentemente in aree collinari e montane, può causare l’abbandono di vaste aree rurali, con conseguente riduzione della produttività agricola, assenza di presidio e tutela del territorio, fenomeni di dissesto idrogeologico, perdita delle qualità paesaggistiche e del patrimonio culturale delle comunità. Il presidio delle aree rurali o scarsamente abitate assume oggi rilevanza anche dal punto di vista ecologico, come evidenziato dal dibattito sui «servizi ecosistemici», che questi ambienti sono in grado di fornire (Costanza 2008; Millennium Ecosystem Assessment 2005; Santolini 2010).
Nel 2014, a testimonianza della rilevanza del tema nel nostro paese, il Dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato la «Strategia Nazionale per le Aree Interne», con l’obiettivo di porre un freno al calo demografico e prevenire i fenomeni di abbandono e spopolamento. Se...