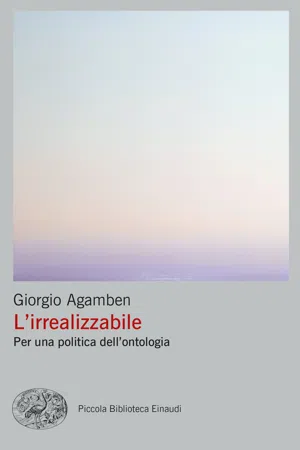1. Il verbo «realizzare» appare tardivamente nelle lingue romanze, in italiano non prima del XVIII secolo, come traduzione del francese réaliser. Da allora, tuttavia, esso diventa progressivamente sempre piú frequente, non soltanto nel vocabolario dell’economia e della politica, ma anche, soprattutto nella diatesi riflessiva, in quello dell’esperienza personale. Leopardi, che pure mette in guardia contro l’abuso dei francesismi nell’italiano, si serve piú volte del termine e dei suoi derivati, in particolare per il tema, su cui torna cosí spesso, delle illusioni («la società umana, – scrive nello Zibaldone, 680, – manca affatto di cose che realizzino le illusioni per quanto sono realizzabili»). E se nella modernità la politica e l’arte definiscono la sfera in cui le illusioni agiscono con piú forza, non stupisce che proprio in questi ambiti il lessico della realizzazione trovi il suo massimo dispiegamento.
2. Si suole attribuire a Marx l’idea di una realizzazione della filosofia nella politica. In verità l’interpretazione dei passi dell’introduzione alla Critica della filosofia del diritto di Hegel in cui egli sembra enunciare questa tesi è tutt’altro che scontata. Egli la formula una prima volta come un’obiezione a un non meglio identificato «partito politico pratico» che rivendicava la negazione della filosofia: «Voi non potete abolire (aufheben) la filosofia, – egli scrive, – senza realizzarla (verwirklichen)». Poco dopo, contro i rappresentanti del partito opposto, egli aggiunge che essi hanno creduto «di poter realizzare la filosofia senza abolirla». E, dopo aver definito il proletariato come la dissoluzione di tutti i ceti, l’introduzione si conclude con l’affermazione perentoria, che lega realizzazione della filosofia e abolizione del proletariato in un circolo: «la filosofia non può realizzarsi se il proletariato non viene abolito e il proletariato non può essere abolito se la filosofia non si realizza».
Ancor prima, nelle note alla dissertazione sulla Differenza fra la filosofia della natura di Democrito e Epicuro, discussa a Jena nel 1841, Marx aveva scritto che quando la filosofia cerca di realizzarsi nel mondo, «il diventar filosofico del mondo è, nello stesso tempo, il diventar mondana della filosofia e il suo realizzarsi è, insieme, il suo perdersi (ihre Verwirklichung zugleich ihr Verlust)»1. Dal momento che Marx non intendeva qui semplicemente riprendere come tale la dialettica hegeliana, che cosa potesse significare per lui una rivoluzione che avrebbe verificato le due tesi simmetriche «abolire e realizzare la filosofia» e «abolire e realizzare il proletariato» non è certo evidente. Ed è giocando su questo difetto di chiarezza che Adorno ha potuto aprire la sua dialettica negativa affermando che «la filosofia, che un tempo sembrò superata, si mantiene in vita perché il momento della sua realizzazione è stato mancato»2. Quasi che, se non avesse mancato quel momento, essa non esisterebbe piú, si sarebbe, realizzandosi, abolita. Ma che cosa significa «realizzarsi»? E che cosa significa «mancare la propria realizzazione»? Noi usiamo questi termini come se il loro senso andasse da sé – ma appena proviamo a definirlo, esso ci sfugge e si rivela opaco e contraddittorio.
3. Nella Fenomenologia dello spirito i due termini tedeschi per realizzazione, Verwirklichung e Realisierung, appaiono rispettivamente 49 e 19 volte e una ventina di volte il verbo realisieren. Ancora piú frequenti sono i due vocaboli per «realtà»: 68 occorrenze per Wirklichkeit e 110 per Realität. Com’è stato osservato, questa frequenza non è casuale, ma si tratta di termini tecnici a pieno titolo3.
L’esperienza della coscienza che è in questione nella Fenomenologia implica un continuo processo di realizzazione, che è però ogni volta puntualmente difettosa o mancata. Che si tratti della certezza sensibile (per la quale la realtà che essa crede di affermare «abolisce la sua verità» e «dice il contrario di ciò che vuole dire»), della «dialettica della forza» («La realizzazione della forza è nello stesso tempo perdita della realtà»), della coscienza naturale (per la quale «la realizzazione del concetto vale piuttosto come la sua perdita»), della cultura (in cui «il Sé è cosciente di essere reale soltanto come Sé abolito»), dell’anima bella (la cui realizzazione «sparisce in una vuota nebulosità») o della coscienza infelice («la sua realtà è immediatamente il suo nulla»), la realizzazione è sempre anche perdita e abolizione di sé. Ciascuna delle figure in cui lo spirito si realizza nel suo movimento si abolisce per cedere il posto a un’altra figura, che a sua volta si sopprime in un’altra fino a raggiungere l’ultima, che è il «sapere assoluto» (das absolute Wissen). Ma proprio in quanto lo spirito non è che questo movimento di incessante autorealizzazione, la sua «ultima figura» (lezte Gestalt) non può che avere la forma di una rimembranza in cui lo spirito «abbandona la sua esistenza e ne affida la figura al ricordo», una sorta di «galleria d’immagini, ciascuna delle quali è adorna di tutta la ricchezza dello spirito». Nel ricordo, «lo spirito nella sua immediatezza deve ancora una volta ricominciare da capo il suo movimento e ingenuamente estrarre da questa figura la sua grandezza, come se tutto ciò che precede fosse perduto per lui». Il sapere assoluto (cioè lo spirito «che conosce se stesso come spirito») non è una «realtà», ma piuttosto la contemplazione di una incessante «realizzazione», la cui realtà deve essere per questo ogni volta smentita e apparire nel ricordo solo come la «schiuma della propria infinità». La realizzazione è la negazione piú radicale della realtà, perché se tutto è realizzazione, allora la realtà è qualcosa di insufficiente, che deve essere incessantemente abolita e superata e la figura ultima della coscienza non potrà che avere la forma di una realizzazione della realizzazione (questo è il sapere assoluto). Contro questa concezione, occorre ricordare che la realtà non è l’effetto di una realizzazione, ma un attributo inseparabile dell’essere. Il reale, come tale, è per definizione irrealizzabile.
4. È singolare che quasi un secolo dopo Debord riprenda la formula marxiana riferendola questa volta non alla filosofia ma all’arte. Egli rimprovera ai dadaisti di aver voluto abolire l’arte senza realizzarla e ai surrealisti di aver voluto realizzare l’arte senza abolirla. Quanto ai situazionisti, invece, essi intendono realizzare l’arte e, insieme, abolirla.
Il verbo, che nel testo marxiano abbiamo tradotto con abolire, è quello stesso – aufheben – che, col suo doppio significato, svolge un compito essenziale nella dialettica di Hegel, cioè: abolire, far cessare (aufhören lassen) e conservare (aufbewahren). L’arte si può realizzare nella politica solo se, in qualche modo, si abolisce e, insieme, si conserva in essa. Come Robert Klein aveva osservato in un saggio del 1967, significativamente intitolato L’eclissi dell’opera d’arte, l’abolizione che le avanguardie avevano in mente non era diretta tanto contro l’arte, quanto contro l’opera, a cui l’arte pretendeva di sopravvivere. Questo resto di artisticità vagante è raccolto dall’arte contemporanea, che rinuncia alla realtà dell’opera in nome della realizzazione dell’arte nella vita.
Il verbo aufheben, cui Hegel affida questo arcano dialettico, ha acquisito il suo duplice significato attraverso la traduzione luterana del Nuovo Testamento. Di fronte al passo della lettera ai Romani (3.31), che aveva da sempre messo in imbarazzo gli interpreti, perché Paolo sembra affermare insieme l’abolizione della legge e la sua conferma («Aboliamo – katargoumen – dunque la legge attraverso la fede? Non sia, anzi, la innalziamo – histanomen»), Lutero decide di tradurre il gesto antinomico della katargesis paolina con aufheben (heben wir das Gesetz auf).
L’intenzione dell’apostolo era però necessariamente piú complessa. Nella prospettiva messianica in cui egli si situava, l’avvento del Messia significava la fine della legge (telos tou nomou, Rm 10.4), nel duplice senso che il termine telos ha in greco: fine e, insieme, compimento, pienezza. La critica di Paolo non si rivolgeva, infatti, alla Torah come tale, ma alla legge nel suo aspetto normativo, che egli definisce senza possibili equivoci nomos ton entolon, legge dei comandi (Ef 2.15) o anche nomos ton ergon (legge delle opere, Rm 3.27). Si tratta, cioè, per lui di revocare in questione il principio rabbinico secondo cui la giustizia si ottiene compiendo le opere prescritte dalla legge («noi crediamo – egli scrive – che un uomo sia giustificato senza le opere della legge», Rm 3.28).
Per questo, ogni volta che deve esprimere il rapporto fra il Messia e la legge, egli si serve del verbo katargeo, che non significa «distruggere», come a volte traduce la Vulgata, bensí «rendo inoperante, faccio uscire dall’ergon e dall’energeia» (in questo senso, katargeo è il contrario di energeo, che vale «metto in opera, attuo»). Paolo conosce perfettamente l’opposizione cosí familiare al pensiero greco a partire da Aristotele fra potenza (dynamis) e atto (energeia) e vi fa piú volte riferimento (Ef 3.7: «secondo l’energeia della sua dymanis»; Gal 3.5: lo spirito «mette in opera – energon – in voi le potenze – dynameis»). Rispetto alla legge, tuttavia, l’evento messianico opera un’inversione della normale relazione fra i due termini, che privilegia l’atto: il compimento della legge che qui avviene ne disattiva invece l’energeia e rende inoperanti i suoi comandamenti. La legge cessa di essere qualcosa che deve essere realizzato nei fatti e nelle opere e la katargesis del suo aspetto normativo apre al credente la possibilità reale della fede, come pienezza e compimento della Torah, che ora si presenta come «legge della fede» (nomos pisteos, Rm 3.27). In questo modo la legge è restituita alla sua potenza – una potenza che, secondo il limpido dettato di 2 Cor 12.9, «si compie nella debolezza» (dynamis en astheneia teleitai). Né di abolizione né di realizzazione si può qui propriamente parlare: la fede non è qualcosa che possa essere realizzato, perché essa stessa è la sola realtà e la sola verità della legge.
5. Che Platone, nei suoi tre viaggi in Sicilia alla corte di Dionisio, cercasse di realizzare la filosofia nella politica è quanto una lettura non sufficientemente attenta della Lettera VII sembra suggerire. Platone giustifica qui infatti il suo soggiorno presso il tiranno con lo scrupolo di apparire ai propri occhi come un uomo «che è soltanto parola e non si impegna mai in nessuna opera» e confessa di aver ceduto alle insistenze degli amici che gli ricordavano che «se mai qualcuno poteva impegnarsi a portare a buon fine (apotelein) quel che aveva pensato sulle leggi e sulla politica, questo era il momento di provare» (328c). Che cosa egli intendesse con queste parole lo si può comprendere, tuttavia, solo mettendole a confronto con quanto scrive poco prima (326b) sulla giusta relazione tra filosofia e politica: «i mali che affliggono le generazioni umane non cesseranno, prima che il genere dei veramente e giustamente filosofanti non pervenga alle magistrature politiche o coloro che hanno il potere nelle città per una qualche sorte divina veramente facciano filosofia (philosophesei)». Questa tesi perentoria riprende la teoria del filosofo-re che Platone espone quasi con le stesse parole in un celebre passo della Repubblica (473d): «A meno che i filosofi regnino nelle città o che quelli che sono detti ora re e dinasti filosofino veramente e con competenza (philosophesosi gnesios te kai ikanos) e siano unite in uno stesso (eis tauton sympesei – l’espressione è pregnante: sympegnymi significa anche «coagulare») la dynamis politica e la filosofia […] non diminuiranno i mali per le città e per il genere umano, e la politica stessa di cui abbiamo ora parlato non nascerà (phyei) per quanto è possibile né vedrà la luce del sole».
L’interpretazione corrente di questa tesi platonica è che i filosofi devono governare la città, perché solo la razionalità filosofica può suggerire a chi governa le giuste misure da adottare. Platone affermer...