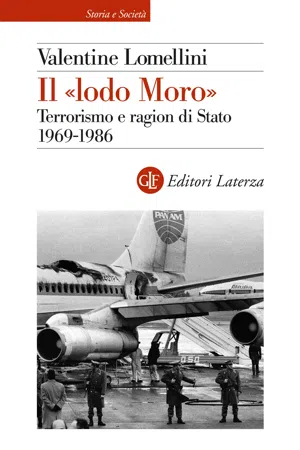VI.
La prosecuzione del «lodo»
1. 1976: il consolidamento dell’accordo. Presidenza della Repubblica e magistratura
Tra la fine del 1975 e l’estate del 1976 ebbero luogo due importanti attentati che condizionarono l’atteggiamento degli Stati europei nei confronti del terrorismo internazionale. Nel dicembre 1975, un commando occupò la sede dell’OPEC a Vienna, prendendo in ostaggio undici ministri del Petrolio dei Paesi arabi, oltre al personale dell’Organizzazione1. Tra il giugno e il luglio 1976, invece, si consumò l’attentato nei confronti di un aereo Air France, che fu costretto ad atterrare ad Entebbe, in Uganda2. A fronte della compiacenza del leader ugandese Idi Amin nei confronti dei terroristi, Israele ritenne di effettuare un raid per portare in salvo gli ostaggi ebrei che, insieme al personale dell’aereo, i terroristi si erano rifiutati di liberare a causa della loro appartenenza religiosa – aggiungendo un ulteriore elemento di complessità alla crisi3.
Alla metà del decennio, fu definitivamente chiaro che il terrorismo era un attore delle relazioni internazionali in grado di condizionare i rapporti tra gli Stati, i processi di pace e di generare crisi diplomatiche e militari. La stessa composizione dei commandos rivelava poi un’evoluzione: da militanti palestinesi, le squadre terroristiche erano formate sempre più da elementi ai margini della Resistenza, con un ulteriore coinvolgimento da parte di alcuni Stati arabi, la Libia in primis.
Nell’ambito della cooperazione internazionale in materia di terrorismo, l’Italia si mostrò tendenzialmente disposta alla collaborazione. La posizione italiana era tuttavia connotata da un filo-arabismo che divenne sempre più marcato nel tempo. Ne fu un esempio il dibattito che si sviluppò ai margini dei fatti di Entebbe, durante il quale la Repubblica Federale Tedesca propose che il rappresentante olandese presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite intervenisse per chiedere l’adozione di una dichiarazione di condanna del terrorismo, focalizzata sulla «prassi criminale del dirottamento di aerei e della minaccia alla vita di innocenti passeggeri ed equipaggi»4. Il sostegno alla causa tedesca da parte degli italiani non appariva affatto scontato. Era il nodo politico della questione che non li trovava concordi: non ci si poteva astenere dal «risalire alle cause del terrorismo», e «non era possibile scindere le responsabilità di una parte da quelle dell’altra». In altri termini, non si poteva condannare l’attentato senza prendere in considerazione le responsabilità di Israele5.
L’orientamento filo-arabo dei governi italiani, che nascevano e si dissolvevano in rapida successione, si fece più evidente pur non uscendo dalla cornice dell’equidistanza teorizzata da Moro, in un quadro generale europeo di peggioramento dei rapporti con Tel Aviv6. In questo contesto, tra il marzo 1974 e il luglio 1976, si succedettero in Italia ben tre governi (Rumor V, Moro IV e V) nei quali i due esponenti democristiani si alternarono alle cariche di presidente del Consiglio e di ministro degli Esteri7. Per lo Stato, le sfide assumevano forme diverse: la crisi economica, il processo al «regime democristiano», la prova del referendum sul divorzio8. L’endemica instabilità italiana era destinata a consolidarsi anche dato l’evolvere dell’orientamento dell’elettorato. Alle elezioni amministrative del 1975 e a quelle politiche dell’anno successivo, il Partito comunista italiano conobbe il migliore risultato della storia della Repubblica: nel 1976 il 34,37% degli elettori votò comunista, rendendo il «sorpasso» con la Democrazia cristiana, che si attestò al 38,71%, a portata di mano. Con l’elezione del democratico Jimmy Carter, una parte della classe dirigente italiana rilevava segnali di apertura anche oltreoceano. Poco importava se queste speranze sarebbero state disilluse dalla dichiarazione del Dipartimento di Stato USA del gennaio 1978, ove si chiariva che l’atteggiamento statunitense sulla partecipazione comunista ai governi dei Paesi NATO non era poi così favorevole come la stampa aveva fatto intendere9. Tra il 1974 e il 1975, inoltre, caddero alcune delle più importanti dittature militari nel Mediterraneo (Grecia, Portogallo e Spagna), confermando la percezione di uno spostamento a sinistra degli equilibri europei10. La firma dell’Atto finale di Helsinki, che portava a compimento il processo inaugurato tre anni prima con la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, suggellò la détente, lasciando spiragli per una distensione anche nei singoli contesti nazionali. In tale frangente, la proposta politica di un’alternativa al socialismo reale, l’eurocomunismo, proposta dai tre principali partiti comunisti occidentali – quello francese, quello spagnolo e quello italiano, ma sostenuta soprattutto da quest’ultimo come evoluzione internazionale del compromesso storico –, parve inserirsi in un clima di generale miglioramento delle relazioni internazionali11.
In una cornice di evoluzione delle relazioni internazionali e di inedita attenzione al confronto Nord-Sud, il dialogo dell’Italia con la Libia proseguì, dando luogo alle «intese romane Rumor-Moro-Jallud» del febbraio 1974 nei settori della «ampia collaborazione petrolifera, petrolchimica, industriale». Oltre agli ovvi (e importanti) risvolti economici, questa intesa avrebbe dovuto avere due obiettivi: «l’incontro tra mondo arabo ed Europa» in «condizioni di chiarezza reciproca e di autonomia rispetto alle ingerenze esterne» e la definizione di un assetto mediterraneo caratterizzato da «sicurezza, stabilità e cooperazione»12. Questa iniziativa, che si sviluppava in parallelo rispetto a quella del dialogo euro-arabo intersecandola in vari punti, era frutto di una visione di distensione mediterranea.
Nell’aprile 1975, il primo ministro libico Jallud, di ritorno da una visita in Austria e nella Repubblica Democratica Tedesca, chiese e ottenne un incontro ai più alti vertici dello Stato italiano13. Nel corso dello scambio, Jallud propose e insistette per la definizione di uno «schema di intesa globale» in cui fosse definito con più ampio respiro il programma di cooperazione economica e finanziaria tra i due Paesi. La proposta fu accolta positivamente sia dal Ministero degli Esteri italiano sia dagli alti vertici dell’ENI: entrambi auspicavano un accordo che fosse «concretamente operativo» al fine di imprimere una «reale svolta» allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi rivieraschi14. L’intento italiano era soprattutto quello di raggiungere un’intesa di natura economica; non era così per il primo ministro libico, che dimostrava d’aver «fretta di concludere» e desiderava dare la precedenza ad un accordo politico15. Con un cambio di passo percettibile, il governo italiano si trovava ora nella posizione di far valere con maggiore forza la propria posizione: nel colloquio con Jallud, Moro mantenne il punto, affermando così l’idea che era necessario acquisire degli elementi tecnici (cioè sostanzialmente definire il problema del prezzo del petrolio) prima di passare agli aspetti politici16.
Ma, a prescindere da ciò, le principali conseguenze (e ragioni) di questo accordo da parte libica erano chiare agli italiani e da essi condivise: rafforzare, a livello interno, la linea gheddafiana di collaborazione verso l’Europa, così contribuendo a consolidare, indirettamente, lo sviluppo di una politica mediterranea comune e condivisa dai Paesi europei17. Dal canto proprio, l’Italia pareva aver recuperato una forza negoziale inedita nei confronti della Libia di Gheddafi: anche rispetto alla vendita di armi, a fronte delle rimostranze libiche, i rappresentanti italiani rivendicarono di aver in larga parte soddisfatto la controparte con vendite militari («navi, elicotteri, mezzi di trasporto») e con «offerte» che erano in corso di esame («sommergibili e sistemi missilistici»)18.
Il dialogo appariva favorito da una valutazione comune della questione palestinese: entrambi gli interlocutori, seppur con toni diversi, condividevano la necessità di tenere in considerazione i diritti dei palestinesi e la valutazione negativa dell’irrigidimento intercorso da parte israeliana19. In questa cornice, rievocando le «gravi difficoltà di comprensione» degli anni precedenti, da parte libica fu riconosciuto e valorizzato in particolare il ruolo di Aldo Moro: Jallud ricordò «come al momento della crisi fu cosa buona che il Presidente Moro fosse Ministro degli Esteri». Moro rispose compiaciuto, ringraziando per «il cortese riconoscimento dato ad un’azione personale svolta superando pressioni emotive dell’opinione [pubblica]». Il commento poteva essere riferito sia alle difficoltà iniziali emerse nell’incontro del 1971 sia ai fatti di Fiumicino, ma il riferimento di Moro alle «pressioni emotive dell’opinione [pubblica]», ripreso dal leader democristiano più volte dopo l’attentato, mi pare indicare in modo più netto questa seconda opzione, sottolineando così il ru...