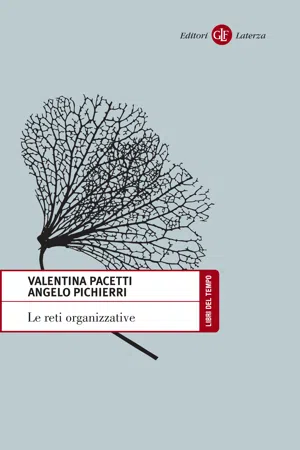1.
Che cosa sono le reti organizzative
Questo volume vuole offrire ad analisti, studiosi e operatori uno strumento per l’analisi organizzativa delle reti. Le reti alle quali facciamo riferimento sono reti di organizzazioni. Questa precisazione identifica un campo di interesse che lascia fuori dai propri confini gran parte delle pur interessanti riflessioni sulle reti di persone e sul ruolo dell’analisi di rete come strumento per la comprensione di vari e diversi fenomeni sociali: i fenomeni sociali ai quali ci rivolgiamo sono esclusivamente di carattere organizzativo. Anche restando all’interno di questo segmento delle riflessioni sociologiche, tuttavia, il concetto di rete assume significati tra loro anche profondamente diversi. Ci pare che le diverse prospettive possano essere raccolte all’interno di tre diverse famiglie di significati assunti dal concetto di rete organizzativa.
1. Tre diverse accezioni dell’espressione “rete organizzativa”
Un primo significato del termine rete, utilizzato in senso lato, è quello che troviamo in molte delle riflessioni sui processi di de-verticalizzazione della grande impresa di origine fordista. Il passaggio dell’organizzazione di fabbrica “dal castello alla rete” (Butera 1990) individua la seconda come rappresentazione ideale della configurazione assunta da organizzazioni che si allontanano progressivamente dal modello della grande impresa verticalmente integrata e gerarchicamente controllata. Le nuove organizzazioni perseguono strategie diverse dalla produzione di massa e predispongono strutture organizzative nelle quali assumono un ruolo sempre più importante unità dotate di livelli crescenti di autonomia. Il progressivo affermarsi di strutture divisionali, oggetto della classica ricerca di Chandler (1976), va certamente in questa direzione: le varie divisioni delle grandi corporations vengono dotate delle risorse economiche e gestionali necessarie per presidiare un certo prodotto, una certa area geografica, una certa parte del processo produttivo. Man mano che tali unità si “autonomizzano” dal centro direzionale della casa madre, la struttura organizzativa assume la configurazione di una rete della quale le varie divisioni costituiscono i nodi. I nodi della rete sono in questo caso “microstrutture” (Butera 2009), parti dell’organizzazione.
Il termine rete ricorre anche nelle analisi dei gruppi di imprese altamente diversificati e delle imprese multinazionali caratterizzate da diversi gradi di dispersione territoriale. La struttura a rete tiene allora insieme le unità responsabili dei diversi prodotti, o gruppi di prodotti, oppure le unità sedi che presidiano diversi territori o aree territoriali. Vengono quindi definite come imprese-rete grandi imprese con organizzazione divisionale, gruppi di imprese, holding, ecc.
Alcuni di questi casi, sebbene coerenti con la nostra prospettiva, interessano solo parzialmente lo sviluppo del volume, perché rimangono osservabili con gli strumenti tradizionali dell’analisi organizzativa. Più nello specifico, riteniamo che per studiare queste realtà possa essere particolarmente efficace l’analisi sistemica, colpevolmente trascurata a favore dell’adozione spesso frettolosa del nuovo paradigma reticolare. Possiamo dire che in molti casi l’uso del termine rete sembra di carattere più metaforico che analitico, mentre la prospettiva sistemica offrirebbe strumenti di analisi efficaci per l’individuazione delle componenti delle organizzazioni più complesse e delle relazioni di retroazione che le connettono.
Il riferimento ai processi di de-verticalizzazione richiama in modo diretto le riflessioni di molti autori condotte a partire dall’affermarsi dell’economia dei costi di transazione (Williamson 1975; Eccles 1985; si veda anche Nacamulli e Rugiadini 1985): quanto più le imprese rinunciano a controllare alcuni segmenti del processo produttivo attraverso la gerarchia aziendale, tanto più il “castello” del controllo burocratico cede il passo a una rete delle relazioni di mercato. Naturalmente il processo non riguarda solo le imprese, ma varie classi di organizzazioni, tra le quali non mancano le pubbliche amministrazioni, che tendono a delegare ad altri soggetti porzioni crescenti delle attività e dei servizi erogati. I casi dei servizi di ristorazione scolastica o dei servizi per l’infanzia affidati a cooperative attraverso bandi sono solo alcuni degli esempi che possono essere analizzati e discussi, ma si fanno strada anche più complesse forme di partnership tra pubblico e privato per la gestione di vari aspetti dei servizi socioassistenziali (Le Grand 1991; Rossi e Colombo 2019) che portano in primo piano il tema dei sistemi di coordinamento e controllo che possono essere attivati per la gestione delle reti (ce ne occuperemo nei prossimi paragrafi).
Il processo di de-verticalizzazione può quindi assumere diverse forme: l’organizzazione che assume una forma divisionale rimane formalmente unitaria e, pur dotandosi di una struttura “a rete” non perde la propria soggettività, anche giuridica; nel caso della delega di attività ad altre organizzazioni, formalmente autonome, possiamo invece assistere alla nascita di una rete inter-organizzativa.
È questo il secondo significato dell’espressione “rete organizzativa”, quella che proponiamo di considerare come “rete in senso stretto”. Nei prossimi paragrafi proporremo una definizione completa delle reti inter-organizzative, ma per il momento vogliamo sottolineare che si tratta di entità organizzative costituite da organizzazioni autonome, che collaborano per il raggiungimento di un obiettivo comune. I nodi della rete sono organizzazioni indipendenti.
La ricerca sociologica (ma anche, a volte soprattutto, quella economica) ha spesso osservato oggetti di questo tipo, a partire dal modello dei distretti industriali. Nei distretti, il sistema economico locale è costituito da piccole imprese indipendenti e gran parte delle ricerche migliori sull’argomento si sono concentrate sulle relazioni che legano tra loro questi nodi, sulle condizioni di funzionamento di transazioni incredibilmente poco costose e sui meccanismi di integrazione tra la vita economica e quella della comunità locale. Restando in tema di agglomerazioni di imprese, troviamo la stessa logica nelle numerose ricerche che usano il concetto di cluster, sottolineando più di quanto non faccia la letteratura distrettuale la compresenza nella rete di nodi-organizzazioni di diversa natura (non solo imprese ma istituzioni educative e di ricerca, governi locali, ecc.).
Una prospettiva di questo tipo è spesso utilizzata per studiare il radicamento delle imprese nell’ambiente. Osservando con quali organizzazioni e istituzioni pubbliche e private interagisce un nodo della rete, possiamo tracciare l’insieme delle relazioni che connettono l’organizzazione al suo task environment, mettendone a fuoco punti di forza e punti di debolezza. Si tratta di una prospettiva molto efficace per l’analisi dei modelli di sviluppo locale, ma anche per la comprensione delle condizioni territoriali di successo dei diversi modelli organizzativi (Trigilia 1998; Regini 2000). Osservare le reti inter-organizzative vuol dire interrogarsi sulle motivazioni che spingono gli attori a collaborare, sulle risorse che vengono scambiate, sugli incentivi e sulle resistenze alla collaborazione. La rete nasce “dal basso”, per aggregazione di unità dotate di autonomia e di una propria individualità anche giuridica.
Un terzo significato spesso attribuito all’espressione “rete organizzativa” è quello utilizzato da chi osserva le organizzazioni come reti sociali costituite dai membri che ne fanno parte. I nodi della rete sono in questo caso le persone che compongono l’organizzazione, e il funzionamento dell’organizzazione è dato dalle relazioni e dalla loro struttura. Qualcuno considera questa “organizzazione network” come un modello alternativo a quelli precedenti, caratterizzati da strutture integrate, tanto da farne il fulcro di una nuova “èra” per le organizzazioni (Catino 2012), nella quale non contano tanto le funzioni e le gerarchie, quanto le persone e il flusso delle loro relazioni. Oggi questo tipo di approccio è rafforzato dalla disponibilità di tecniche di analisi sofisticate, e dalla possibilità di utilizzare modelli statistici e rappresentazioni grafiche basate sull’utilizzo delle tecniche di social network analysis (si vedano ad esempio Krackhardt e Hanson 1993; Cross et al. 2010), che consentono di riflettere in modo esplicito sul diverso ruolo di relazioni formali e informali nelle organizzazioni.
L’idea che le relazioni formali (prevalentemente di tipo gerarchico) siano in grado di raccontare solo una parte di quello che avviene nella vita quotidiana delle organizzazioni non è una novità. Basti pensare alle riflessioni di Crozier (1969) a proposito dell’imprevista distribuzione del potere in organizzazioni altamente burocratiche. Anche le osservazioni di Burt (1992) a proposito del concetto di “buco strutturale” si collocano in questa prospettiva: se vogliamo comprendere la velocità delle carriere dei manager dentro le organizzazioni non dobbiamo guardare tanto alla struttura dell’impresa o al capitale umano del singolo quanto alla posizione che il soggetto ricopre all’interno della rete di persone che veicola informazioni strategiche dentro l’organizzazione. La capacità di mettere in contatto segmenti che non hanno legami alternativi, e di veicolare quindi informazioni rilevanti, è fonte di potere nello studio di Burt come la possibilità di gestire i residui margini di incertezza è fonte di potere per l’operaio di manutenzione descritto da Crozier. In entrambi i ...