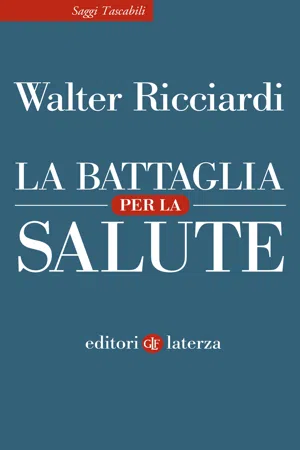
eBook - ePub
La battaglia per la salute
Walter Ricciardi
This is a test
Share book
- 112 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
La battaglia per la salute
Walter Ricciardi
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Viviamo in un paese fortunato: l'Italia è da anni ai vertici delle classifiche degli indicatori sanitari mondiali, con la maggiore aspettativa di vita dopo il Giappone e tassi bassissimi di mortalità materna e infantile. Non solo: se andiamo in ospedale per un accertamento o un ricovero non ci vengono chiesti né carta di credito né certificato assicurativo. Tutto questo grazie al Servizio sanitario nazionale, un sistema universalistico che non discrimina in funzione di sesso, razza, religione, livello economico-sociale. Da tempo però la nostra sanità pubblica sta attraversando una gravissima crisi. Se non si interviene presto e bene con un radicale cambio di rotta sarà una vera e propria débâcle civile e sociale.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is La battaglia per la salute an online PDF/ePUB?
Yes, you can access La battaglia per la salute by Walter Ricciardi in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Volkswirtschaftslehre & Wirtschaftspolitik. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Subtopic
Wirtschaftspolitik1.
Breve storia della tutela
della salute
1. La nascita del sistema assicurativo sociale nella Prussia di Bismarck
I sistemi sanitari come li intendiamo oggi sono un frutto della modernità: in passato era possibile curarsi solo se si disponeva dei mezzi economici sufficienti per pagare il medico, che peraltro fino a cent’anni fa o forse meno aveva strumenti diagnostici e terapeutici decisamente limitati. Per arrivare al primo sistema sanitario moderno bisogna attendere la fine del XIX secolo.
Nell’Europa di quell’epoca non si viveva praticamente mai in pace. Le guerre tra le potenze si susseguivano senza soluzione di continuità: la Francia contro l’Inghilterra, la Prussia contro la Russia, e poi l’Austria contro l’Italia – diventata un paese unitario solo nel 1861 e ancora nel 1847 definita da Metternich una «espressione geografica» – per poi proseguire con la costante tensione al confine tra Francia e Germania, che periodicamente si trasformava in conflitto aperto.
Uno dei problemi per tutti i capi di Stato e di governo dell’epoca era la scarsità della manodopera, cioè della risorsa essenziale con cui si combattevano le guerre e con cui si costruivano le armi: i soldati e gli operai.
L’aspettativa di vita media del tempo era inferiore ai quarant’anni. Epidemie di malattie infettive mietevano migliaia di vittime, e soldati e operai, quando si ammalavano, non avevano quasi mai risorse sufficienti per pagare di tasca propria le limitate cure che i medici potevano erogare loro. Certo, fin dal 1500 c’erano ordini religiosi che avevano tra le loro ragioni d’essere l’assistenza e la fondazione di ospedali, come i Fatebenefratelli, ma la loro misericordia non poteva certamente risolvere i problemi di milioni di persone ed essi erano solo una pallida luce nelle tenebre della malattia e della sofferenza che coinvolgevano intere popolazioni.
Come spesso succede, però, la necessità aguzza l’ingegno e, nei paesi di prima industrializzazione, gli operai avevano provato ad auto-organizzarsi, cominciando a versare mensilmente una piccola parte del proprio salario in una cassa comune a cui attingevano per pagare le cure per sé stessi e per la propria famiglia nel momento del bisogno. Erano nate così le Società di mutuo soccorso, che avevano però anch’esse il limite di coprire solo una parte molto limitata della popolazione.
Lo statista che intuì la necessità di un sistema sanitario moderno per supportare lo sviluppo economico del proprio paese fu il primo cancelliere dell’impero tedesco, Otto von Bismarck, che estese all’intera Germania l’idea del mutuo soccorso introducendo l’obbligo normativo per tutti i cittadini di stipulare una polizza assicurativa sanitaria, pagata in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente. Il risultato fu eccezionalmente positivo. Di fatto, l’obbligo garantiva una copertura universale in un sistema in cui lo Stato aveva la funzione di garante, di controllore e, per coloro che, non avendo un lavoro, non disponevano di un reddito per pagare un’assicurazione, di finanziatore di un pacchetto minimo di copertura dei rischi sanitari.
La popolazione apprezzò e l’economia ne uscì rafforzata, per non parlare del potenziale bellico della Germania, anche se questo portò – come è noto – a un eccesso di militarismo non estraneo al divampare di tutti i conflitti che sconvolsero l’Europa, anche nel XX secolo.
Fatto sta che tutti i paesi, inclusa l’Italia con la legge Crispi-Pagliani (presidente del Consiglio il primo, professore ordinario di Igiene all’Università di Torino il secondo), abbracciarono, con maggiore o minore successo, il modello bismarckiano, denominato da allora «assicurativo sociale» e che rimase per molti decenni l’unico modello di sistema sanitario.
Per la nascita del secondo modello bisognerà aspettare quasi settant’anni e due terribili guerre mondiali.
2. Il primo servizio sanitario nazionale al mondo: il National Health Service britannico
All’indomani della vittoria sul nazifascismo, il primo ministro britannico Winston Churchill, che aveva dato un contributo indubitabile e fondamentale nella lotta contro le dittature e che aveva portato alla vittoria il proprio paese, immaginava che sarebbe stato rieletto trionfalmente dai cittadini, riconoscenti per una leadership leggendaria esercitata in condizioni proibitive. Invece, gli inglesi assicurarono una forte maggioranza parlamentare al partito contrario a Churchill, quello laburista, che aveva promesso «non più lacrime e sangue», ma un futuro di serenità e prosperità basato su un sistema di welfare garantito «dalla culla alla tomba», concepito dalla mente geniale dell’economista e sociologo William Beveridge: scuola e università, formazione professionale, sussidi di disoccupazione, pensioni e, per la salute, un National Health Service (NHS), un servizio sanitario nazionale, naturalmente pubblico, finanziato con le tasse dei cittadini, in cui operavano medici e personale salariato, gratuito al momento dell’uso, equo, solidale.
Un’utopia che diventava realtà e, ai giornalisti che gli chiedevano se davvero pensava di poter realizzare quel che prometteva, il ministro della Sanità Aneurin Bevan rispose senza esitazione: «Sì! La malattia non è un lusso da pagare o una maledizione da vivere da soli, ma un evento che deve essere affrontato grazie alla efficienza di una società solidale».
E così fu. Tra l’incredulità della gente e le resistenze dei medici, il NHS partì nel 1948 e i risultati straordinari che ottenne, affiancati al desiderio di equità e di giustizia sociale che emergevano dopo il conflitto mondiale, indussero altri governi ad adottarlo. Cominciarono i governi socialdemocratici dei paesi scandinavi e, nel 1978, si aggiunse al gruppo il primo paese dell’Europa del Sud, l’Italia appunto.
In realtà, di un sistema siffatto si era cominciato a parlare anche da noi già nel 1948. La «più bella Costituzione del mondo» è ancora l’unica a considerare il diritto alla tutela della salute, nel suo articolo 32, come un diritto umano fondamentale, sia a livello individuale che collettivo. Così recita, infatti, il primo comma dell’articolo: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Ci sarebbero voluti trent’anni (e la tragedia del terrorismo, come a breve diremo) per favorirne l’effettivo avvio.
Nel frattempo il nostro sistema prevedeva cittadini di serie A, quelli coperti da una «mutua» assicurativa, i quali potevano godere di cure da questa rimborsate, e cittadini di serie B, che pagavano le prestazioni di tasca propria o, in caso di incapienza, venivano inseriti in liste di «poveri» da assistere caritatevolmente.
Tutto cambiò il 16 marzo 1978, quando venne rapito Aldo Moro, segretario del più importante partito politico dell’epoca, la Democrazia cristiana. La sua uccisione, ad opera del gruppo terroristico delle Brigate Rosse, indurrà la formazione di un governo di unità nazionale che prenderà misure urgenti e varerà, con una rapidità inconcepibile per la politica italiana in tempi ordinari, tre leggi sanitarie che cambieranno la vita di milioni di persone.
La prima, n. 180, per la riforma dell’assistenza psichiatrica; la seconda, n. 194, per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza; la terza, n. 833, per l’istituzione del Servizio sanitario nazionale.
Da quel momento l’Italia si proiettava tra le nazioni più avanzate del pianeta per i livelli di assistenza erogati alla propria popolazione.
3. Tutti i paesi ricchi allineati,
tranne gli USA fino a Obama
Dagli anni Ottanta in poi, tutti i paesi sviluppati del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d’America, hanno adottato in sanità o un modello «bismarckiano» (assicurativo sociale) o uno «beveridgiano» (servizio sanitario nazionale).
In Europa, dopo i paesi scandinavi, sono stati quelli dell’Europa meridionale – Italia, Spagna e Portogallo in primis, seguiti dalla Grecia – a istituire servizi sanitari nazionali, mentre i paesi dell’Europa orientale, man mano che si liberavano del giogo sovietico, preferivano abbracciare un modello assicurativo sociale. In ogni caso, oggi 500 milioni di cittadini dell’Unione Europea hanno, in un modo o in un altro, una copertura sanitaria universale.
Negli altri continenti, paesi sviluppati come il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, garantivano la stessa tipologia di copertura mentre quelli più poveri, soprattutto in Africa e in Asia, dipendevano – e in larga misura dipendono ancora – da donazioni internazionali con enormi livelli di inefficienza e inequità.
L’unica eccezione tra i paesi ricchi era rappresentata dagli Stati Uniti, fino all’approvazione, nel 2010, dell’Affordable Care Act, il cosiddetto «Obamacare».
La cultura della frontiera, il liberismo esasperato e fortissimi interessi commerciali avevano prodotto in quel paese un sistema stile «selvaggio West», dove la salute e la malattia venivano considerate una responsabilità totalmente individuale e la sanità un bene di consumo, da erogare tramite assicurazioni puramente commerciali, costosissime e pertanto nella disponibilità solo di coloro che potevano permettersele.
Rimanevano così in balia della sorte decine di milioni di persone per le quali ammalarsi poteva significare impoverirsi drammaticamente o, semplicemente, morire per l’impossibilità di curarsi.
La riforma Obama ha attenuato, ma non risolto, i problemi strutturali di tale sistema e, benché abbia certamente garantito la copertura assicurativa a oltre 30 milioni di cittadini che prima non l’avevano, continua a presentare livelli di inefficienza e di inequità senza paragoni nel resto del mondo. Nella capitale degli Stati Uniti, ad esempio, convivono indicatori da Primo mondo in alcuni quartieri ricchi e performance ‘africane’ a poche fermate di autobus di distanza per le persone più povere. Il tutto a fronte di una spesa sanitaria ‘mostruosa’, pari ormai a quasi il 20% del PIL nazionale.
Ma è quello che potrebbe succedere anche in Europa, e persino da noi, se non ci attrezziamo in tempo.
I primi segnali preoccupanti già si intravedono.