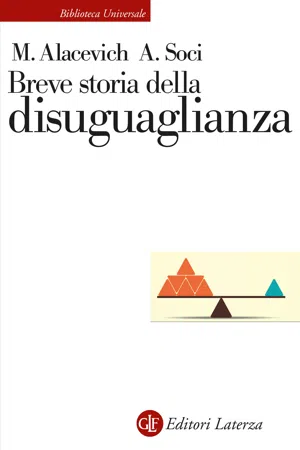1.
Perché dobbiamo discutere
di disuguaglianza
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha.
Matteo 25:29
La disuguaglianza non è un fenomeno nuovo. Essa ha accompagnato la civiltà almeno da quando le società umane hanno sviluppato l’agricoltura sedentaria, tra gli 11.000 e gli 8.000 anni fa. La ricerca antropologica ha infatti dimostrato che, se nelle società di cacciatori-raccoglitori la natura delle relazioni sociali ed economiche era sostanzialmente egualitaria, dopo l’invenzione dell’agricoltura la perdita delle abitudini nomadi e il carattere sempre più sedentario dei gruppi umani hanno comportato la crescita e l’evoluzione di strutture sociali sempre più complesse. È stato un processo che, a sua volta, ha prodotto stratificazione sociale, reti di rapporti clientelari ed élites dominanti capaci di esercitare liberamente la violenza per i propri fini1: stratificazione sociale e reti di rapporti clientelari. Come ha scritto il premio Nobel Angus Deaton, «la disuguaglianza è uno dei doni della civiltà»2.
Ciò che non ha precedenti, invece, è la centralità della disuguaglianza nel dibattito pubblico contemporaneo. Come sosteniamo in questo libro, la questione della disuguaglianza ha assunto un carattere più marcato con il progredire della globalizzazione e in molte società moderne contribuisce in maniera cruciale alla crisi del patto sociale e dei processi politici.
1. La disuguaglianza è un falso problema?
Molti politici, in alcuni casi per ragioni chiaramente opportunistiche, sostengono che la questione della disuguaglianza dovrebbe essere rimossa dall’agenda politica e accademica. Ad esempio, il candidato repubblicano alla presidenza americana del 2012, il miliardario Mitt Romney, sosteneva che parlare di disuguaglianza denotasse un approccio «basato sull’invidia» e che fosse quindi da tenere fuori dal dibattito pubblico3. Più in generale, molti hanno condiviso il timore che aggredire la disuguaglianza potesse mettere in pericolo l’ordine precostituito. Persino studiosi di chiara fama hanno suggerito che un certo grado di disuguaglianza vada accettato al fine di preservare la salute politica ed economica di una società: William Nozick è un esempio tra i più significativi, ma già agli inizi del XIX secolo Alexis de Tocqueville aveva sostanzialmente le stesse posizioni. Altri, infine, sostengono che il vero problema non sia la disuguaglianza ma la povertà, e che la risposta più adeguata passi per la diffusione globale della crescita economica.
Deirdre McCloskey, per esempio, ha affermato che la disuguaglianza è un falso problema e che «la condizione assoluta dei poveri è di gran lunga migliorata più per il Grande Arricchimento che per [la] redistribuzione delle risorse» (con l’espressione «Grande Arricchimento» l’autrice intende la Rivoluzione industriale e i suoi effetti sul benessere degli individui4). McCloskey sostiene che un grafico del reddito medio pro capite dall’età dei cacciatori-raccoglitori a oggi avrebbe la forma di una mazza da hockey su ghiaccio, orizzontale per decine di migliaia di anni, con un aumento improvviso dopo il 1800, in corrispondenza della Rivoluzione industriale e della conseguente crescita economica. La disuguaglianza, in questo scenario, è per McCloskey un falso problema: «Quale quota [di reddito o ricchezza] vada al 10% più povero della popolazione è una questione che non ha nulla a che fare con [...] lo scopo di elevare i poveri a una condizione di dignità»5.
L’economista della Columbia University Jagdish Bhagwati ha definito gli studi sulla disuguaglianza «ridicoli», una sequela di «dati irrilevanti» e in conclusione «una follia»6. Il filosofo Harry Frankfurt una volta ha descritto la questione morale dell’uguaglianza economica come «aridamente formale», «feticistica» e «alienante». Ha aggiunto, tuttavia, che sebbene l’uguaglianza economica non abbia una reale rilevanza morale, spesso sussistono buone ragioni pratiche affinché i governi si preoccupino dei problemi legati alla distribuzione delle risorse, poiché le politiche sociali egualitarie sono importanti per soddisfare bisogni fondamentali come nutrizione e salute7.
L’elenco delle argomentazioni che non valutano la disuguaglianza come un vero problema potrebbe essere facilmente esteso. Mentre non è necessario procedere con un’analisi puntuale di tutte le diverse tesi, è più interessante notare come esse si adattino ai tipici strumenti retorici del pensiero reazionario. Uno di questi è l’idea che la disuguaglianza economica, lungi dall’essere il lato negativo, infausto e deprecabile di una struttura sociale ed economica imperfetta, favorisca in realtà lo sviluppo economico complessivo. Limitare la disuguaglianza, quindi, ucciderebbe la crescita. Albert O. Hirschman ha definito questa posizione la «tesi della messa a repentaglio»; il costo della riduzione della disuguaglianza, infatti, metterebbe in pericolo un risultato molto più prezioso, in questo caso la crescita economica, che alla fine giova sia ai ricchi che ai poveri o, come afferma una massima ben conosciuta, solleva tutte le barche allo stesso tempo. L’evidenza storica, però, mostra ben altro: i trent’anni di crescita economica seguiti alla fine della seconda guerra mondiale sono stati anni di limitata disuguaglianza, almeno nelle economie avanzate. Gli ultimi decenni di crescita anemica, al contrario, hanno registrato un drammatico aumento della disuguaglianza8.
Esiste un’altra tesi per cui combattere la disuguaglianza distorcerebbe certi meccanismi tipici delle società moderne che si basano sul libero dispiegarsi del talento e delle preferenze individuali, e che sono alla base della mobilità sociale. Limitare la disuguaglianza si rivelerebbe un ostacolo al miglioramento della propria posizione, perpetuando e anzi peggiorando la disuguaglianza già presente nella società. Si tratta di una versione di ciò che Hirschman chiama la «tesi della perversità», secondo cui qualsiasi azione volta a migliorare l’ordine sociale ed economico finisce per peggiorare la situazione iniziale. In realtà, disuguaglianza e mobilità sociale non vanno insieme, anzi: negli ultimi decenni la disuguaglianza è aumentata e la mobilità sociale si è quasi del tutto arrestata.
Infine, si affaccia spesso l’idea che la disuguaglianza non conti, e se anche fosse importante, non si potrebbe fare nulla al riguardo. Si tratta di un esempio perfetto di ciò che Hirschman ha chiamato la «tesi della futilità», ovvero l’idea che ogni sforzo per correggere lo stato attuale delle cose sia condannato a fallire, e dunque non abbia senso tentare. Un’altra versione di questa tesi è quella per cui altre siano le questioni davvero essenziali da affrontare, come la povertà e l’istruzione, ma non la disuguaglianza. Questa versione della tesi della futilità riflette la visione di una società composta da segmenti non correlati e reciprocamente indipendenti; tale schematizzazione è palesemente falsa: sebbene la disuguaglianza strutturale non sia un problema facile da affrontare, la storia fornisce molti esempi di politiche che sono riuscite a porle un freno9.
2. Disuguaglianza e povertà
Prima della recessione mondiale del 2008-2009, i programmi di ricerca, sia sui paesi sviluppati sia su quelli meno sviluppati, mostravano con chiarezza la scelta di concentrarsi sulla povertà e ignorare la disuguaglianza. Questa predilezione unilaterale era probabilmente il prodotto delle diverse implicazioni politiche che i due concetti portano con sé. Se la povertà può essere affrontata in maniera non antagonistica, la disuguaglianza scatenerà sempre, prima o poi, un dibattito sulla struttura del potere e sulle disparità sociali in una determinata società. Come ricorda Branko Milanovic in Chi ha e chi non ha, il capo di un prestigioso centro di ricerca americano una volta gli disse che «il consiglio d’amministrazione del centro molto difficilmente accetterebbe di finanziare una ricerca che avesse “disuguaglianza di reddito o di ricchezza” nel titolo», mentre un progetto che includesse la parola «povertà» riscuoterebbe un pieno consenso10.
Allo stesso modo, la Banca Mondiale, la principale organizzazione internazionale di aiuto allo sviluppo, è rimasta sorprendentemente indifferente dinanzi al problema della disuguaglianza, e non per mancanza di consapevolezza11, visto che ha riconosciuto la questione più di quarant’anni fa: quando il suo quinto presidente, Robert S. McNamara (1968-1981), ne riformulò l’agenda, vi fece infatti esplicito riferimento. Come sostenne in un discorso del 1973, «Se guardiamo oggettivamente al mondo di oggi, dobbiamo convenire che è caratterizzato da un tasso elevato di disuguaglianza. La differenza negli standard di vita tra le nazioni ricche e le nazioni povere è di proporzioni gigantesche. [...] Inoltre, dobbiamo riconoscere che esiste un alto grado di disuguaglianza non solo tra nazioni avanzate e in via di sviluppo ma anche all’interno delle stesse nazioni in via di sviluppo»12. Eppure, quando si passava alle proposte politiche, la disuguaglianza spariva dagli obiettivi da affrontare, e il suo posto era occupato da progetti contro la povertà, politicamente più appetibili. Benché non necessariamente, è chiaro che povertà e disuguaglianza siano spesso correlate. Il riorientamento delle strategie di sviluppo della Banca Mondiale di McNamara verso le aree rurali in cui viveva la maggioranza della popolazione povera, dunque, aggrediva principalmente la povertà assoluta, ma contribuiva anche a correggere distribuzioni del reddito eccessivamente distorte...