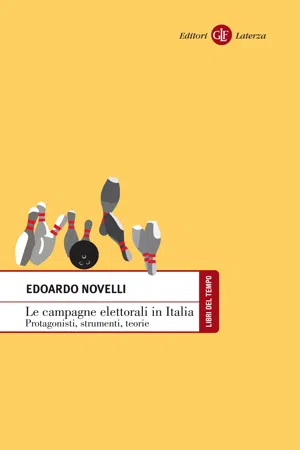
eBook - ePub
Le campagne elettorali in Italia
Protagonisti, strumenti, teorie
Edoardo Novelli
This is a test
- 208 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Le campagne elettorali in Italia
Protagonisti, strumenti, teorie
Edoardo Novelli
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Le campagne elettorali sono una festa e una battaglia, una celebrazione e una competizione, un momento sacro e un rito pagano, terreno d'azione di folle e singoli leader, condotte da eserciti di volontari e ristretti staff di professionisti. Momento centrale delle moderne democrazie, nel corso degli anni si sono trasformate. Pubblicitari, sondaggisti, esperti di marketing, hanno sostituito militanti, partiti e candidati; tecniche di campaigning e spot, strategie di media management e storytelling, la rete e i social network hanno preso il posto di manifesti, comizi, volantini. Il libro ripercorre le caratteristiche e l'evoluzione delle campagne elettorali in Italia dalla nascita della Repubblica a oggi.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Le campagne elettorali in Italia an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Le campagne elettorali in Italia by Edoardo Novelli in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economics & Economic Policy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1.
All’alba della Repubblica: 1946-1960
Le campagne elettorali del secondo dopoguerra rappresentano dei veri e propri laboratori per la messa a punto e la sperimentazione delle pratiche, degli strumenti e dei linguaggi della propaganda elettorale: una sorta di prototipi ai quali i partiti continueranno a rifarsi e ad attingere per molto tempo. È in questi anni che, con il ritorno alla democrazia e alla libera competizione politica, si svolgono le prime campagne elettorali di massa. Il salto rispetto al passato è evidente tanto nelle forme quanto, soprattutto, nei numeri. Il concetto stesso di campagna elettorale acquisisce una ben precisa identità pratica e teorica, distinguendosi nelle forme e nei contenuti dal resto della comunicazione politica. Nel 1946, in occasione delle prime elezioni amministrative del dopoguerra e del doppio appuntamento elettorale per le elezioni dell’Assemblea Costituente e il referendum istituzionale del 2 giugno, come fare una campagna elettorale deve di fatto essere reinventato dai partiti. Alla fine degli anni Cinquanta le pratiche e le forme di una campagna elettorale sono oramai chiaramente definite e si può parlare di una cultura comune della competizione elettorale.
Nonostante vent’anni di sospensione di ogni forma di reale competizione elettorale imposta dal fascismo e lo sviluppo tecnologico intercorso nel frattempo, sarebbe però sbagliato considerare questa fase come l’anno zero delle campagne elettorali in Italia. Oltre alle novità e ai cambiamenti nelle forme della propaganda politica, vengono infatti ripresi e utilizzati anche strumenti, linguaggi e tecniche già sperimentati dai partiti in occasione delle campagne elettorali di inizio secolo o, in maniera totalitaria, durante il regime (Noiret 2002; Fimiani 2002; Mana 2004).
Visti in una prospettiva di lungo periodo, i primi quindici anni della Repubblica appaiono caratterizzati da una sostanziale omogeneità nelle forme e nei contenuti della propaganda (Ventrone 1996), da una continua riproposizione e attualizzazione di quanto messo a punto in occasione delle elezioni del 1946 e del 1948. Ad un’analisi più ravvicinata e comparativa è però già possibile cogliere linee evolutive e l’avvio di processi di trasformazione e modernizzazione della comunicazione dei partiti. In particolare: «un graduale ma ben marcato trapasso dal tipo di propaganda emotiva ed ideologica dei primissimi anni del dopoguerra ad una più sobria e riflessiva» (Visentini 1963: 280); l’elaborazione di diversi linguaggi grafici e repertori visivi; la ricerca di nuove forme e canali di contatto con gli elettori; l’affermarsi della campagna elettorale quale momento a sé stante e ben distinto, anche comunicativamente, dalla normale attività politica dei partiti; e anche l’avvicinamento ai formati della pubblicità commerciale e i primi contatti con professionisti della comunicazione.
Le campagne elettorali italiane di questa prima fase sono caratterizzate dalla centralità dei partiti e dall’attivismo dei militanti. I partiti – includendo in essi i dirigenti, i funzionari, i candidati – sono gli ideatori, gli organizzatori e i realizzatori della campagna elettorale; i militanti e i simpatizzanti ne sono gli esecutori materiali. In presenza di un sistema dell’informazione ancora poco sviluppato e, di conseguenza, di un’arena pubblica estremamente ristretta e frammentata, lo svolgimento delle campagne elettorali dipende totalmente da loro. Le prime campagne elettorali del dopoguerra sono così campagne labour intensive (Farrell 1996), basate cioè sulla grande quantità di energie e di tempo messa a disposizione da questi due soggetti.
Il modello organizzativo dei principali partiti italiani è quello del partito a integrazione di massa (Duverger 1951; Panebianco 1982). Si tratta di un’organizzazione centralizzata, radicata in maniera capillare sul territorio, strutturata gerarchicamente in maniera verticistica, dagli apparati dirigenti nazionali sino alla base periferica, fortemente burocratizzata, che sopravvive grazie all’attività di leader e funzionari stipendiati che operano a tempo pieno e di migliaia di militanti e volontari che dedicano alla causa tutte le loro energie. Una efficiente macchina propagandistica ed elettorale, intorno alla quale gravita inoltre una fitta rete di organizzazioni strettamente interrelate – dall’associazionismo sindacale a quello giovanile e femminile, dal campo culturale a quello sportivo – che promuovono una partecipazione e un’appartenenza diffuse, contribuendo attivamente a delineare diverse subculture politiche.
Pur in presenza di notevoli differenze fra i partiti, dovute alle diverse storie e culture politiche, e di cicli di forte crescita alternati ad altri di stasi – esaminati in dettaglio nel corso del capitolo – tratto generale dei primi quindici anni di vita repubblicana è dunque l’ampliarsi della macchina organizzativa dei partiti, del numero degli iscritti e della loro base di militanti e attivisti.
I grandi partiti gestiscono la propria comunicazione e propaganda elettorale in maniera totale, dall’ideazione sino alla diffusione, passando per la fase realizzativa e produttiva. All’interno degli organismi nazionali e locali deputati alla comunicazione e alla propaganda sorgono centri e uffici che si occupano della realizzazione dei materiali delle campagne elettorali, mentre l’ideazione, cioè la scelta dei temi e degli slogan, rimane appannaggio dei vertici politici. I partiti che non raggiungono un tale grado di efficienza e organizzazione si affidano invece a soggetti esterni, anticipando un po’ i tempi a venire. Si tratta comunque di eccezioni, all’interno di una fase nel complesso caratterizzata da partiti in grado di gestire le campagne elettorali in maniera autarchica.
Una delle principali conquiste del ritorno alla democrazia è rappresentata dall’estensione nel 1946 del suffragio universale con il voto alle donne. Tradotto in numeri significa il passaggio dai 12 milioni di elettori attivi e 7.600.000 votanti delle ultime elezioni politiche del 1924, ai 28 milioni di elettori attivi e 24.900.000 votanti alle elezioni per l’Assemblea Costituente del 1946. Si tratta di una novità non priva di incognite per i principali protagonisti della vita politica e delle campagne elettorali. Come scrive pochi mesi prima del 2 giugno Attilio Piccioni, uno dei fondatori della Dc e futuro membro dell’Assemblea Costituente, «il comportamento della massa elettorale costituisce veramente un interrogativo misterioso. Prima di tutto per le proporzioni ingigantite dalla massa stessa; poi per il fatto che la più grande parte di essa – uomini e donne – è letteralmente digiuna di esperienza elettorale, poi ancora per il nuovissimo intervento della ingente massa femminile, ed infine per il problematico equilibrio dell’ordine pubblico»1.
Nel momento in cui la partecipazione alla vita politica diventa un fenomeno di massa, anche le forme della propaganda devono utilizzare mezzi, linguaggi, immagini propri di una nascente società di massa. Un ruolo importante nel processo di messa a punto e innovazione delle forme e dei codici della propaganda politica era stato svolto dal fascismo – si pensi in particolare ai manifesti, alla radio, alle grandi manifestazioni di piazza, al cinema, al linguaggio. Si tratta però di forme troppo compromesse con la stagione totalitaria, che non possono essere direttamente trasposte nelle campagne elettorali dell’Italia democratica. Se i mezzi e gli strumenti utilizzati dal regime possono tornare utili, almeno i linguaggi e gli stili devono essere innovati. Inoltre, come i partiti sperimentano in prima persona, una cosa è fare propaganda all’interno di una realtà totalitaria, altra cosa è farlo in una scena popolata da più protagonisti in competizione fra loro.
Le prime campagne elettorali accelerano dunque, da un lato, il recupero degli strumenti e delle forme tradizionali e la riflessione su come adeguarli al nuovo scenario democratico; dall’altro, l’interesse verso le forme di propaganda più innovative e, nelle speranze, più efficaci. Le campagne elettorali sono comunque ancora saldamente incentrate sulla forza persuasiva della parola. E tali rimarranno per molti anni. Parola orale nel caso dei comizi, scritta nel caso dei manifesti. Sono questi i due principali strumenti, in termini di diffusione e numeri, utilizzati nelle campagne elettorali di questa prima fase.
Il comizio costituisce la forma di propaganda per eccellenza ed è praticato in molte forme e variabili. Una di queste, diffusa in occasione delle prime campagne elettorali del dopoguerra, riconosciuta anche dalle autorità (Ventrone 2004), prevede che al discorso dell’oratore seguano domande o veri e propri contraddittori con persone del pubblico. In qualche caso si tratta di interventi spontanei, in altri di interruzioni da parte di disturbatori appositamente organizzati dai partiti. Inoltre, nei primissimi anni del secondo dopoguerra sono molti gli elettori che vanno a sentire gli oratori di più partiti per informarsi su tutte le opinioni. Con il progressivo ritorno alla normalità democratica e il succedersi delle campagne elettorali, si verificano alcuni cambiamenti nell’uso e nella struttura del comizio, che diventa una manifestazione alla quale partecipano esclusivamente i simpatizzanti e i militanti del partito. A questo si aggiunge che, anche al fine di evitare incidenti, si abbandona la formula del confronto pubblico di ottocentesca memoria. Un insieme di fattori che determinano la perdita di attrattività del discorso pubblico e la sua progressiva ritirata dalla piazza per spostarsi in luoghi chiusi quali teatri e cinema, cosicché alla fine degli anni Cinquanta già si parla di una sua crisi.
L’altro principale strumento delle campagne elettorali di questa prima fase sono i manifesti. Mentre il comizio rappresenta la temporanea conquista sonora degli spazi pubblici, i manifesti costituiscono una forma di occupazione ben più longeva, che modifica l’arredo urbano e ridefinisce con i propri colori e simboli l’aspetto delle città. In occasione delle prime campagne elettorali i manifesti sono prevalentemente scritti, mostrano stili grafici diversi, collegati a varie tradizioni visive e differenti concezioni di propaganda. Negli anni si evidenzia la ricerca di linguaggi e stili originali, una maggiore cura nel segno grafico, l’attenzione ai modelli propri della pubblicità commerciale e l’avvio di una riflessione sulle caratteristiche e finalità della comunicazione pubblica. E anche i primi tentativi di identità visiva e immagine coordinata. La differenza fra i manifesti testuali prodotti in occasione della doppia campagna elettorale del 1946 e le campagne plurisoggetto d’ispirazione pubblicitaria delle elezioni politiche del 1958 è, da questo punto di vista, estremamente eloquente.
Tutti processi che andranno meglio sviluppandosi nelle fasi successive.
La stampa segue e documenta con interesse lo svolgimento del dibattito elettorale e delle campagne elettorali che, soprattutto all’inizio, rappresentano una grossa novità. Nell’immediato dopoguerra il numero di quotidiani cresce esponenzialmente, arrivando a 146 (Castronovo, Tranfaglia 1980), per poi ridursi man mano che il sistema dell’informazione trova nuovi assetti e nuove proprietà che portano la gran parte dei giornali indipendenti a schierarsi su posizioni filogovernative. L’influenza della stampa è però fortemente condizionata dal basso indice di lettura dei quotidiani. Inoltre diffuso è il fenomeno della stampa di partito che, sebbene vada ridimensionandosi – ad eccezione dell’«Unità» –, assorbe parte dei lettori. Nel corso ...