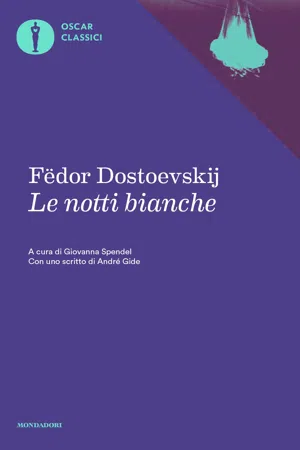Nel numero di novembre della rivista «Annali patrii» (Otečestvennye zapiski) dell’anno 1848 Fëdor M. Dostoevskij, all’età di ventisette anni, pubblicò uno dei racconti tra i più riusciti del periodo giovanile: Le notti bianche, dal doppio sottotitolo «Romanzo sentimentale. Dai ricordi di un sognatore», che dedicò a A. Pleščeev, «al primo poeta degli anni Quaranta», il compagno dei circoli semiclandestini di impronta utopico-socialista. Non si può escludere che l’autore abbia visto in A. Pleščeev uno dei prototipi per il protagonista del suo racconto; infatti Dostoevskij aveva scritto il racconto in un periodo di una loro stretta amicizia ed assidua frequentazione dei circoli A. e N. Beketov, M. Petraševskij e S. Durov.1
Successivamente, nel 1859, ormai tornato dal suo quasi decennale esilio in Siberia, durante il breve soggiorno a Tver’ apportò alcune correzioni al racconto, come del resto corresse tutte le opere scritte prima dell’esilio: cancellò significativamente la frase che un condannato di fronte all’esecuzione, anche se ha un cuore di pietra, sente pentimento e rimpianto. Certamente le esperienze vissute sulla piazza Semënovskaja (Dostoevskij con gli altri membri del circolo Petraševskij era stato portato in piazza per l’esecuzione e solo nell’ultimo istante la pena di morte fu commutata in deportazione) gli avevano insegnato qualcosa. Fu aggiunto invece il brano che indica i personaggi storici e letterari tanto amati dal «sognatore» de Le notti bianche e tolta la dedica ad A. Pleščeev. Con tali correzioni la versione del 1859 venne anche in seguito considerata come definitiva; comunque questi cambiamenti e ritocchi non sono così essenziali da poter parlare di due opere completamente diverse come è avvenuto per Il sosia (Dvojnik).
Ne Le notti bianche è intrecciato come un filo di Arianna il tema del sognatore con il quale Dostoevskij ha un rapporto estremamente personale: negli anni Sessanta F. Dostoevskij confessa che anch’egli apparteneva a tale categoria. Nelle lettere del periodo giovanile più di una volta troviamo delle lamentele di Fëdor Michajlovič per la sua solitudine, sempre sorella del sognatore, accanto al desiderio inappagato di trasformare la propria vita in un’opera d’arte, proprio la stessa aspirazione che aveva nutrito anche il protagonista del racconto.2
Un anno prima della pubblicazione de Le notti bianche, al tema del sognatore fu dedicato il quarto e ultimo feuilleton su Pietroburgo che F. Dostoevskij pubblicò il 15 giugno 1847 (gli altri tre furono pubblicati il 27 aprile, l’11 maggio, il 1º giugno) sulle pagine del giornale «Notizie di Sanktpietroburgo» («Sanktpeterburgskie Vedemosti», organo dell’Accademia Imperiale delle Scienze). F. Dostoevskij accettò questo incarico, avuto per intercessione di V. Sollogub, l’autore dell’allora celebre romanzo Tarantas, probabilmente per migliorare un po’ le sue finanze molto compromesse dai debiti suoi e del fratello Michail. F. Dostoevskij sostituì un giornalista e pubblicista assai noto in quegli anni, E.I. Guber, che era morto proprio verso metà aprile dello stesso anno.3 Il nucleo centrale dei quattro feuilleton è centrato su Pietroburgo, le cui immagini si alternano tra due poli, quello della realtà e quello del sogno, quello della cronaca e quello della fantasmagoria, due facce che rivelano la doppia Pietroburgo. Quest’ampia confessione su Pietroburgo, del resto molto personale, diventa l’asse portante del racconto sentimentale di un sognatore durante le notti bianche. Nel terzo feuilleton Fëdor Michajlovič scrive: «Tutti si osservano e si saggiano a vicenda con occhi curiosi. Ne viene fuori una sorta di confessione generale. La gente si racconta, si descrive minuziosamente, si analizza davanti al mondo intero, spesso con dolore e sofferenza».4 Proprio un monologo così sincero e leggermente ironico darà ritmo a Le notti bianche, il cui protagonista è stato modellato sull’esempio dei sognatori degli anni Quaranta; Dostoevskij ne dà un’ampia descrizione nell’ultimo feuilleton, descrizione che sarebbe in gran parte coincisa con la presentazione del sognatore nel racconto: «Talvolta, in caratteri assetati di attività, assetati di vita immediata, di realtà, ma deboli, femminei, delicati, nasce pian piano quella che si chiama tendenza alla fantasticheria, e l’uomo finisce col diventare non più un uomo, bensì uno strano essere di genere neutro – il sognatore… Sono cupi e taciturni con il loro prossimo, sprofondati in se stessi, ma amano tutto ciò che è lento, leggero, contemplativo… Amano leggere, leggere ogni sorta di libri, anche seri, specialistici, ma, di solito, dopo la seconda o terza pagina, abbandonano la lettura, perché già pienamente soddisfatti. La loro fantasia, mobile, leggiadra e volatile, è già risvegliata, l’impressione è già scattata…».5
L’eroe nel racconto Le notti bianche narra personalmente la sua avventura: è sempre il sognatore dei feuilleton, ma assai più studiato e approfondito, mentre certe descrizioni di Pietroburgo all’inizio dell’estate sono letteralmente riprese dai feuilleton stessi.6
In uno studio dedicato a Dostoevskij e ai suoi personaggi sdoppiati il critico G. Gesemann considera il personaggio maschile de Le notti bianche un mascherato e scisso individualista;7 il sognatore pietroburghese, come del resto altri personaggi di Dostoevskij quali Ordynov, giovane studente protagonista de La padrona (Chozjajka, 1847), ed il giovane del Cuore debole (Slaboe serdce, 1848) sono, secondo il critico, cugini di primo grado, per la loro natura demoniaca, di German della Dama di picche di A. Puškin. Ognuno di questi personaggi è una variante di un German immerso in un universo di illusioni che distruggono la sua volontà e con essa indeboliscono il suo individualismo demoniaco. Più convincente, anche se più restrittiva, ci appare l’analisi di V. Kirpotin, che nei racconti del giovane Dostoevskij (come La padrona, Le notti bianche) e nel romanzo incompiuto Netočka Nezvanova riconosce un atteggiamento critico dell’autore nei confronti del «sognatore romantico». Nel quarto feuilleton, afferma Kirpotin, Dostoevskij definì il sognatore romantico come un fenomeno di indifferenza sociale nei confronti del progresso e della trasformazione della vita sociale; di conseguenza le sue opere sul sognatore vanno intese come un’interpretazione artistica della tesi racchiusa nel feuilleton.8
Ma non vi è alcun dubbio che i feuilleton, come del resto i racconti, racchiudono una problematica assai più ampia e più profonda. Nel racconto La padrona il protagonista è immerso in un mondo ai margini tra la realtà e il sogno, è soprattutto un artista della scienza di impronta hoffmanniana, mentre ne Le notti bianche ci imbattiamo in un «giovane schilleriano», ci aggiriamo in un labirinto di «escapismo» estetico, estremamente vitale nella cultura russa degli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, alla base del quale stava la teoria di Schiller sull’educazione estetica dell’uomo. Le cause che portarono alla popolarità e all’esaltazione di Schiller come poeta e ideologo nella «fortezza del dispotismo» (così la giovane intelligencija aveva definito la Russia di allora, in particolare dopo la sconfitta della rivolta decabrista del 1825) sono abbastanza chiare ed evidenti.9 Dopo ogni ondata di repressione da parte del potere, l’attività sociale assumeva un carattere maggiormente astratto e l’ideologia della protesta e dell’ira si trasformava in una utopia estetica. Infatti l’ideale estetico dell’uomo è indubbiamente quello più astratto e staccato dalla vita reale. In una situazione sociale di questo tipo l’interesse per Schiller,10 in particolare per la sua idea della libertà e per l’interpretazione dell’«anima bella», diventa pienamente comprensibile; ma questo ideale estetico dell’«individuo libero» di Schiller, diventato tanto caro ad A. Herzen e N. Stankevič, non era poi così innocente… Non per niente, rimproverando nel 1848 A. Smirnova, Nicola I ebbe ad affermare: «Il vostro Schiller e Goethe hanno rovinato la gioventù e hanno preparato l’anarchia». Nicola I esagerava certamente, ma non di tanto… In quei tempi l’«escapismo» estetico era, nonostante tutto, un’espressione di una protesta inconciliabile ed in ogni circostanza favorevole avrebbe potuto trasformarsi in una ideologia dai concreti contenuti politici.
La stima e l’ammirazione per Schiller, anche sullo sfondo dell’entusiasmo generale, erano per Dostoevskij del tutto eccezionali: questa passione per l’autore de I fratelli masnadieri era incominciata nell’infanzia e, con pochi intervalli, durò fino alla morte di F. Dostoevskij. A dieci anni aveva visto la rappresentazione de I fratelli masnadieri e l’impressione di questo spettacolo l’accompagnò per vari decenni, al punto di non scordarsene mai nell’età adulta. Schiller, attraverso le traduzioni di V. Žukovskij, era entrato nell’elenco delle letture preferite dei fratelli Dostoevskij; è un fatto non ignorato dalla critica che F. Dostoevskij, con uno dei suoi compagni di scuola, Ivan Berežyckij, s’immergeva estasiato nella lettura di Schiller.11 Quando, durante gli studi all’Istituto di Ingegneria, suo fratello Michail gli rimprovera una scarsa conoscenza di Schiller, il futuro autore de Le notti bianche gli risponde così in una lettera del 1º gennaio del 1840: «Mi hai scritto, fratello, che non ho letto Schiller. Ti sbagli, fratello. L’ho imparato a memoria. Parlavo e sognavo, fratello, con le sue parole. Penso che il dono più grande del destino è stato di conoscere il grande poeta nella mia vita di quel momento. Non avrei mai potuto conoscerlo meglio se non allora».12
Il propugnatore dell’educazione estetica e del perfezionamento individuale dell’uomo, l’autore del Don Carlos, aveva sollevato un dubbio essenziale quando arrivò alla convinzione che il piano radicale del perfezionamento umano, proposto dai pensatori dell’Illuminismo, non avrebbe potuto essere mai realizzato: la Rivoluzione francese e la violenza collegata ad essa erano per Schiller una chiara dimostrazione che l’umanità non era ancora giunta alle grandi mete. Una educazione estetica che sviluppasse nell’individuo tutte le virtù donategli dalla natura avrebbe dovuto sviluppare ed accrescere in ognuno qualità tali che, trasmesse di generazione in generazione, avrebbero infine sollevato il livello morale dell’umanità intera e l’avrebbero preparata ad una serie di mete e di aspirazioni comuni a tutto il genere umano. Questa grandiosa utopia schilleriana aveva chiaramente un’impronta sociale. I comuni sforzi di tutta l’umanità avrebbero dovuto giungere al risultato di creare uno stato ideale dove si sarebbero riconciliati sia gli interessi individuali, dalla matrice egoista, sia le necessità generali della comunità. Questa armonia avrebbe potuto essere raggiunta solo grazie al «bello»: il ruolo dell’arte, dell’amore e dell’amicizia vengono considerati da Schiller in questo processo come essenziali. Fra i due tipi umani che nell’ideologia dell’autore de I fratelli masnadieri svolgono un ruolo di primaria importanza, la palma viene attribuita agli idealisti e non ai realisti. Il realista, secondo la concezione schilleriana, in ogni determinato avvenimento opera solo per cause esterne e solo per scopi esterni; sempre e dappertutto il suo punto di riferimento saranno le leggi della natura, l’aspetto concreto della realtà e quello definitivo del mondo. Un realista non oserebbe mai concedere all’uomo la libertà, in quanto essa è considerata da lui la fonte della vendetta e della disperazione, del male e dell’anarchia. Un realista conosce con estrema chiarezza i suoi limiti, ciò che può e ciò che non può, e i suoi pensieri non oltrepassano mai tale limite. L’idealista invece considera la sua volontà come fonte delle proprie aspirazioni e conoscenza, e come volere supremo la libertà del proprio io. Si tratta di un sognatore che grazie all’arditezza del suo spirito può realizzare l’utopia estetica di Schiller. Finché la società è organizzata in uno «stato etico di dovere» l’idealista è obbligato a portare la sua utopia estetica nell’intimo del proprio io. L’individuo può raggiungere la libertà non tanto nella sfera dell’azione politica e dell’attività sociale, quanto nello spazio ideale del bello. In tale dimora dell’ideale, nello spazio dello spirito, potrà entrare solo l’uomo che possiede un’«anima bella», «die schöne Seele». L’uomo contemporaneo può raggiungere la libertà solo nella dimensione dell’ideale, nell’ambito dell’arte, attribuendo ai valori culturali una importanza maggiore di quella che dà ai beni materiali.
Lo sfondo ideologico de Le notti bianche non è nient’altro che la trasposizione a livello artistico della polemica intorno all’«educazione estetica» schilleriana che l’intelligencija russa aveva sperimentato negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento. Gli ideologi della «riconciliazione con la realtà», il giovane V. Belinskij e M. Bakunin, appena agli inizi della loro attività pubblicistica, hanno assunto nei confronti di Schiller un atteggiamento decisamente di rifiuto, ma gli attacchi di Bakunin, quanto quelli di Belinskij, erano indirizzati piuttosto contro il giovane filosofo M. Stankevič, geniale diffusore della filosofia tedesca, che al tempo aveva un notevole influsso sulla letteratura russa. Per Stankevič il sogno e la fantasticheria erano simboli della superiorità dell’individuo sulla cupa realtà nella «fortezza del dispotismo»; egli tratta «il regno dell’ideale» come «la propria dimora», nella quale ci si rifugia quando non si può andare da nessun’altra parte. Stankevič si era affidato al sogno per salvaguardare la propria purezza morale; del resto si sentiva disgustato dagli attacchi nei confronti di Schiller, che adorava in quanto «poeta delle nebbie...