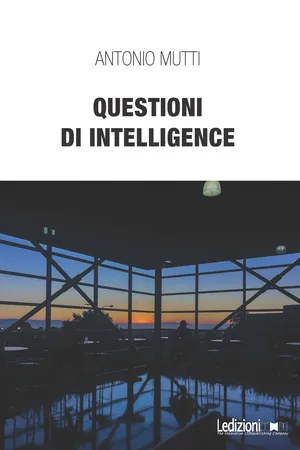![]()
I
Cosa si intende per intelligence
Il termine intelligence ha finito per soppiantare quello di spionaggio. Varie ragioni sono alla base di questo slittamento linguistico, ma due di esse mi sembra che pesino più di altre. La prima deriva dal fatto che sempre più l’attività di ricerca degli operatori di intelligence si trova a ragionare su fonti aperte che sono andate dilatandosi a dismisura con la rivoluzione informatica. L’attività di acquisizione e decrittazione di fonti segrete, che rientra più tipicamente nell’attività di spionaggio, continua a essere rilevante, e spesso cruciale, ma ha finito per essere inglobata in un’attività più vasta (definita appunto di intelligence) che include in misura crescente l’analisi delle fonti aperte.
La seconda ragione è che l’idea di spionaggio, non gode di buona reputazione. Lo spionaggio è pur sempre percepito come un’indebita sottrazione di informazioni a chi non intende concederle. Questo vale soprattutto nello spionaggio offensivo. Ma anche lo spionaggio difensivo risulta essere una pratica che si accetta a malincuore, e solo in casi eccezionali, quali la difesa di rilevanti interessi minacciati dal comportamento altrui o la tutela della sicurezza personale e collettiva.
Il termine intelligence enfatizza perciò le attività svolte su fonti aperte e minimizza o cala un velo di silenzio sulle attività di spionaggio vero e proprio che, in realtà, continuano a essere vive e vegete.
Detto questo, resta il fatto che le attività di raccolta e di interpretazione delle informazioni (aperte e chiuse) collezionate dalle agenzie di intelligence risultano coperte da aree di segretezza di varia ampiezza e durata temporale, giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Ciò, come abbiamo già evidenziato, non facilita l’attività di ricerca sull’azione di tali agenzie. Questa difficoltà di accesso alle fonti non ha impedito comunque lo sviluppo, soprattutto negli ultimi tre decenni e in ambito prevalentemente anglosassone, di un’attività di ricerca che studia le agenzie di intelligence come organizzazioni, evidenziandone caratteristiche e specificità rispetto ad altri sistemi organizzativi. Prima di entrare nel merito di queste specificità organizzative risulta però necessario introdurre una definizione di intelligence sufficientemente generale e, al contempo, operativa.
![]()
1. Un concetto di sicurezza che tende progressivamente a dilatarsi
Un noto manuale inglese definisce l’intelligence:
Un mezzo per un fine. Questo fine è la sicurezza, inclusa la prosperità, dell’attore che sollecita la raccolta e la successiva analisi delle informazioni di intelligence. Nel sistema internazionale contemporaneo, gli Stati sono i principali clienti dell’intelligence e gli organizzatori chiave delle agenzie che raccolgono e analizzano le informazioni. Tuttavia, un gamma di attori sub-statali, politici, commerciali e criminali percepiscono pure il bisogno di intelligence e di proteggersi dal furto dei loro segreti.
Si tratta, naturalmente, di una definizione molto generale vincolata al concetto di sicurezza preso in considerazione. Nella sua formulazione più restrittiva la sicurezza è implicata quando «in una disputa politica gli attori minacciano o impiegano la forza per ottenere ciò che essi vogliono l’uno dall’altro…, dove per forza si intende espressamente l’impiego della violenza o la minaccia del suo impiego». Nella sua accezione più estesa la sicurezza include, oltre alla difesa dalla violenza altrui, da attacchi militari o paramilitari, anche la protezione dalle minacce al benessere socio-economico e finanche politico-civile di un determinato attore. L’accezione più estesa è adottata da tempo nell’ambito delle Nazioni Unite e ciò ha sicuramente contribuito a far sì che le attività di intelligence abbiano teso a operare sempre più con una concezione allargata di sicurezza, sia nella sua forma difensiva (di tutela dagli attacchi altrui) che offensiva (volta a potenziare la propria sicurezza, anche a discapito di quella altrui).
Una simile estensione del concetto di sicurezza rende ovviamente più problematica l’elaborazione di schemi teorici coerenti, come quelli maturati negli studi strategici focalizzati prevalentemente sull’elemento militare, ma ha il vantaggio di permettere la fuoriuscita da un’ottica esclusivamente Stato-centrica, includendo anche il riferimento al singolo individuo e ai diritti universali che lo proteggono in quanto essere umano (human security). Un concetto esteso di sicurezza appare particolarmente utile, come vedremo più avanti, per far fronte alle sfide odierne delle migrazioni e del terrorismo internazionale, ma vale anche per gli attori sub-statali, politici ed economici che hanno bisogno di intelligence a fini difensivi e offensivi.
![]()
2. Raccolta delle informazioni, analisi e diffusione
Dunque, nella definizione di intelligence appena esposta il mezzo per conseguire la sicurezza è costituito da un processo informativo che viene generalmente definito «ciclo dell’intelligence». Esso include: 1) la pianificazione degli obiettivi informativi da raggiungere; 2) la raccolta dei dati; 3) l’elaborazione dei dati e la loro interpretazione; 4) la diffusione dei risultati ottenuti.
La pianificazione degli obiettivi informativi ha il compito di definire le priorità di raccolta e analisi delle informazioni relative alle specifiche minacce alla sicurezza individuate.
La raccolta dei dati avviene su fonti catalogate usualmente in quattro categorie. La prima categoria riguarda le fonti aperte (Open Source Intelligence o Osint) cioè a disposizione di tutti, quali giornali, documenti ufficiali, siti web, ecc. Le altre tre categorie di fonti sono invece caratterizzate da gradi variabili di segretezza. La seconda categoria riguarda, infatti, fonti «protette» (Protected Information o Protint), come quelle presenti nel dark e deep web o detenute dallo Stato e da organizzazioni private, relative a informazioni sui cittadini, anche sotto forma di big data. La terza categoria è relativa a informazioni segrete ottenute tramite fonti umane (Human Intelligence o Humint), costituite da informatori, agenti sotto copertura, o persone che forniscono informazioni nel corso di un interrogatorio. La quarta categoria, infine, fa riferimento ai mezzi tecnologici (Technical Intelligence o Techint) che permettono di raccogliere informazioni, con vari gradi di segretezza, attraverso intercettazioni di comunicazioni telefoniche, elettroniche e elettromagnetiche (Signals Intelligence o Sigint), attività fotografica anche satellitare (Imagery Intelligence o Imint) e attività di sensori vari, quali sonar, sismografi, metal detector (Measurement and Signature Intelligence o Masint).
L’elaborazione dei dati e la loro interpretazione implicano processi di validazione (quantitativa e qualitativa) delle informazioni ottenute e la loro collocazione in uno schema esplicativo adeguato. A questo riguardo, è bene sottolineare che l’attività di un analista di intelligence, non è dissimile da quella di ogni scienziato sociale con tutte le problematiche e i limiti cognitivi ed emotivi che essa comporta.
La diffusione (o disseminazione) dei risultati consiste nel loro trasferimento agli agenti, pubblici o privati, che hanno richiesto, direttamente o indirettamente, la ricerca agli apparati di intelligence.
Per evitare di concepire il ciclo dell’intelligence come costituito da fasi rigidamente separate tra loro e con l’ambiente esterno, è senz’altro preferibile sostituire il concetto di ciclo con quello di sistema o di reti dei relazioni interattive. Ragionare in termini di sistemi di intelligence costringe, infatti, a riflettere sui processi interattivi esistenti tra le varie fasi dell’attività di intelligence e tra queste e l’ambiente esterno.
Rispetto alla diatriba relativa all’opportunità o meno di includere nel sistema di intelligence le azioni sotto copertura, difensive o offensive, mi sembra opportuno includerle solo nel grado in cui esse sono volte a raccogliere informazioni utili all’attività di intelligence, come nel caso dell’agente infiltrato. Escluderei, perciò, le azioni di natura militare o paramilitare che rientrano nelle competenze di altri apparati di sicurezza.
![]()
3. La centralità del segreto
Si è già sottolineato che l’attività di un analista di intelligence non è molto dissimile da quella di un qualunque scienziato sociale nelle fasi di elaborazione e di interpretazione dei dati raccolti. Ci sono invece delle differenze riguardo alla raccolta di informazioni segrete realizzata dall’intelligence, in quanto quest’ultima, come abbiamo appena visto, può attingere a un’ampia gamma di strumenti, di cui alcuni risultano difficilmente disponibili per lo scienziato comune. È evidente, inoltre, che le attività di spionaggio si collocano spesso su un crinale sfumato, tra il lecito e l’illecito, che solleva acuti dilemmi morali soprattutto quando vengono violati diritti fondamentali che vanno ben oltre quelli relativi alla privacy (come, per esempio, nel caso di minacce, ricatti, interrogatori al limite della tortura, ecc.). Ci sono differenze anche per quanto concerne la diffusione dei risultati ottenuti. Nel caso dell’intelligence, la disseminazione dei risultati è soggetta a vari gradi di segretezza di natura decisamente più cogente di quanto può manifestarsi nell’ambito della ricerca scientifica pubblica e privata. Non a caso gli apparati di intelligence vengono tradizionalmente definiti «servizi segreti».
La centralità del segreto che permea questi apparati è collegata alla crucialità dei livelli di sicurezza da garantire. Per esempio, nel caso italiano, i gradi di segretezza sono «classificati», in ordine decrescente di rilevanza, nel modo seguente: «segretissimo», «segreto», «riservatissimo», «riservato». Più in generale, però, la segretezza che permea questi apparati solleva una serie di questioni che cercherò di affrontare nel corso del presente lavoro. Anzitutto si tratta di individuare quale equilibrio deve esistere tra trasparenza e segretezza nelle istituzioni dei sistemi democratici, con particolare riferimento agli apparati di intelligence, identificando anche le strutture di controllo atte a garantire questo equilibrio. In secondo luogo, risulta necessario individuare qual è il bilanciamento più adeguato tra la sicurezza dei cittadini e la tutela della loro privacy e, più in generale, delle loro libertà individuali. In terzo luogo, la segretezza presente nelle agenzie di intelligence deve essere intesa come risorsa ma anche come vincolo alla loro azione. Come si vedrà in riferimento al terrorismo internazionale e al governo dei processi migratori, tale risorsa può costituire un vantaggio informativo nei confronti di altre organizzazioni, ma anche un vincolo sul fronte della comunicazione e del coordinamento (locale, nazionale e internazionale) delle informazioni e delle interpretazioni a disposizione delle varie agenzie di intelligence. Infine, sia come risorsa, sia come vincolo, la segretezza finisce per solle...