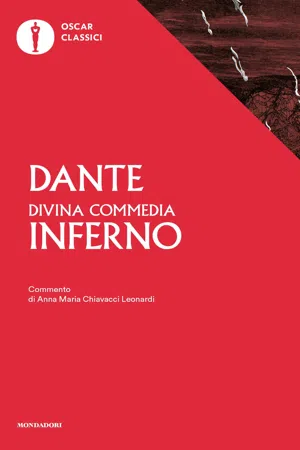1. Nel mezzo del cammin…: giunto alla metà del cammino della nostra vita umana. L’inizio del poema, in forma semplice e piana, è una indicazione di tempo. La visione dell’aldilà si presenta come un fatto storicamente datato che si svolge nel tempo. Dante indica infatti qui una data precisa, cioè i suoi trentacinque anni, considerati allora, «ne li perfettamente naturati», il punto medio della durata della vita (Conv. IV, XXIII 6-10); la Scrittura stessa – in accordo del resto alle teorie aristoteliche riprese da Alberto Magno e Tommaso – era all’origine di tale opinione («Dies annorum nostrorum… septuaginta anni» – Ps. 89, 10) e l’aggettivo nostra sembra discendere dal salmo al verso di Dante, dando a quel linguaggio dimesso e quotidiano una risonanza universale ed epica. L’idea della vita come cammino (che ha quindi un suo fine) riempie questo primo verso. È l’idea di partenza del poema. Essa è scritturale (2 Cor. 5, 6) e Tommaso la precisa nel suo commento: «Homo, in statu vitae istius constitutus, est quasi in quadam via, qua debet tendere ad patriam». Dante la riprende e la svolge in un passo del Convivio, dove si ritrova quasi una parte del primo verso del poema: «così l’anima nostra, incontanente che nel novo e non mai fatto cammino di questa vita entra…»; è questo il cammino verso il bene, che l’uomo «perde per errore come le strade de la terra» (Conv. IV, XII 15-8), proprio come è accaduto all’uomo della prima terzina del poema. La data di questo viaggio dell’anima è tuttavia storica, come dichiarano più luoghi lungo le cantiche che fissano la visione al 1300 (Dante era nato, come si sa, nel 1265) e precisamente al Venerdì santo di quell’anno (vedi sotto, nota integrativa). È questo del resto l’anno del grande giubileo indetto da Bonifacio VIII, certo non a caso scelto per il viaggio di conversione e salvezza. Che le prime parole del poema indichino dunque un tempo storico, appare indubbio. Ma tale tempo storico è fin dall’inizio proiettato sullo sfondo dell’eternità dal preciso ricordo biblico presente in questo primo verso: «Ego dixi: in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi» (Is. 38, 10). Le parole del profeta – che narra in quel capitolo l’intervento salvifico di Dio per strappare un uomo alla morte – stabiliscono la seconda dimensione del racconto: sono così già posti i due piani, terrestre e celeste, sui quali si svolgerà tutto il poema al quale ha posto mano, come Dante stesso dirà, e cielo e terra (Par. XXV 2).←
– nostra: con questo aggettivo il singolo personaggio Dante accomuna a sé tutta l’umanità. Scopo del poema infatti, come abbiamo ricordato nella Introduzione, è «removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis» (Ep. XIII 39). Così Dante assume in persona propria questo viaggio, che è di tutti gli uomini, dall’oscurità (la selva) alla luce, dal dolore alla felicità, e la sua vicenda personale, storicamente reale e databile, diventa segno dell’universale vicenda umana.←
– Il mezzo del cammin. È decisamente da rifiutare l’interpretazione, già di alcuni antichi, per cui il «mezzo del cammin» sarebbe il sonno, nel quale si passa metà della vita (cfr. Eth. Nic. I 13), inteso come figura di uno stato di visione, quale si ritrova anche nella Scrittura. Il testo infatti indica chiaramente il punto medio di un cammino, cioè di un percorso, nel quale si è smarrita la strada: e poco oltre (v. 11) si userà la metafora del sonno per indicare lo stato in cui il viandante era quando è entrato nella selva: mentre ora, che se ne accorge (mi ritrovai), è ben sveglio. Tale uso della metafora in senso opposto è ovviamente inammissibile. Ma l’interpretazione tradizionale è confermata (oltre che dal passo del Convivio citato sopra, in nota a Nel mezzo del cammin…) dai molti luoghi del poema che offrono una data, e che portano tutti, come si è detto, al 1300 (cfr. Inf. VI 67-9, X 79-81, XXI 112-4; Purg. II 98-9, XXIII 76-8; Par. XVII 80-1; ecc.): vedi soprattutto Inf. XXI 112-4, dove si precisano, oltre l’anno, anche il giorno e l’ora. Ultima conferma il passo citato di Is. 38, 10, riscontro che appare decisivo.←
2. mi ritrovai: mi ritrovai a essere, presi coscienza di trovarmi; «dice l’essersi lui accorto di trovarsi là entro…» (Tommaseo). Di qui lo sgomento e la paura. Quando c’era entrato infatti, e fino a quel momento, non ne aveva avuto coscienza (Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai: v. 10). Questo preciso momento, in cui l’uomo si accorge del suo smarrimento (v. 3), e se ne spaventa (v. 6), è appunto l’inizio della conversione, e segna l’inizio del poema.←
– per una selva oscura: per vale «per entro», mantenendo il senso latino di moto per luogo; indica quindi il camminare senza meta proprio di chi si è smarrito. La selva è l’immagine antica e immediatamente comprensibile del male e dell’errore, diffusa in tutta la letteratura cristiana, e come tale Dante stesso la usa nel Convivio: «la selva erronea di questa vita» (Conv. IV, XXIV 12). D’altra parte, nell’ambito letterario, la selva si ritrova all’entrata dell’Averno virgiliano (Aen. VI 131, 179, ecc.) e, per restare agli autori più cari a Dante, proprio lo smarrimento nella selva segna l’inizio della storia nel Tesoretto di Brunetto Latini, come di molti testi romanzi (Curtius, p. 446). Questa metafora abbraccia quindi secoli di tradizione (e osserviamo fin d’ora che tale sarà tutto il linguaggio della Commedia, sempre antichissimo, ma insieme straordinariamente nuovo). Essa significa qui, come quasi tutti hanno inteso, uno stato di peccato: «per silvestria loca… idest per operationes vitiosas» (Pietro). La selva è infatti oscura perché non vi splende il sole (v. 60), segno del bene e di Dio. La metafora luce-tenebre, di origine evangelica (Io. 1, 5), si ritroverà poi come motivo conduttore per tutta la Commedia. Dante vuole indicare nella selva, come preciserà a chiare lettere più oltre nel poema (cfr. Purg. XXIII 115-20 e XXX 130-2), un reale periodo di traviamento della sua vita, che è qui lasciato nell’indeterminato, proprio perché vuol essere nello stesso tempo figura del generale sbandamento dell’umanità.←
3. che: i più lo intendono come congiunzione causale (giacché, poiché), ma ci sembra più esatto l’altro valore proposto (dal Pagliaro e dal Pézard), di congiunzione modale («nella situazione di aver smarrito la via») che meglio corrisponde al significato indicato sopra del verbo mi ritrovai, che la congiunzione determina. Dante vuole infatti qui descrivere la situazione in cui viene all’improvviso a trovarsi: in mezzo a una selva oscura, smarrito il cammino. Per un simile uso del che, non perfettamente definibile, cfr. VIII 64 e 110. (Secondo questa interpretazione sintattica, diamo nel testo il che non accentato, a differenza dell’ed. Petrocchi, che lo intende come causale.)←
– la diritta via: più precisamente degli altri commentatori (che spiegano in generale: «la via della virtù»), Pietro di Dante ha penetrato il vero valore di questa espressione: l’origine dell’anima umana è il cielo, e l’anima naturalmente desidera tornare nella sua patria, cioè a Dio; altrimenti devia dalla strada diritta, cosa che l’uomo può fare, unico nella natura, grazie al libero arbitrio. Più rapidamente, ma analogamente, il Boccaccio: «egli è il vero che le vie son molte, ma tra tutte non è che una che a porto di salute ne meni e quella è esso Iddio». Tale senso profondo della «via diritta», che porta l’uomo al suo fine, cioè a Dio – metafora anch’essa ben antica e radicata nel Vangelo –, regge, come si vedrà, tutta l’invenzione del viaggio dantesco.←
– era smarrita: e non perduta, notano già gli antichi commentatori, perché poteva ancora ritrovarla: «questa via… si smarrisce… perché chi vuole la può ritrovare, mentre nella presente vita stiamo» (Boccaccio). Tuttavia in questo momento essa appare ben lontana. Questo terzo verso, con la sua precisa cadenza, mantiene e conclude la linea piana dei primi due. Il «sermo humilis», a tutti accessibile,...