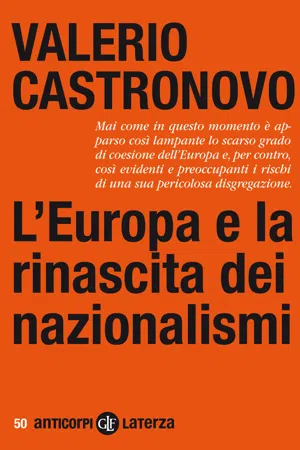I.
La condizionale francese
alla riunificazione tedesca
Dopo la caduta del Muro di Berlino, nel novembre 1989, e l’epilogo della Guerra fredda, sembrava che dovesse avverarsi una prospettiva suggestiva: la formazione degli «Stati Uniti d’Europa». Ossia, l’avvento di un’entità politica sovranazionale, che sarebbe giunta a comprendere man mano gran parte dei paesi del Vecchio Continente.
I primi a esserne convinti erano naturalmente i militanti del movimento federalista, di cui Altiero Spinelli (uno dei firmatari nel 1941 del famoso Manifesto di Ventotene) era stato sino alla sua scomparsa, nel 1986, il più strenuo e tenace animatore. Ma adesso anche numerosi osservatori da sempre scettici non consideravano più l’istituzione di una federazione europea una mèta utopica, vagheggiata e perseguita da alcune «anime belle» con vigorosa passione ideale.
In effetti, la Comunità europea, dopo aver costituito sino ad allora un’area di mercato imperniata sulla liberalizzazione degli scambi e un antemurale sotto l’ombrello della Nato al blocco sovietico dei paesi dell’Est, avrebbe potuto adesso puntare alla realizzazione di una compagine politica unitaria con propri tratti distintivi e una concreta autonomia nello scacchiere internazionale, non avendo più bisogno della protezione degli Stati Uniti allo stesso modo che in passato. Inoltre, nell’agenda di Bruxelles figuravano da tempo sia la creazione di uno «spazio giuridico europeo» sia l’adozione di una politica comune in materia di sicurezza.
Tuttavia, con la riunificazione tedesca, la Germania sarebbe tornata a essere il più grande e popoloso paese d’Europa, nel cuore del Vecchio Continente. S’era perciò riaffacciato un problema cruciale, di portata storica, denso di interrogativi per il futuro. Ci si chiedeva infatti, alla luce del passato e con l’apertura di nuovi orizzonti, quale ruolo avrebbe svolto la Germania. D’altronde, proprio in ragione delle tragiche vicende della seconda guerra mondiale scatenata dal Terzo Reich, e nell’intento di chiudere definitivamente un’epoca drammatica come quella della prima metà del Novecento, era stato concepito, dopo la fine del conflitto, il progetto di dare vita alla Comunità europea.
Erano pertanto più che comprensibili le forti preoccupazioni che assillavano il mondo politico e l’opinione pubblica francese, per la ricostituzione, al di là del Reno, di uno Stato tedesco territorialmente consistente ed economicamente vigoroso. Nella memoria collettiva i retaggi del passato non s’erano dissolti del tutto, ed era perciò inevitabile che ricomparissero gli spettri angosciosi del 1914 e del 1939.
Così pure era accaduto in Gran Bretagna, date le apprensioni suscitate dal ritorno in vita, al di là della Manica, di un megastato, con oltre ottanta milioni di abitanti e un considerevole potenziale industriale. Perciò il governo inglese aveva badato a riesumare dal cassetto una formula pregiudiziale, contemplata nel trattato di pace, come quella del «quattro più due», secondo cui la soluzione della «questione tedesca» non avrebbe potuto prescindere da una risoluzione unanime delle quattro potenze vincitrici dell’ultima guerra mondiale: al di là, perciò, di qualsiasi decisione fossero giunti a prendere in comune i dirigenti di Bonn e di Pankow.
Da parte loro, né l’Italia né il Belgio avevano visto di buon occhio una riunificazione d’emblée della Germania, in considerazione delle incognite che avrebbe potuto generare in un sistema di equilibri internazionali ancora fragile e incerto. Del resto, alla Casa Bianca non si era dell’avviso che Bonn dovesse premere sul pedale. C’era infatti in America anche chi temeva che la Germania potesse un giorno sottrarre a Washington l’influenza che esercitava sul Vecchio Continente. Perciò, il premier italiano Giulio Andreotti, essendosi consultato con il presidente americano George Bush, aveva ritenuto che Kohl non si sarebbe spinto a negoziare direttamente con Gorbačëv il «via libera» di Mosca a un ricongiungimento delle due Germanie, ma avrebbe sondato preventivamente i suoi partner europei.
Che Kohl avrebbe agito di conseguenza era stata dunque l’impressione emersa dopo quanto il Cancelliere aveva affermato, il 22 novembre, nel Parlamento di Strasburgo di fronte agli altri rappresentanti della Comunità europea, sorpresi e disorientati in seguito alla svolta determinata dall’improvviso smantellamento della frontiera che per quasi trent’anni aveva diviso le due sezioni dell’ex capitale tedesca. D’altro canto, al fine di risultare più convincente, Kohl aveva voluto che accanto a lui, durante il suo intervento, ci fosse il presidente francese François Mitterrand.
Senonché il Cancelliere, una volta assicuratosi un placet di Washington, concessogli dalla Casa Bianca purché s’impegnasse a portare la Germania riunificata nell’ambito della Nato, era riuscito nel settembre 1990 a ottenere rapidamente il consenso di Mosca all’incorporazione della Ddr nella Repubblica federale tedesca in cambio di un piano di massicci aiuti finanziari al governo sovietico da parte di Bonn. Aveva anche promesso, in realtà, che la Germania orientale non sarebbe stata inclusa nella Nato per non compromettere la distensione con l’Urss. Tanto che sarà successivamente Bush a dover sciogliere questo nodo nel giugno 1991, nel corso di un incontro a quattr’occhi con Gorbačëv.
Non era rimasto perciò alla Francia e alla Gran Bretagna che far valere il loro «diritto di riserva» sulla «Germania come tutta», previsto dal trattato di pace stilato a suo tempo, per cercare di alzare il prezzo del loro riconoscimento al ritorno sulla scena di uno Stato unitario tedesco. Non poteva infatti bastare a Parigi e a Londra che Kohl avesse provveduto a dichiarare, sulla scia di quanto aveva espresso a suo tempo Thomas Mann, che non voleva assolutamente «un’Europa tedesca» bensì «una Germania europea».
In questo complesso gioco delle parti Mitterrand aveva dalla sua più attitudini personali e carte diplomatiche per trattare direttamente con Kohl, rispetto a Margaret Thatcher, a cui interessava soprattutto il mantenimento dei tradizionali «rapporti speciali» fra Londra e Washington (anche perché dava per scontato che l’Europa sarebbe divenuta alla lunga «tedesca»). Del resto, per il presidente francese si trattava, se non voleva appunto che la Germania, una volta riunificata, alterasse i precedenti rapporti di forza con Parigi e finisse prima o poi per acquisire una posizione preminente, di legarla più strettamente, e per tempo, al carro delle istituzioni europee: senza che per questo si dovesse modificare la configurazione a carattere intergovernativo della Comunità.
In pratica, al punto in cui stavano le cose, era parso all’inquilino dell’Eliseo che l’unica soluzione realistica, e insieme avveduta e conveniente in relazione agli specifici interessi francesi, consistesse nella rinuncia di Bonn al suo tanto amato deutsche mark, a favore di una costituenda moneta unica europea, quale contropartita per la riunificazione tedesca.
D’altronde Mitterrand aveva ben presente come la Francia avesse agito in base a un calcolo sostanzialmente analogo, quando s’era trattato di creare nel 1951 la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, antesignana della Cee. A quel tempo l’intento precipuo di Parigi era di far sì che la Germania non tornasse ad avvalersi in pieno dei giacimenti minerari della Ruhr, di quella ricca parte della Renania Vestfalia la cui sorte definitiva era rimasta in bilico dopo la cessazione delle ostilità, in quanto Parigi aveva seguitato a chiedere, sino al dicembre 1948, di acquisirne metà del territorio. Di fatto, grazie alla creazione di un pool di produzione franco-tedesco, sotto l’egida di un’Alta Autorità comune (ossia di un’istituzione fondata «non sulle parole ma sugli interessi», come aveva detto il ministro degli Esteri Robert Schuman), le imprese francesi avevano potuto avere libero accesso all’utilizzo delle risorse locali, in condizioni paritetiche a quelle delle aziende tedesche.
La Francia s’era così assicurata una leva indispensabile non solo per lo sviluppo della propria siderurgia, ma anche per impedire che la Krupp e la Thyssen riconquistassero una posizione dominante su scala europea in un settore industriale strategico. Inoltre, Parigi avrebbe avuto modo di tenere sotto osservazione le modalità della ricostruzione economica tedesca, senza dare l’impressione di una sua esplicita ingerenza. Tanto meglio perciò, secondo il Quai d’Orsay, se altri paesi europei avessero partecipato a quest’iniziativa (come avvenne con l’adesione di Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo), in quanto sarebbe stata pur sempre la Francia a fare da regista, dato che la Gran Bretagna aveva deciso di autoescludersi da tale intesa.
A quarant’anni di distanza dall’istituzione della Ceca, che aveva avuto per protagonista Jean Monnet, Mitterrand aveva perciò provveduto a far valere soprattutto gli interessi nazionali francesi, in virtù di quello che era stato poi definito un «onesto baratto» fra lui e Kohl: ossia, l’abbandono obtorto collo, da parte della Germania, del suo «supermarco» in cambio del benestare di Parigi alla riunificazione tedesca. Da un lato, la Francia avrebbe potuto così registrare con sollievo il progressivo superamento di un sistema europeo di cambi fluttuanti, ovvero di un regime monetario ruotante intorno al marco e dominato dalla Bundesbank; dall’altro, avrebbe continuato in pratica ad esercitare una funzione politica preminente nel quadro della Comunità europea. Anche perché Londra, da quando s’era associata nel 1973 alla Cee, aveva sempre ritenuto che dovesse costituire soprattutto un’area di libero scambio e non aveva comunque alcuna intenzione di far ingresso in un’unione monetaria immolando a tal fine la propria sterlina.
Che Mitterrand intendesse ribadire fin da subito la leadership della Francia, lo aveva confermato l’iniziativa da lui concepita per il varo di una «Confederazione europea» che avrebbe dovuto includere alcuni paesi ex comunisti dell’Est e avere Parigi quale loro interlocutore primario. Questo progetto non trovò poi l’appoggio del presidente cecoslovacco Václav Havel, che Mitterrand aveva incontrato a Praga nel giugno 1991; mentre la Germania era stata pronta in quello stesso periodo a riconoscere per prima, e quindi ad avvantaggiarsene, i nuovi Stati sloveno e croato costituitisi in seguito all’incipiente disgregazione della Jugoslavia (che invece, secondo Bush, avrebbero dovuto entrare in un’area di specifica influenza dell’Italia nella penisola balcanica).
A ogni modo, si era convinti a Parigi di avere in mano assai più chances politiche e diplomatiche di qualsiasi altro partner per stabilire come e quando includere nella Ue alcuni paesi ex satelliti dell’Unione Sovietica. Senza peraltro che si dovesse modificare l’assetto di un’Europa ancorché più larga e articolata, in quanto restava fuori dalla visuale della classe dirigente francese la formazione di un’entità politica di carattere federale. Tantomeno Mitterrand era dell’opinione, dopo la firma nel febbraio 1992 del Trattato di Maastricht, che l’unificazione monetaria, da tenere a battesimo nel giro di un quinquennio, dovesse costituire il preludio dell’unificazione politica, fra i paesi che avrebbero adottato l’euro, attraverso una sequenza di tappe sempre più ravvicinate.
L’ipoteca di Parigi sulla presidenza della Bce
All’Eliseo si era comunque preoccupati del fatto che il governo tedesco, per rivalersi del sacrificio del marco sull’altare della riunificazione, intendesse dettare (tramite la Bundesbank) le regole del nuovo sistema monetario europeo. E che la Germania trovasse così il modo di acquisire un ruolo determinante.
È vero che il leader socialista francese era rimasto dello stesso avviso del generale de Gaulle: ossia, che l’economia avrebbe agito in conformità alle direttive della politica, come una sorta di fureria nei riguardi dello stato maggiore dell’esercito. Ed era certo comprensibile che i tedeschi fossero pervasi, per via di quanto era avvenuto in Germania negli anni Trenta, dall’ossessione di una reviviscenza dell’inflazione: tanto più di fronte al notevole dispendio di risorse che richiedevano necessariamente il risanamento e l’integrazione dei Länder tedesco-orientali.
Ma in Germania e altrove erano in molti a ritenere che l’unificazione monetaria fosse senz’altro il prologo dell’unificazione politica: anche perché non esisteva da nessuna parte del mondo una banca centrale a cui non corrispondesse un soggetto politico statuale. A ogni modo, mentre il governo tedesco aveva rassicurato quello francese che l’unificazione monetaria avrebbe dovuto avere come suo focus precipuo la stabilità dei prezzi, Mitterrand aveva continuato, per il resto, a non deflettere in alcun modo dall’indirizzo tradizionale dell’Eliseo. Perciò l’assetto della nuova Europa avrebbe dovuto restare imperniato su strutture intergovernative, rispetto a un’architettura di carattere federale.
Tantomeno s’era posto il problema di cambiare registro il suo successore, il neogaullista Jacques Chirac. Eletto di stretta misura nelle presidenziali del maggio 1995, era per di più considerato da sempre un euroscettico. Comunque, dovendo tenere a bada entro le mura domestiche una sinistra in fase d’ascesa e contraria alle misure finanziarie restrittive imposte dalla severa politica di bilancio contemplata dal Trattato di Maastricht, e allo stesso tempo non volendo lasciare del tutto mano libera alla Bundesbank nel percorso di marcia verso la moneta unica, il neo-presidente francese decise di porre sul tappeto a Bruxelles l’esigenza che si tenessero in debito conto determinate finalità di carattere sociale.
Sebbene questa richiesta di Parigi, pur accolta in linea di massima da Kohl, non avesse poi trovato concreto riscontro (per le remore opposte dal ministro delle Finanze tedesco Theo Weigel) in un apposito «Patto per la crescita e l’occupazione», da affiancare al «Patto di stabilità», Chirac non era rimasto a mani vuote. La sua sortita aveva fatto capire che la Francia non intendeva affatto disarmare. Del resto, anche Jacques Delors, che pure passava per uno strenuo fautore dell’integrazione politica, in un suo scritto del 1988 aveva affermato che la creazione dell’Europa era «un modo per recuperare lo spazio di manovra di cui ha bisogno una certa idea della Francia».
Sta di fatto che, al vertice di Dublino del dicembre 1996, i rappresentanti francesi, dando per sicuro che Parigi avrebbe centrato per prima (al pari di Berlino) i parametri di Maastricht, proposero che si sarebbe potuto consentire ai paesi membri in linea con tali clausole di sviluppare delle «cooperazioni rafforzate». Ma non già perché agissero da apripista verso il traguardo dell’unificazione politica, bensì in funzione di un percorso a due velocità, alla testa del quale procedessero la Francia e la Germania. E su questa ipotesi (che escludeva in pratica l’Italia, in quanto la sua ammissione alla moneta unica era ancora in forse) Chirac aveva trovato Kohl sostanzialmente d’accordo.
Senonché il presidente francese aveva le sue brave gatte da pelare, dato che, in vista delle elezioni politiche in agenda nella primavera del 1997, doveva vedersela con una ripresa in forze del Partito socialista di Lionel Jospin (che in effetti sarebbe riuscito ad avere la meglio). Inoltre, a Parigi, numerosi osservatori ritenevano che i ministri economici tedeschi si comportassero da «primi della classe». E ciò per la loro ostentata supponenza nei confronti degli orientamenti del governo Jospin (di cui facevano parte anche i comunisti di Robert Hue), che a Berlino venivano considerati il parto di un vetusto dirigismo, congenito peraltro a una tradizionale vocazione «étatiste» condivisa da larga parte della classe politica francese.
Si spiega pertanto come Chirac e Jospin volessero spiazzare la Bundesbank, puntando a insediare, quale primo presidente della Banca centrale europea, il governatore della Banca di Francia ed ex direttore del Tesoro Jean-Claude Trichet. Di qui la recisa opposizione di Berlino, schierata a favore della candidatura dell’olandese Wim Duisenberg. Ma se questi (già a capo della Banca dei Regolamenti Internazionali), sostenuto dal presidente della Bundesbank Hans Tietmeyer, era riuscito alla fine a spuntarla, era avvenuto in virtù di una soluzione propos...