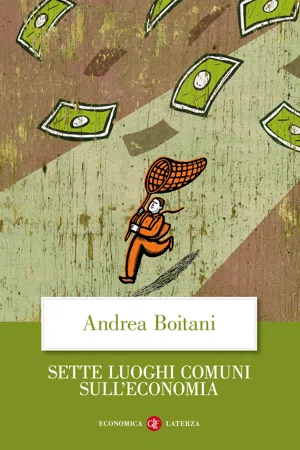1.
L’economia europea va male
perché c’è l’euro
Le faccende umane si trovano,
per unanime consenso, in uno stato deplorevole. Questa peraltro non è
una novità. Per quanto indietro si riesca
a guardare, esse sono state sempre
in uno stato deplorevole.
Carlo M. Cipolla
Un grande successo?
Il 2 giugno del 2008 – 105 giorni prima che, col collasso di Lehman Brothers, si aprisse ufficialmente la più lunga crisi economica europea dopo la seconda guerra mondiale – l’allora presidente della Commissione, José Manuel Barroso, celebrava il decimo anniversario della nascita della Banca centrale europea (BCE) con autentico entusiasmo. «La creazione dell’euro – affermava – è stata un evento straordinario». Molte Cassandre avevano previsto che l’unione monetaria sarebbe stata un fallimento. Invece, scriveva Barroso, «un decennio più tardi possiamo dichiarare orgogliosamente che l’euro è stato un grande successo».
E Barroso andava avanti elencando i benefici prodotti dall’euro, capace di inaugurare un decennio di stabilità nell’Unione Europea, di promuovere l’integrazione finanziaria ed economica e la crescita dei commerci tra i paesi membri, con tassi di inflazione e di interesse bassi come non mai da almeno una generazione. L’euro, secondo il Barroso del giugno 2008, aveva contribuito a proteggere le economie europee da una serie di shock economici globali. Proprio agli inizi, gli shock erano arrivati dallo scoppio, nel corso del 2000, della bolla delle «dot.com», cioè la caduta improvvisa dei prezzi azionari delle imprese operanti nel settore internet, prezzi che erano saliti enormemente nei due anni precedenti. Poi c’erano stati gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e gli aumenti dei prezzi del petrolio. Grazie alla stabilità garantita dall’euro, concludeva Barroso, nel primo decennio dell’Unione monetaria «è stato creato lo stupefacente numero di 16 milioni di posti di lavoro nell’Area euro. Cioè 2 milioni più che negli Stati Uniti e il triplo di quelli che erano stati creati nei dieci anni precedenti».
Alcuni puntini potrebbero essere messi sulle «i» del trionfalistico discorso di Barroso del 2008. Per esempio, è vero che negli USA il tasso di crescita era sceso dal 4% del 2000 allo 0,9% del 2001 (l’anno degli attacchi), e nell’Area euro (Eurozona, EZ) la caduta era stata dal 3,9% al 2%. In altri termini, il tasso di crescita negli USA era crollato del 75% mentre nell’EZ si era «solo» dimezzato. Negli anni successivi, però, la crescita americana era rimbalzata oltre il 3% nel 2004 e nel 2005, mentre quella dell’Eurozona era scesa nel 2002 e 2003 (0,9% e 0,6% rispettivamente), per poi stagnare intorno o sotto il 2% nel 2004 e 2005. Insomma, che lo shock delle Torri gemelle colpisse più gli Stati Uniti dell’Europa era abbastanza scontato, ma il fatto che negli anni successivi sembra averne risentito più l’Area euro degli USA non può essere taciuto.
Qualche altro «puntino sulle i» riguarda la qualità e la distribuzione tra paesi di quei 16 milioni di posti di lavoro creati. Che rappresentano un più 11,5% rispetto al 1999. Quasi 5,5 milioni di posti di lavoro (il 38% del totale) erano stati creati nella sola Spagna, il paese dell’EZ capace di crescere di più tra 1999 e 2007 (quasi del 4% medio all’anno, contro un 2,3% dell’Area). Non stupisce che in quel periodo la Spagna abbia visto crescere di più i posti di lavoro. Semmai stupisce la dimensione della crescita (34% in otto anni, oltre il 4% all’anno). Ma oggi sappiamo che la crescita spagnola di quegli anni era gonfiata da una eccezionale bolla immobiliare e che il settore delle costruzioni edili ha, ovunque, una elevata intensità di lavoro.
Un altro problema viene fuori se si guarda alla produttività. Ci sono tanti modi per misurarla; uno dei più utilizzati è il prodotto interno lordo (PIL) per occupato, cioè quanto produce ogni individuo che effettivamente lavora. Guardando a questa misura, scopriamo che la produttività è aumentata nell’Eurozona dell’8,6% tra il 1999 e il 2007, circa l’1% all’anno. In Spagna però solo dello 0,5% annuo. Insomma, la produttività è cresciuta molto poco nell’Area euro e in Spagna ancora di meno della media, proprio perché i posti di lavoro in quel paese sono stati creati soprattutto nell’edilizia. Nel complesso dell’Eurozona, poi, la produttività era cresciuta molto meno che negli USA, rimasti il motore dell’innovazione tecnologica e finanziaria.
Tirando le somme, l’euro sembra non sia stato decisivo per la crescita dell’economia del gruppo di paesi che lo avevano adottato come moneta comune, né in senso positivo né in senso negativo. Se l’Italia ha rallentato la crescita in concomitanza con l’ingresso nell’euro non è colpa dell’euro, visto che altri paesi non hanno rallentato o addirittura hanno accelerato. Si è detto che la produttività era cresciuta poco, meno che negli USA. Ma ci si dovrebbe chiedere cosa c’entri la moneta con la crescita della produttività. Sarebbe cresciuta di più se avessimo ancora utilizzato lire, franchi, marchi e pesetas?
Non c’è motivo, perché sono il progresso tecnico, i miglioramenti organizzativi e il peso crescente di settori ad elevata tecnologia a fare aumentare la produttività: nulla di tutto ciò dipende dal fatto che circoli una valuta comune o tante valute nazionali. In Italia, per esempio, l’industria informatica era sparita tra 1996 e 1997, con l’uscita dell’Olivetti dalla produzione di computer. Lo sgretolamento delle grandi imprese chimiche italiane era iniziato verso la metà degli anni Sessanta; nel 2002 erano quasi scomparse. Nell’elettronica di consumo, di cui gli italiani sono vigorosi acquirenti, le imprese italiane sono praticamente assenti già dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso. E la presenza di imprese italiane nell’hi-tech si era andata assottigliando negli anni Ottanta e Novanta. Quindi l’indebolimento dell’Italia nei settori a più alta intensità di tecnologia e di innovazione era avvenuto ben prima dell’adozione dell’euro. Nel primo decennio dell’euro, in Italia sono cresciuti sia il capitale che il lavoro (come normale), ma è l’efficienza con cui questi due fattori produttivi vengono utilizzati ad essere diminuita. Si è avuta e perpetuata, insomma, una cattiva allocazione del capitale e del lavoro tra i diversi possibili usi. Non si tratta di una conseguenza della scarsa flessibilità del mercato del lavoro (come pure alcuni hanno pensato e scritto), dal momento che tutti gli indicatori ci dicono che la flessibilità del lavoro è aumentata notevolmente nei primi anni Duemila, proprio mentre la produttività cominciava a stagnare o addirittura a diminuire. Approfondiremo la questione nel capitolo 4.
I veri meriti dell’euro
La moneta unica era stata fondata con gli obiettivi della bassa inflazione e dell’integrazione finanziaria. L’obiettivo di un’inflazione inferiore ma vicina al 2% se lo è dato la BCE, ma certo era stato iscritto nei geni dell’euro fin dalla definizione dei criteri di accesso alla moneta unica, con il Trattato di Maastricht. La stessa indipendenza della BCE – garantita dai trattati – è finalizzata a isolare la Banca centrale dalla «domanda di inflazione» che potrebbero esercitare i governi nazionali, interessati a ridurre il valore reale del loro debito pubblico. D’altra parte, una bassa inflazione era ritenuta necessaria a mantenere o aumentare la competitività delle merci europee sui mercati internazionali, senza indebolire la valuta (se il pane costa 1 euro in Eurolandia e 1 dollaro negli USA e il tasso di cambio è e rimane 1 dollaro per un euro, con un’inflazione annua del 2% in EZ e del 3% negli USA, il pane europeo dopo un anno costerà meno del pane americano).
Nel suo primo decennio di vita, l’Unione monetaria ha mantenuto la promessa di inflazione media intorno al 2%, con una significativa riduzione della sua variabilità tra i paesi aderenti. Tuttavia, va ricordato che l’inflazione nell’Eurozona si era già molto ridotta negli anni Novanta, anche per lo sforzo messo in campo dai paesi a più alta inflazione (come Italia, Portogallo, Spagna e Grecia) di soddisfare i criteri di Maastricht ed entrare nell’euro. E va detto anche che, tra 1999 e 2008, la stabilità dei prezzi non è stata una prerogativa dell’EZ. Solo pochi decimi di punto in più o in meno separavano l’inflazione dell’Eurozona da quella degli Stati Uniti o di altri paesi dell’Unione Europea che non avevano adottato l’euro. Dunque, non è scontato attribuire alla moneta unica il merito di aver ridotto l’inflazione. Anche perché, se guardiamo all’interno dell’Eurozona, fino al 2007 i vari paesi rivelano tassi di inflazione abbastanza differenziati, con i paesi del Nord (Germania, Austria, Olanda, Finlandia, ecc.) che hanno prezzi crescenti molto più lentamente rispetto ai paesi del Sud (Spagna, Portogallo, Grecia, in misura minore Italia) e ai paesi dell’Est (Slovacchia, Estonia, Slovenia). E, come diremo tra poco, questi divari hanno avuto conseguenze sulla competitività e sui conti con l’estero dei diversi paesi dell’Area.
Fino allo scoppio della crisi nel 2008, l’integrazione finanziaria è stata certamente il maggior successo seguito all’introduzione dell’euro. Uno degli obiettivi della creazione di una moneta unica in Europa era la mobilità delle risorse finanziarie, grazie alla scomparsa dei rischi connessi ai tassi di cambio tra le valute. Al venir meno di questo rischio si sarebbe dovuta accompagnare una drastica riduzione del differenziale (spread) tra i tassi di interesse pagati dalle imprese (e dagli Stati) in diversi paesi. Il che doveva garantire una corretta e uniforme trasmissione della politica monetaria comune in tutti i paesi dell’Area. In poche parole, la politica monetaria consiste nel fissare il tasso di interesse che la Banca centrale fa pagare alle banche di tutti i paesi per fornire loro la liquidità. Non si può parlare di vera politica monetaria comune se all’unico tasso di interesse di policy corrisponde un ventaglio ampio di tassi sui prestiti a medio e lungo termine nei vari paesi e se, a fronte di variazioni del tasso fissato dalla Banca centrale, le variazioni dei tassi di mercato nei vari paesi sono molto differenziate. È come se, a un colpo di acceleratore o di freno, le ruote di un’auto cambiassero velocità in modo diverso: l’auto sbanderebbe pericolosamente. Inoltre, grazie all’integrazione finanziaria, i capitali dovrebbero muoversi facilmente da dove ce n’è in eccesso (e quindi rendono poco) a dove mancano (e perciò rendono di più). Questi movimenti dovrebbero consentire una maggiore e più equilibrata crescita economica per tutti i paesi dell’Unione monetaria.
Il successo dell’integrazione finanziaria cominciò a manifestarsi subito, pochi giorni dopo l’avvio della moneta unica. Ci fu una rapida convergenza tra i tassi ai quali le banche dei diversi paesi si prestano soldi tra loro a breve o brevissimo termine (i cosiddetti tassi interbancari). Convergenza che si estese presto ai tassi sui titoli di Stato a scadenze più lunghe, tanto che si parlò dell’avvio di un mercato unico dei titoli di Stato, che pure continuavano ad essere emessi autonomamente dai diversi paesi. Oltre al rischio di cambio, sembrava essere destinato a scomparire anche il rischio di credito legato alla sostenibilità del debito pubblico dei diversi paesi. Tanto che si arrivò a dire, sempre più frequentemente, che i titoli pubblici erano da considerarsi tutti privi di rischio, indipendentemente dal paese che li aveva emessi. E ciò nonostante il livello del debito pubblico in rapporto al PIL (che misura la capacità di ripagare il debito di ogni singolo paese) fosse assai diverso in Germania, in Italia o in Grecia e a Cipro. Addirittura, nel 2007, i tassi sui titoli pubblici decennali erano compresi tra il minimo tedesco del 4,15% e il massimo cipriota del 4,47%: 30 punti base (ovvero lo 0,3%) di differenza. E poi c’era stato il progressivo sviluppo di un mercato europeo delle obbligazioni e l’integrazione di alcune «infrastrutture» che sorreggono i mercati azionari (acquisizione di Borsa italiana da parte del London Stock Exchange, sviluppo di Deutsche Bourse, ecc.). Tuttavia non c’era (e ancora non c’è) una vera «piazza» borsistica europea come è New York per gli Stati Uniti. E la più importante Borsa europea sta a Londra, la capitale di un paese fuori dall’Eurozona e che ha scelto anche di uscire dall’Unione.
Il settore bancario è rimasto molto più indietro nell’integrazione, soprattutto la sua parte squisitamente commerciale, più legata al territorio. Inoltre, le banche erano sottoposte a vigilanza nazionale (fino al 2014) e a condizionamenti politici anch’essi nazionali, quando non locali. In altri termini, all’unione monetaria non si era accompagnata l’unione bancaria, con conseguenze molto gravi, quando nel 2007-2008 scoppiò la crisi. Ma qualche passo era stato compiuto. Tra 1999 e 2008, vi sono state parecchie fusioni tra banche di diversa «nazionalità», specialmente nel Nord Europa e nel Benelux, e acquisizioni di banche estere (specie dell’Est Europa) da parte di grandi gruppi come l’italiano Unicredit e lo spagnolo Santander. Le banche tedesche e francesi avevano investito parecchi capitali nell’acquisto di titoli pubblici di altri paesi (Grecia, Spagna, Portogallo, Italia) che rendevano marginalmente di più di quelli nazionali e avevano prestato molti soldi alle banche dei paesi del Sud Europa che, a loro volta, finanziavano i loro boom immobiliari nazionali. E questo doveva diventare il tallone d’Achille dell’euro.
Gli squilibri dietro le quinte
Si è detto che uno dei più importanti «dividendi» dell’euro è stata la sostanziale riduzione dei tassi di interesse sia a breve che a lungo nei paesi che venivano da una storia di inflazione alta e di elevato debito pubblico. Per un paese come l’Italia, in cui il rapporto tra debito e PIL era sì sceso di oltre 20 punti dal 1994 al 2004, ma era comunque rimasto sopra al 100% (99,7% solo nel 2004 e 2007), si è trattato di un beneficio notevole. Il deficit primario di bilancio è la differenza tra entrate pubbliche e spese, una volta tolta la spesa per il pagamento degli interessi sul debito pubblico esistente. Per ottenere una riduzione del rapporto debito/PIL, a parità di altre condizioni, è necessario un avanzo primario di bilancio (ovvero l’opposto di un deficit) tanto più grande quanto più alto è il tasso di interesse che lo Stato deve pagare sul debito contratto. Con la riduzione dei tassi permessa dall’avvio dell’euro, gli avanzi primari necessari a proseguire sulla strada della riduzione del rapporto debito/PIL diventavano quindi più piccoli; il che voleva dire che sarebbe stato possibile ridurre la pressione fiscale e/o aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini tramite la spesa pubblica. Se ciò non è avvenuto o non è avvenuto a sufficienza, tra il 2002 e il 2007, non è certo colpa dell’euro o di Bruxelles. Un altro beneficio atteso dalla riduzione dei tassi era il rilancio della spesa per investimenti privati, per l’innovazione e, quindi, l’ammodernamento dell’industria e dei servizi, soprattutto nei paesi del Sud Europa, Italia compresa (più bassi sono i tassi e minore è il costo da sostenere per finanziare gli investimenti). In effetti, un aumento della spesa per investimenti c’è stata fino al 2007, ma proprio nei paesi del Sud Europa ha preso principalmente la strada degli investimenti immobiliari, dove i tassi bassi alimentavano la domanda e questa faceva crescere i valori, il che attirava nuovi investimenti, in una spirale molto simile a una tipica «bolla». I soldi vanno dove rendono di più e in quegli anni, nel Sud Europa e in Irlanda, il mattone rendeva molto bene.
L’accresciuta integrazione finanziaria ha consentito, nel primo decennio dell’euro, di finanziare i crescenti deficit di partite correnti dei paesi del Sud Europa. Quello delle partite correnti è un bilancio che registra importazioni ed esportazioni di beni e servizi e movimenti di reddito come i trasferimenti dei migranti. Tutte le somme che entrano nel paese (per esportazioni e redditi dall’estero) compaiono nel conto col segno più; quelle che escono (per importazioni e trasferimenti all’estero) compaiono col segno meno. Se le somme che escono sono maggiori di quelle che entrano c’è un deficit. E i deficit dei paesi del Sud EZ si ampliarono notevolmente proprio dopo l’avvio dell’euro e fino al 2008. I paesi del Nord dell’Eurozona – qualche volta chiamati core, a indicare che sono il nucleo, il nocciolo duro dell’Area – avevano, tutti insieme, un surplus di partite correnti di 14,5 miliardi nel 2000, arrivato a 311 miliardi nel 2007 (236 nel 2008). I paesi del Sud – che nel gergo comune includono l’Irlanda e per i quali è invalso l’uso dell’acronimo PIIGS – nel frattempo passavano da un passivo complessivo di 51 miliardi nel 2000 a uno di 317 miliardi nel 2008.
Ogni deficit di parte corrente significa che il paese spende (per consumi, per investimenti, per opere e servizi pubblici) più di quanto produca all’interno. Questo eccesso della spesa sulle risorse disponibili all’interno di un paese è possibile solo se quel che manca arriva dall’estero. A fornire le risorse mancanti non possono che essere i paesi che spendono meno rispetto alle risorse che producono, quindi i paesi con surplus di partite correnti. E così è successo in Europa e, in particolare, nell’Eurozona. I risparmi dei paesi del Nord, in surplus di partite correnti, hanno finanziato le spese «in eccesso» dei paesi del Sud. Gli squilibri di partite correnti lasciano anche una pesante eredità, dal momento che ad ogni passivo corrisponde un aumento dell’indebitamento finanziario v...