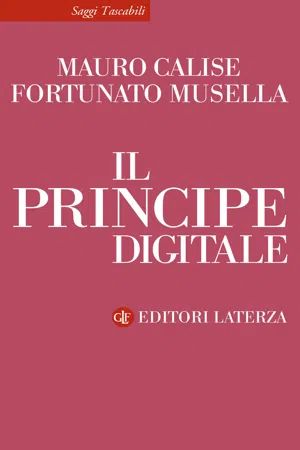
eBook - ePub
Il Principe digitale
Mauro Calise, Fortunato Musella
This is a test
- 192 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Il Principe digitale
Mauro Calise, Fortunato Musella
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Con l'avvento dei social media, la politica è entrata in una nuova era. Gli attori tradizionali – partiti, sindacati, élites – sono rimpiazzati da protagonisti e reti di relazioni inediti e imprevedibili. Un cambiamento che avviene con una velocità senza precedenti. Al centro del processo, la connettività della rete che sostituisce antichi legami e gerarchie. Può la politica riprendere il comando e il destino di questa sfida? Per riuscirvi, il Principe digitale dovrà avere tre teste. Quella carismatica del leader. Quella gramsciana del partito nuovo. E quella del popolo sovrano, cui spetta – in prima e ultima istanza – lo scettro.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Il Principe digitale an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Il Principe digitale by Mauro Calise, Fortunato Musella in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economia & Politica economica. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
EconomiaSubtopic
Politica economica1.
L’opinione privatizzata
Sono il nuovo oro nero, ambìto da imprese e governi di tutto il mondo. Come in passato il petrolio. Tutti alla rincorsa dei dati digitali, le tracce che lasciamo in una realtà virtuale dove sino a poco tempo fa ci sembrava di “andare”, e che invece ha inghiottito le nostre vite. Basti pensare che quindici anni fa ogni persona in rete era in possesso di un solo device, nel 2010 la media sale a uno e mezzo, nel 2020 arriveremo a 7 device a testa, in un ambiente iperconnesso che segnala una assoluta novità rispetto al passato1. Trascorriamo online sei ore al giorno, di cui almeno due su una piattaforma di social media2. In un solo minuto della rete sono totalizzate 4,2 milioni di visualizzazioni su YouTube, 3,7 milioni di ricerche su Google, 38 milioni di messaggi via WhatsApp, 187 milioni di email inviate e oltre 481.000 nuovi tweet pubblicati3. Che si tratti di leggere un libro o prenotare un albergo, esprimere emozioni o ascoltare musica, non si scappa a un sistema che traccia, e archivia perennemente, azioni, abitudini, preferenze.
Le possibilità di sfruttare questa enorme mole di dati sono sterminate. E danno immediati vantaggi competitivi a chi se ne appropria. L’inedita capacità di calcolo sui dati permette di elaborare forme automatizzate di comunicazione con amplissimi pubblici. Le più immediate applicazioni riguardano il mercato dei beni. Così Amazon, piattaforma che detiene il primato del commercio mondiale elettronico, utilizza informazioni dettagliate per dare consigli pubblicitari basati sui precedenti acquisti. Facebook attraverso la più grande base dati del pianeta «riesce a vendere miliardi di inserzioni pubblicitarie al giorno, ciascuna ritagliata su misura del profilo socio-demografico e comportamentale dell’utente»4. Mentre cresce in maniera vertiginosa il numero di imprese al mondo che fanno dei dati una componente essenziale del loro business. Senza considerare quale uso si possa fare delle tecnologie della localizzazione, per ragioni che vanno dalla sicurezza all’e-commerce: molti produttori conservano con dettagliata minuziosità i dati di ogni singolo possessore di smartphone, e potrebbero ricostruire anche gli spostamenti che questi non ricorda più.
È però quando si passa dal mercato dei beni a quello delle idee che la questione dei big data va al cuore della nostra vita associata, rendendo il possesso dei dati la risorsa principale per capire e misurare preferenze passate, e influenzare orientamenti futuri dei cittadini. L’uso dei big data impatta sull’opinione pubblica, stravolgendone le caratteristiche originarie, così strettamente intrecciate con l’ascesa dei regimi liberaldemocratici. A partire dal suo elemento più prezioso: la libertà e autonomia di giudizio. Un fenomeno segnalato già agli esordi del web, ma sul quale l’avvento dei social media ha acceso prepotentemente i riflettori, minacciando di erodere alle radici il ruolo dell’opinione pubblica come principale parametro – e baluardo – della democrazia.
La nascita della sfera pubblica è scandita da requisiti strutturali, dalla diffusione della stampa alla proliferazione dei luoghi di discussione sui temi più rilevanti, ma soprattutto dalla rivendicazione dell’emergente classe borghese del suo ruolo e controllo sulle decisioni che la riguardano. Nell’affresco di Jürgen Habermas, i cittadini si fanno pubblico quando acquistano adeguate capacità critiche per informarsi e assumere scelte consapevoli e razionali sui destini della collettività. Senza questi passaggi, che assegnano al cittadino la capacità di autodeterminarsi nell’interazione con gli altri, di democrazia non si può iniziare a parlare. Per una lunga fase storica, lo sviluppo dell’opinione pubblica è legato a tre fattori, e alla loro sinergia: l’esistenza di libertà civili efficacemente tutelate dallo Stato, l’ampia diffusione di organi di stampa pluralisti, un adeguato livello di alfabetizzazione che consenta a fasce consistenti della popolazione di partecipare attivamente al dibattito pubblico.
Durante tutto l’Ottocento, la conquista di questi tre traguardi e il loro consolidamento segna il faticoso affacciarsi dei diversi paesi sulla scena democratica. In genere, il raggiungimento dei primi due viene considerato sufficiente per entrare a far parte del club dei regimi liberali. Ma è solo quando anche il terzo indicatore coinvolge una percentuale ragguardevole degli aventi diritto al voto che si può parlare di una opinione pubblica di massa. E, di conseguenza, di una più stretta integrazione tra opinioni consapevoli e funzionamento della democrazia.
Tuttavia, anche quando le statistiche ufficiali mostrano un notevole restringimento dell’analfabetismo non consegue immediatamente la crescita dei comportamenti – e dell’elettorato – di opinione. Anzi, l’analisi delle motivazioni di voto mostrerà che, a dispetto delle più o meno parziali informazioni che un cittadino può raccogliere sul funzionamento della vita pubblica, queste non saranno trasformate necessariamente in una propensione a scegliere questo o quel partito, o leader. Le sue scelte possono essere orientate da altre spinte, che si tratti della propria esperienza di socializzazione alla politica – familiare, subculturale, partitica – o di attaccamento fideistico a qualche personalità carismatica. Per non parlare, in moltissime occasioni, della semplice tutela di un proprio interesse privato senza prendere minimamente in considerazione le ricadute sul bene collettivo. Un fenomeno cui il nostro paese non manca di contribuire, come lascia intendere il vasto ricorso al voto di preferenza a livello locale e regionale.
Alla luce di questi criteri, il peso dell’opinione pubblica, anche in quei regimi politici che sul piano formale corrispondono ai principali requisiti per un suo pieno sviluppo, risulta molto più ristretto di quanto una visione razionale della democrazia postulerebbe.
Ma accanto a questi ostacoli sistemici di ordine politico, c’è un altro fattore che, dalla seconda metà del Novecento, mette in crisi la centralità dell’opinione pubblica tradizionale. Mutuando il proprio ruolo e la propria influenza dall’ambiente – e dalla logica – del mercato in cui muovono i primi passi, i sondaggi d’opinione si affermano come uno strumento alternativo di misurazione degli orientamenti dei cittadini. I sondaggi riescono, infatti, a pesare, con discreta attendibilità quantitativa, le opinioni e i loro andamenti nel corso del tempo. Superando le strozzature dei circuiti inevitabilmente elitari dei lettori della carta stampata e delle nascenti trasmissioni radiotelevisive, e ponendosi come interpreti statisticamente affidabili dell’universalità dei cittadini.
Proprio questa loro pretesa di esaustività espone però, fin dagli esordi, i sondaggi alla critica sulla validità delle opinioni che raccoglievano. Quanto veramente ne sapevano, i cittadini intervistati, delle questioni su cui si esprimevano? Restano celebri le sprezzanti osservazioni di Lazarsfeld, uno dei padri della sociologia americana: «Dopo avere esaminato in dettaglio i dati su come gli individui percepiscono in modo sbagliato la realtà politica, o rispondono a influenze sociali irrilevanti, uno si chiede come una democrazia possa mai risolvere i suoi problemi politici»5.
Un quadro che, nel tempo, non sarebbe molto cambiato. I sondaggi elettorali hanno segnalato negli ultimi anni altissime percentuali di «last-minute voters», indecisi pronti a cambiare idea all’ultimo momento. Con un livello molto superficiale di informazioni e motivazione, che la ricerca mette chiaramente in evidenza. Molto ampi, inoltre, erano – e restano – i rischi che i sondaggi, in sede di somministrazione come di pubblicazione, influenzino gli orientamenti dei cittadini. Si consideri il noto effetto bandwagon, sul quale ha tanto fatto affidamento l’ascesa di Berlusconi nel nostro paese: basta annunciare, sulla scorta di sondaggi più o meno verificabili, un candidato come vincitore per convincere gli elettori più tiepidi. Con i sondaggi, l’opinione pubblica diventa più facilmente influenzabile.
Sarebbe sbagliato, però, attribuire ai sondaggi un ruolo sistematico di manipolazione o, addirittura, contraffazione. A parte casi isolati, nella maggior parte delle democrazie i rilevamenti di opinione vengono sottoposti a rigide regolamentazioni e ad obblighi di trasparenza. Oltre che al deterrente più importante, la concorrenza di altri istituti che possono facilmente smentire risultati clamorosamente inattendibili. Il limite principale dei sondaggi non riguarda lo strumento, ma il fenomeno che mette a nudo: l’impietosa fotografia di quanto sia problematico raggiungere, per la maggioranza dei cittadini, un livello informativo adeguato ad affrontare soluzioni complesse, come quelle che quotidianamente intasano l’agenda di governo, a livello locale, nazionale, internazionale. Questo iato – questa contraddizione – diventa ancora più eclatante con l’avvento dei circuiti di informazione, comunicazione e interazione del web.
La rilevazione delle opinioni dei cittadini emerge direttamente dalla rete, dall’aggregazione di micro-atti privati misurati da complessi sistemi di calcolo automatizzato, a partire da un’immensa mole di tracce che essi lasciano online nel corso delle loro attività. Frammenti di esistenza che acquistano coerenza nei trend evidenziati dagli «analytics», dettagliate statistiche in grado di raccogliere ogni respiro digitale del cittadino-utente. Con un’aggravante, anzi, due, che sono i punti deboli – e oscuri – dell’opinione di rete.
Il primo è l’eterodirezione. In nessuna altra epoca storica il cittadino ha avuto più informazioni e strumenti di conoscenza a disposizione. Gli internauti mostrano «appetito onnivoro» per notizie politiche diffuse attraverso canali multimediali, con accresciute possibilità anche di creare nuovi contenuti6. Tuttavia la catena intellettuale che vede il cittadino autorità suprema nel connettere dati, informazioni e conoscenza rischia di venire meno per la progressiva incapacità di gestire la mole di dati della nuova infosfera. Sono gli algoritmi elettronici a selezionare e diffondere i contenuti online, attraverso una serie di regole e procedure spesso opache e mutevoli nel corso del tempo, agendo da formidabili costruttori di una «agenda setting automatizzata e applicata alla quasi totalità della nostra vita digitale»7.
Di fatto, le procedure degli algoritmi finiscono per ridurre drasticamente la nostra capacità di capire, e orientare, «il mondo sociale che la Silicon Valley sta creando»8. Ciò che in rete è visibile o non visibile dipende da chi definisce le regole del web. E ciò che non è visibile, nel nuovo mondo digitale, rischia di non esistere. L’intima logica dei search della principale, e tendenzialmente u...
Table of contents
- Introduzione. La personalizzazione delle masse
- Parte prima. L’ecosistema digitale
- 1. L’opinione privatizzata
- 2. La «platform society»
- 3. Giochi di guerra
- 4. Gutenberg 2.0
- Parte seconda. Restituire lo scettro al cittadino
- 5. Democrazia virtuale
- 6. «Social campaigning»
- 7. Partiti tra exit e voice (populi)
- 8. L’autocrazia dei selfie
- Parte terza. Il nuovo principe
- 9. «The Machiavellian moment»
- 10. Personal leader
- 11. Il partito cybercratico
- 12. L’école digitale
- Conclusioni. I mille corpi del re
- Approfondimenti bibliografici
- Gli autori
Citation styles for Il Principe digitale
APA 6 Citation
Calise, M., & Musella, F. (2019). Il Principe digitale ([edition unavailable]). Editori Laterza. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3517263/il-principe-digitale-pdf (Original work published 2019)
Chicago Citation
Calise, Mauro, and Fortunato Musella. (2019) 2019. Il Principe Digitale. [Edition unavailable]. Editori Laterza. https://www.perlego.com/book/3517263/il-principe-digitale-pdf.
Harvard Citation
Calise, M. and Musella, F. (2019) Il Principe digitale. [edition unavailable]. Editori Laterza. Available at: https://www.perlego.com/book/3517263/il-principe-digitale-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Calise, Mauro, and Fortunato Musella. Il Principe Digitale. [edition unavailable]. Editori Laterza, 2019. Web. 15 Oct. 2022.