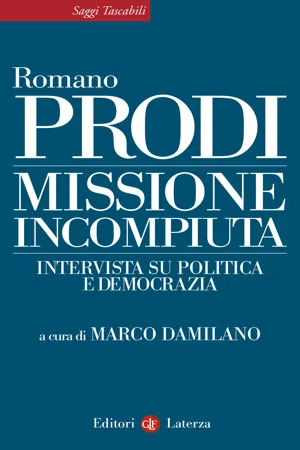1. QUANDO CI CREDEVAMO
Lei ha vissuto la ricostruzione, gli anni dello sviluppo italiano con il miracolo economico, gli anni della crisi e del rilancio, fino al periodo di declino e di recessione. Come riassume questo percorso?
Sono nato nel 1939 e quindi la mia età della ragione (se mai vi è stata) coincide con la stagione repubblicana. Nella mia felice infanzia e poi adolescenza mi occupavo ovviamente di quello che interessa ai bambini e agli adolescenti. Alla fine del liceo, a Reggio Emilia, e soprattutto negli ultimi anni dell’università, a Milano, ho cominciato ad interessarmi sempre più intensamente di politica e di economia. Erano gli anni della grande speranza. Alla fine degli anni Cinquanta, quando ho frequentato l’Università Cattolica, Milano sembrava imitare New York: tutto era possibile. Il Paese, tra tensioni e scontri, cambiava per il meglio: tutto era in crescita, sia nelle aree tradizionali che nei settori nuovi. Si producevano sempre più automobili e sempre più elettrodomestici ma, soprattutto, non vi era paura del nuovo. C’era la certezza della speranza, nessun dubbio sulla crescita, e un diffuso ottimismo sull’ascesa delle categorie più modeste, dagli operai ai contadini, nonostante le tensioni sociali, talvolta anche aspre. Una scommessa sul futuro che non era limitata alla borghesia. Anzi, l’ascensore sociale sembrava poter funzionare per tutti. È questa la grande diversità con l’oggi. Si è trattato di un periodo unico della storia italiana. Le precedenti fasi di espansione, per esempio il periodo giolittiano, erano limitate ad alcune zone e ad alcuni settori e non coinvolgevano l’intera società. Lo sviluppo precedente riguardava solo una minoranza del Paese. Si trattava di un’espansione di élite o comunque di categorie limitate. Quello che è avvenuto negli anni Cinquanta-Sessanta è stato invece un aggancio al mondo. Una modernità diffusa. Una grande apertura non solo intellettuale, ma anche nella vita di ogni giorno. Era tutto in movimento e, soprattutto, nessuno pensava che lo sviluppo potesse interrompersi.
È stata quella la stagione in cui l’Italia ha avuto la possibilità di affrontare alcuni nodi mai sciolti, l’opportunità di raddrizzare il legno storto, se non dell’umanità – come diceva Isaiah Berlin – almeno di alcuni mali storici del Paese?
Quel momento magico è stato giustamente chiamato “miracolo economico”. Quando, nel 1964, entrò nel nostro vocabolario la parola “congiuntura”, dal tandem Carli-Colombo scoprimmo che non era scritto in cielo che dovessimo sempre procedere con uno sviluppo lineare e infinito. Tuttavia anche quando lo sviluppo si interruppe, vi era la convinzione che il cammino sarebbe presto ripreso, perché nel frattempo si era risvegliata tutta l’Europa. L’Italia stava cambiando, sia pure con grandi sacrifici, anche per effetto dell’influenza dell’Europa. Uno dei miei ricordi più vivi dei tempi dell’Università Cattolica di Milano era la folla di emigranti che venivano assistiti nella vicina caserma di polizia in piazza Sant’Ambrogio. Ogni giorno passavano centinaia di lavoratori che andavano all’estero, verso la Francia o la Germania. Partivano, ma con la speranza, in molti casi realizzata, di tornare rapidamente. E anche io ci credevo perché ero sotto l’influenza di un ricordo della mia adolescenza a Reggio Emilia, quando chiusero le Officine Reggiane che, durante la guerra, erano arrivate a impiegare 12 mila addetti. Fu un momento di disperazione, in una città di 110 mila abitanti ogni famiglia aveva uno o più lavoratori in quella grande fabbrica. Molti papà dei miei compagni di scuola partirono allora per andare all’estero. Molti verso Saint-Étienne, dove le locali acciaierie e officine meccaniche pesanti avevano bisogno di mano d’opera ben addestrata. Partirono tutti assieme ma, dopo un anno, cominciarono a tornare e tornarono quasi tutti perché, nel frattempo, nelle città emiliane era cominciata un’epoca nuova. Nel mio quartiere c’era uno scantinato che chiamavano “la Rettifica” dove andavo a curiosare: si mettevano a posto gli ingranaggi, si “rettificavano” i macchinari vecchi e poi, quasi senza rendersene conto, si cominciavano a fare cose nuove. Si affrontavano con serenità anche le emergenze più drammatiche, perché tutto sembrava a portata di mano.
Eravamo la Cina dell’Europa?
Come tasso di crescita sicuramente. Ma anche come autostima. I discorsi dei ragazzi cinesi, studenti alla Business School di Shanghai, sono identici ai nostri di allora. Sentono di poter fare tutto, rifiutano le lettere con le proposte di lavoro perché hanno la certezza che ne arriveranno di migliori. Uno mi ha spiegato che, nella sua vita, ha programmato di essere il primo al mondo nella costruzione di vetture davvero speciali: ambulanze con unità cardiache, macchine per lo spegnimento di incendi provocati da prodotti chimici particolari, ecc. Stravagante? Forse sì, ma i miei coetanei di allora non avevano sogni molto diversi da quelli dei giovani cinesi di oggi.
L’innovazione non faceva paura?
No, la grande differenza con il presente è che allora l’innovazione tecnologica portava lavoro. Oggi, almeno qui da noi, il progresso tecnologico sta diventando simbolo di distruzione di lavoro.
Le due leve dello sviluppo negli anni Cinquanta sono state la programmazione economica e l’impresa pubblica, legate a personaggi come Ezio Vanoni e Pasquale Saraceno. C’era un disegno illuministico guidato dall’alto?
No, non c’era una classe dirigente che prevedeva e dirigeva il cambiamento economico. La politica non guidava lo sviluppo, ma lo seguiva con grande attenzione concentrandosi soprattutto nell’offrire un rapporto con i riferimenti ideologici che stavano alla base dei grandi partiti popolari. Senza dubbio c’era fiducia nella programmazione come una necessità razionale, ma, in fondo, si pensava che le cose si sarebbero messe a posto da sole, soprattutto in periferia. Quella stagione mi ha segnato in profondità perché mi ha trasmesso un senso di ottimismo, mi ha impresso nella mente il messaggio (non vero ma utile) che le crisi sono una parentesi nel cammino dello sviluppo. È certo una convinzione anti-storica. Lo studio più approfondito della storia ti fa capire che il progresso non è mai un processo lineare: ci sono gli strappi, le rotture, le cadute, gli alti e i bassi. Però l’ottimismo è una forza in sé: è importante avere fiducia. Crederci.
E noi italiani, quando abbiamo smesso di crederci?
Un momento preciso non c’è. È successo progressivamente. Anche il ’68 non è stato vissuto, nemmeno dai giovani, come una rottura definitiva del processo di sviluppo ma come la necessità di un suo cambiamento. Le difficoltà sono arrivate dopo. Le speranze di cambiamento sono state via via soffocate, ma con un processo lento che ha costruito un sentimento di rassegnazione. Al termine di questa trasformazione la complessità del mondo e lo sviluppo non sono più apparsi come lineari. Difficile trovare le ragioni per cui tutto ciò è avvenuto. Non è un caso che gli anni del miracolo economico abbiano una precisa datazione e quelli della successiva perdita di vigore non abbiano un inizio e neppure una definizione condivisi.
Lei come li definirebbe?
Gli anni dell’assestamento, dell’adattamento, e poi della rassegnazione. È stato un rassegnarsi progressivo alla perdita di energia, al rallentamento, interrotto soltanto dalle illusioni degli anni Ottanta, quando i grandi magazine internazionali dedicavano le copertine ai capitani di ventura come i nuovi conquistatori. Gli imprenditori sono apparsi come gli eroi di un nuovo rinascimento, fondato solo sull’illusione e su una descrizione falsata di quanto stava avvenendo nel mondo. L’ascesa dell’economia e della società italiana negli anni Cinquanta-Sessanta è stata lineare e intensa, l’assestamento e poi il passaggio verso la stagnazione si è invece compiuto tra alti e bassi. Quello che è più grave è che per costruire una di queste stagioni di ascesa momentanea, negli anni Ottanta, è stato devastato il bilancio dello Stato. È stato lanciato all’opinione pubblica il messaggio che l’inflazione fosse un unguento miracoloso e che il deficit potesse correre all’infinito.
Non ci sono mai stati periodi di ripresa?
Certamente un momento di riconquista delle speranze collettive è stato l’ingresso nell’euro negli anni Novanta: dopo un lungo periodo di difficoltà tornava l’idea, giusta, che se si riaffermava una speranza collettiva, potevamo stare al passo degli altri paesi europei. La crisi economica invece ci ha di nuovo differenziato, perché il debito pubblico ha reso insopportabile il peso per lo Stato. Le cause di questo progressivo scollamento sono infinite. La maggiore, per me, sta nell’arretratezza del nostro sistema scolastico, insieme alla tradizionale debolezza della cultura politica. È a scuola che abbiamo perso la gara della modernità e nelle scelte della classe dirigente la possibilità di porvi rimedio.
Si riferisce anche alla sua formazione? La sua famiglia, i nove fratelli, la tribù sterminata di figli e nipoti, è una storia tipicamente italiana: nonni contadini, il padre Mario l’unico ad aver terminato gli studi con la laurea in ingegneria, voi figli tutti laureati e professori universitari. Lei ha studiato a Milano, alla Cattolica, che negli anni Cinquanta ha costruito la classe dirigente del Paese.
Non solo l’università, ma soprattutto il collegio si fondava su accurati processi di selezione. Occorrevano medie elevate, i posti erano pochi, le élites si formavano nello studio ma anche attraverso un dibattito continuo e intenso. E si attingeva veramente da tutta l’Italia. Si trovavano a studiare ragazzi spesso provenienti da famiglie realmente povere, sia settentrionali che meridionali, con un assistente spirituale che era avanti di secoli, con un senso di libertà, modernità e pluralismo unico per quei tempi, e anche per quelli successivi.
C’era la politica?
C’era una naturale tendenza prevalente verso la Democrazia cristiana, ma c’erano anche molte eccezioni, e soprattutto un fortissimo dibattito interno tra le diverse correnti culturali. Molti di noi facevano il tifo per il disegno del centrosinistra. Lo vedevamo come il volto politico dello sviluppo economico. L’allargamento dei protagonisti politici nel campo da gioco che doveva accompagnare la crescita del Paese.
E sul piano religioso?
C’era la proposta di un cattolicesimo libero, non conservatore. I giovani professori, Siro Lombardini, il giovanissimo assistente Beniamino Andreatta, erano il segno di un cambiamento di cultura economica che correva in parallelo a quello religioso. L’orizzonte guardava molto all’estero: Giuseppe Lazzati, monsignor Carlo Colombo, erano tutti molto legati intellettualmente al cattolicesimo francese. Leggevamo il teologo tedesco Romano Guardini, ma il punto di riferimento era la rivista “Esprit”: Jacques Maritain, Emmanuel Mounier e poi il domenicano Marie-Dominique Chenu. Il cattolicesimo francese era fecondo, combattivo, non ancora in crisi.
Nasce da questa radice la definizione di “cattolico adulto” che lei utilizzò quando, nel 2005, rifiutò di seguire le indicazioni di voto della Cei sulla fecondazione assistita? Per far fallire i referendum (come poi avvenne) i vescovi fecero campagna per l’astensione, lei invece andò a votare...
Fu considerata una definizione esplosiva, invece è stata la logica conseguenza della formazione ricevuta all’Università Cattolica, un’espressione assolutamente naturale del credente impegnato nel mondo. Quella frase mi è costata molto, anche se oggi è ritornata ad assumere il suo significato semplice e originario della necessità di interpellare sempre e a fondo la propria coscienza. Più ci penso, più sono contento di averla detta! Ma a partire dagli anni Novanta non c’era disponibilità all’ascolto: il mondo cattolico sembrava modellato su un pensiero unico. Non c’era più dibattito: tutto arrivava dall’alto. Per anni nelle riunioni della Conferenza episcopale italiana non ci sono stati confronti o discussioni. In quel contesto la mia è apparsa come una scelta di ribellione, ma era quello che mi ero sempre sentito predicare sulla necessità di essere responsabili delle proprie azioni e di assumersi il rischio delle scelte personali. Mi sono definito “cattolico adulto” in modo spontaneo, non pensato; per me era del tutto normale e quasi ovvio, il riflesso della mia educazione nella quale avevo cercato di proseguire anche dopo il mio ritorno, una volta laureato, a Reggio Emilia, durante gli anni del Concilio. Era un discorso addirittura banale, una frase pronunciata anche da Pio XII e da padre Agostino Gemelli, non certo percorsi da tentazioni rivoluzionarie. Tutti eravamo stati educati al primato della coscienza.
Da quando conosce Camillo Ruini, anche lui reggiano?
Beh, da sempre... fin da quando sarebbe stato certamente d’accordo sull’espressione “cattolico adulto”.
Nel 1969 è stato don Ruini a leggere l’omelia davanti a lei e a sua moglie Flavia, al vostro matrimonio.
Sì, ma lo conoscevo almeno dal 1964, da quando tornai a Reggio da Londra. Avevamo animato insieme un circolo chiamato “Leonardo”, un’associazione avanzata, molto aperta alla città, con una grande attenzione sia alla politica locale che ai temi ecclesiali. Chiamammo a Reggio tutti i teologi del Concilio. Una volta io e Flavia andammo a prendere il grande teologo domenicano padre Chenu al Convento di San Domenico di Bologna con una Fiat 850. Mi vengono ancora i brividi a ricordarlo: la macchina si ruppe, Flavia e il grande teologo fecero l’autostop, io rimasi in mezzo alla strada ad aspettare i soccorsi. Era un altro mondo. Tra me e don Ruini c’era un rapporto personale molto forte. Ha parlato al nostro matrimonio, ha battezzato i nostri figli e tutti gli anni a Natale passava a salutare l’intera tribù.
Com’è possibile, allora, una rottura così violenta dopo l’ingresso in politica e la nascita dell’Ulivo?
Non ho mai parlato di questo anche perché non vi è mai stato uno scontro personale ma, piuttosto, una divergenza crescente sulla interpretazione della società italiana. Alla radice della sua visione politica vi era non solo un profondo e radicale anti-comunismo, ma anche l’idea che la Chiesa abbia una sostanziale necessità...